Molto caro al commissario Montalbano è un ulivo saraceno dai rami contorti, che assume un carattere fortemente simbolico.
Questo albero costituisce infatti un esplicito elemento pirandelliano: Camilleri affermava di essersi ricollegato alle ultime parole che Pirandello rivolse a suo figlio Stefano, a proposito dell’opera incompiuta I giganti della montagna: “C’è in mezzo al palcoscenico un ulivo saraceno col quale ho risolto tutto” (cfr. G. Bonina, Il carico da undici, Le carte di Andrea Camilleri, Barbera editore, Siena 2007, p. 293).
L’ulivo rispecchia quasi mimeticamente ciò che avviene nella testa del commissario, l’intreccio delle ipotesi e l’accavallarsi dei ragionamenti.

Questa curiosa simbiosi è evidenziata in un magistrale passo del romanzo La gita a Tindari:
“Pareva un àrbolo finto, di teatro, nisciùto dalla fantasia di un Gustavo Doré, una possibile illustrazione per l’Inferno dantesco. I rami più bassi strisciavano e si contorcevano terra terra, rami che, per quanto tentassero, non ce la facevano ad isarsi verso il cielo e che a un certo punto del loro avanzare se la ripinsavano e decidevano di tornare narrè verso il tronco facendo una specie di curva a gomito o, in certi casi, un vero e proprio nodo. Poco doppo però cangiavano idea e tornavano indietro, come scantati alla vista del tronco potente, ma spirtusato, abbrusciato, arrugato dagli anni. E, nel tornare narrè, i rami seguivano una direzione diversa dalla precedente. Erano in tutto simili a scorsoni, pitoni, boa, anaconda di colpo metamorfosizzati in rami d’ulivo… Montalbano, quando non aveva gana d’aria di mare, sostituiva la passiata lungo il braccio del molo di levante con la visita all’àrbolo d’ulivo. Assittato a cavasè sopra uno dei rami bassi, s’addrumava una sigaretta e principiava a ragionare sulle facenne da risolvere. Aveva scoperto che, in qualche misterioso modo, l’intricarsi, l’avvilupparsi, il contorcersi, il sovrapporsi, il labirinto insomma della ramatura, rispecchiava quasi mimeticamente quello che succedeva dintra alla sua testa, l’intreccio delle ipotesi, l’accavallarsi dei ragionamenti. E se qualche supposizione poteva a prima botta sembrargli troppo avventata, troppo azzardosa, la vista di un ramo che disegnava un percorso ancora più avventuroso del suo pinsèro lo rassicurava, lo faceva andare avanti” (pp. 97- 98).
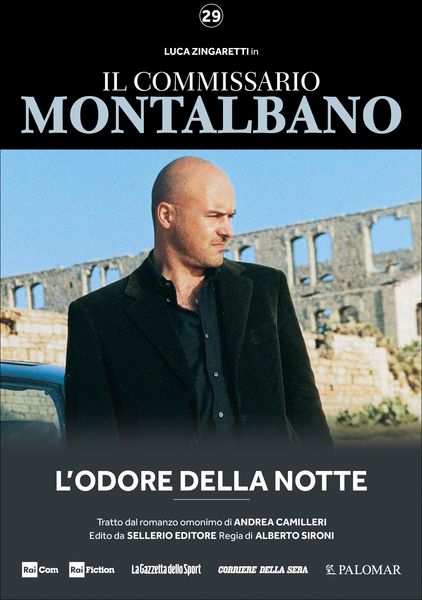
Nel romanzo L’odore della notte (Sellerio, Palermo 2001, pp. 53-56) l’ulivo saraceno esce drammaticamente dalla vita di Montalbano.
Il commissario capita per caso nel luogo a lui caro, a tarda sera, dopo una cena luculliana da “Giugiù ‘u carritteri”; è quasi ubriaco e decide di farsi passare la sbornia “tra i rami dell’àrbolo” a lui caro. Ma qualcosa lo spiazza, non riconosce il paesaggio abituale; scende allora dalla macchina e avanza nello scenario stravolto ed irriconoscibile, finché fa una terribile scoperta: l’ulivo è stato sradicato nel corso dei lavori di costruzione di un orrendo villino: «Puntò la pila, taliò meglio e fece un urlo. Aveva visto un morto. O meglio, un moribondo. Il grande aulivo saraceno era davanti a lui, agonizzante, dopo essere stato sradicato e gettato ‘n terra. Agonizzava, gli avevano staccato i rami dal tronco con la sega elettrica, il tronco stesso era stato già profondamente ferito dalla scure. Le foglie si erano accartocciate e stavano seccando».
Montalbano scoppia in lacrime, palpeggia la pianta agonizzante come se fosse un essere umano moribondo; poi passa dalla disperazione “a una specie di raggia lucida, controllata”, a una rabbia sconfinata che lo induce a devastare l’empio scenario che si sta sostituendo all’antico e mitico ulivo.

Il commissario penetra all’interno del villino, impugna una mazza da spaccapietre e frantuma sistematicamente i vetri delle finestre del piano terra; quando vede poi otto grandi statue kitsch, le distrugge a mazzate: «Erano otto grandi statue momentaneamente raggruppate in attesa che il proprietario della villetta le dislocasse a suo piacimento. Biancaneve e i sette nani. “Aspettatemi che torno” disse Montalbano. Scassò coscienziosamente le rimanenti due finestre e poi, facendo roteare alta sopra la sua testa la mazza come Orlando faceva roteare la sua spada quand’era furioso, s’avventò sul gruppo dando mazzate all’urbigna. Tempo una decina di minuti e di Biancaneve, Mammolo, Eolo, Pisolo, Brontolo, Cucciolo, Ventolo, Mignolo, o come m*** si chiamavano, non rimasero altro che minuscoli frammenti colorati. Ma Montalbano ancora non si sentiva soddisfatto. Scoprì che sempre vicino al gazebo in costruzione c’erano delle bombole spray di colore. Ne pigliò una verde e scrisse, a caratteri cubitali, quattro volte la parola STRONZO, una per lato della villetta. Quindi riscalò il cancello, si rimise in macchina e partì per Marinella, sentendo che la ‘mbriacatura gli era completamente passata».
In questa rabbiosa e irrazionale reazione non emerge tanto la sensibilità ecologista di Montalbano, quanto la rabbia per l’empia violazione di un affetto per lui sacro, per la cancellazione violenta di una consuetudine radicata.
In tutti i romanzi della serie, Montalbano si rivela ostile al degrado ambientale, ma l’impressione è che in lui convivano ambientalismo e passatismo, che egli cioè ami l’ambiente soltanto se è incontaminato dal presente, quando resta immobile nel tempo e nello spazio.
Egli ama, ad esempio, la Sicilia “arcaica”, rurale, aspra e incontaminata, mentre detesta le autostrade e le strade a scorrimento veloce: “Per arrivare a Calapiano scelse di fare la strata più lunga e meno agevole, quella aveva sempre pigliato le poche volte che c’era andato perché gli permetteva di rivedere quella Sicilia che di giorno in giorno scompariva, fatta di terra avara di verde e d’òmini avari di parole” (L’odore della notte, Sellerio 2012, p. 111).

A questa Sicilia “ideale” (prioritaria nella fiction televisiva) si contrappongono la sporcizia, l’abbandono, il cattivo gusto in cui sprofonda l’isola “reale”, potentemente descritto in alcuni passi dei romanzi su Montalbano:
- “Conosceva Vigàta 2. Un incubo generato da un palazzinaro in preda ai peggiori allucinogeni. Lui non ci avrebbe abitato manco sotto forma di catafero” (La luna di carta, Sellerio 2005, p. 22).
- “Sorpassò il camposanto e continuò ad acchianare tra dù ali di cimento, grigi falansteri a mità tra un càrzaro messicano d’alta sorveglianza e un manicomio-bunker per pazzi furiosi e assassini visto come l’incubo di un pazzo furioso e assassino. Quella viniva chiamata, va a sapiri pirchì, edilizia popolare” (La caccia al tesoro, Sellerio 2010, p. 75).
- “Stava passanno in quella zona di Piano Lanterna indove erano stati flabbicati quattro orrendi grattaceli nani, o meglio aborti di grattaceli, per ospitari la popolazioni che dal centro del paìsi si era squasi tutta spostata sull’altopiano… Ora era un mari di cimento, ‘na speci di kasbah dominata dai finti grattaceli” (Una voce di notte, Sellerio 2012, pp. 32-33).
- “Ogni vota che s’attrovava a passari dalle parti di Borgonovo, un quartiere a ponente di Vigàta, il commissario, macari se stava guidanno, chiuiva l’occhi. ‘Na decina di palazzetti repellenti, costruiti su progetto di un architetto chiaramenti dedito agli alcolici e soprattutto ‘ndiciso tra Gaudì e Le Corbusier. Per non fari torto a nisciuno dei dù, aviva pigliato tanticchia dell’uno e tanticchia dell’altro. Inspiegabilmente i palazzetti, tutti di cinco piani, erano come ‘mpiccicati tra di loro, collegati da stratuzze tanto stritte che ci poteva passari ‘na sula machina alla vota. Torno torno, ‘nveci, aperta campagna. O meglio: ‘n’enormi discarrica di ogni cosa possibili e ‘mmaginabili: frigorifira, atomobili, cessi, vasche da bagno, carogne di cani e gatti, fusti che colavano, stracci, liquami ‘ndefinibili e forsi forsi reattori atomici ormai inutilizzabili. E, a circari bono, sicuramenti si sarebbi attrovato suttirrato macari qualichi catafero. Il tutto feteva accussì forti che l’aceddri, appena per sbaglio ci volavano supra, cadivano ‘n terra stecchiti” (Riccardino – Seguito alla prima stesura del 2005, Sellerio 2020, pp. 49-50).

Nel complesso, questa Sicilia camilleriana costituisce una sorta di mix: “appare depurata della fissità verghiana, del profondismo pirandelliano, dell’immobilità lampedusiana, dell’isolitudine bufaliniana e dell’irredimibilità sciasciana” (G. Bonina, Il carico da undici, cit., p. 132).

Leggere simili post toglie l’amaro in bocca del presente così inquieto e turbolento.
Camilleri, un lenimento per l’anima che va oltre la isolitudine del mio collega-maestro Bufalino e trova il suo ubi consistam, finalmente.