Come scrive Guido Paduano nella postfazione dell’edizione BUR, il romanzo “Il visconte di Bragelonne” di Alexandre Dumas «è un romanzo torrenziale e avvincente, capace di seguire in modo esaustivo il labirinto delle pulsioni e delle relazioni tra i molti personaggi che costituiscono la sua trama, ma non è solo questo. È anche un grande libro di storia, dal quale emerge con vivezza quel fenomeno epocale che fu l’affermarsi in Europa delle monarchie assolute, rappresentate con degna antonomasia da Luigi XIV, il Re Sole» (p. 1821).
Il romanzo è il terzo della trilogia “dei moschettieri”, rappresentando il “sequel” de “I tre moschettieri” (1844) e di “Vent’anni dopo” (1845); uscì a puntate sul quotidiano “Le Siècle” dal 20 ottobre 1847 e fu poi pubblicato in volume fra il 1848 e il 1850 in 26 tomi, riscuotendo un grandissimo successo di pubblico.
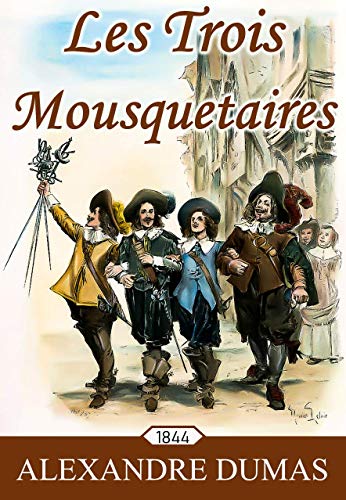
Io avevo letto questo romanzo da ragazzo, in un’edizione ridotta e semplificata; ora ne ho gustato la rilettura, che mi ha preso diversi giorni, trattandosi di un testo – davvero “torrenziale” – di 1820 pagine, che scoraggerebbe molti lettori del nuovo millennio; ne ho ricavato molte riflessioni nuove: certi libri non vanno solo letti, ma anche “riletti”, soprattutto quando cambia la nostra età e la nostra maniera di vedere le cose.

Anzitutto, va detto che il libro inizia nel maggio 1660, negli ultimi mesi di vita del cardinale Giulio Mazzarino, che di fatto aveva governato la Francia durante la minore età del re Luigi XIV (che era salito al trono il 14 maggio 1643, quando aveva meno di cinque anni).
Il titolo dell’opera allude a quello che “dovrebbe” esserne il protagonista, cioè Raul visconte di Bragelonne, nato da una relazione occasionale del conte de La Fère (a noi più noto come Athos).

In realtà le figure predominanti sono ancora una volta quelle dei famosi quattro moschettieri, seguiti nell’ultimo periodo della loro esistenza:
1) Athos, come viene descritto nella sua prima apparizione, «era sempre il gentiluomo di una volta, nobile e bello, ma il tempo aveva dato alla sua nobiltà e alla sua bellezza un carattere più solenne e più distinto» (p. 31); affettuosissimo verso il figlio, il conte de la Fère tollera la sua infatuazione per la signorina de la Vallière e, pur avendo sperato per Raul una migliore “collocazione”, chiede al re di autorizzare il matrimonio; Luigi però, comprendendo il malessere del conte, rifiuta per il momento di acconsentire alle nozze: la fanciulla entrerà però a corte dove, inaspettatamente, si innamorerà follemente del sovrano dimenticando Raul. La disperazione del ragazzo e il suo desiderio di cercare la morte in terre lontane provocheranno la separazione definitiva dal padre, che perderà ogni gioia nella vita e si spegnerà nel rimpianto del figlio lontano.
2) Aramis, già moschettiere con inclinazioni religiose, abate d’Herblay e poi vescovo di Vannes, diventa addirittura generale dei gesuiti e architetta una cospirazione per sostituire il Re Sole con un suo gemello, Filippo, la cui esistenza è stata tenuta nascosta e che è stato segregato da anni alla Bastiglia; ma la sostituzione del prigioniero con il sovrano dura lo spazio di una notte: la congiura viene scoperta e il re-gemello viene relegato per sempre, mentre il suo volto viene coperto da una maschera di ferro.

Nella sua congiura Aramis coinvolge l’ignaro amico Porthos ed è, di fatto, responsabile della sua morte eroica. Alla fine del romanzo Aramis, lo sfuggente, ambiguo, raffinato moschettiere gesuita, è l’unico dei quattro amici a restare in vita: «Dei quattro valorosi di cui abbiamo raccontato la storia, non restava più che un corpo solo: Dio aveva ripreso le anime» (p. 1820). Aramis è però ormai solo un “corpo”; la sua anima (se ne aveva una) è già volata altrove.
3) D’Artagnan è, come sempre nella trilogia, il vero protagonista. Molte riduzioni cinematografiche, che ne hanno fatto solo un invincibile spadaccino, sono riduttive e superficiali di fronte a un personaggio ben più complesso e delineato perfettamente: il Guascone è uomo intelligentissimo, arguto e a tratti geniale, ironico quanto prudente, integerrimo quanto scanzonato, irriverente e mai servile.
Un passo che andrebbe letto nelle scuole, in periodi di rinnovato servilismo ed ipocrita acquiescenza, è quello in cui il capitano dei moschettieri si rivolge coraggiosamente al Re Sole con parole di altissimo livello morale: «Sire, scegliete! Volete degli amici o dei valletti? Dei soldati o dei ballerini per le riverenze? Dei grandi uomini o dei pulcinella? Volete che vi servano o che si pieghino? Volete che vi si ami o che si abbia paura di voi? Se voi preferite la bassezza, l’intrigo, la codardia, ditelo, sire, e noi ce ne andremo, noialtri che siamo i soli resti, dirò di più, i soli modelli del valore di una volta. […] Scegliete, sire, e fate in fretta. I grandi signori che vi restano, conservateli: di cortigiani ne avrete sempre a sufficienza» (p. 1369). [Chi ha orecchie per intendere, intenda…]
Nel romanzo il re finirà per tenersi stretto questo incorreggibile Guascone che osa dirgli la verità in faccia senza infingimenti; e alla fine D’Artagnan morirà, dopo essere stato nominato maresciallo di Francia, nell’assedio di Maastricht del 1673 (come avvenne in effetti nella realtà storica).
4) Porthos merita un discorso a parte; come osserva Paduano, la parte finale del “Visconte di Bragelonne” presenta un «innalzamento di tono, per cui l’ultima sequenza dei fatti si ispira direttamente allo stile sublime dell’epopea» (p. 1840). Di questa epopea l’eroe è Porthos, «quello dei quattro moschettieri che nella trilogia e in particolare nel terzo romanzo occupa sempre una posizione subalterna e sempre aggredita dall’ironia, affettuosa quanto si vuole, per la compresenza di un’iperbolica forza fisica (“gigante” ed “ercole” sono usti come suoi sinonimi correnti) e di una quasi altrettanto sterminata ingenuità» (ibid.).
Porthos, oltre alla forza smisurata, ha doti ben più profonde: il senso sacro dell’amicizia, la generosità, la bonarietà, la disponibilità, l’affettuosità (anche nei confronti del suo fedelissimo servitore Mousqueton), l’altruismo.
Certo, ogni volta che entra in scena la descrizione si fa più “leggera” e strappa più d’un sorriso, sia quando assistiamo alle quasi surreali prove di forza del gigante sia quando manifesta «un desiderio gastronomico investito da un’attenzione aristofanesca o rabelaisiana, che impazza ugualmente alla tavola del re o nella devastazione della dispensa di Planchet» (ibid.); ma l’ironia verso Porthos è sempre prova di una viscerale simpatia dell’autore per il suo personaggio, descritto sempre con un’ammirazione evidente.
Dumas era, come Porthos, un formidabile mangiatore (lo si vede dal ventre sempre più tondo nelle foto che gli scattarono Nadar e Le Gray); col suo personaggio condivideva la passione per le cene “pantagrueliche” che, per l’appunto, ricordavano “Gargantua e Pantagruel” di Rabelais.

Nel “Visconte di Bragelonne” Porthos, ormai barone du Vallon de Bracieux de Pierrefonds, viene strappato ai suoi ozi rurali e coinvolto dal subdolo Aramis nella congiura contro il re; ovviamente del vero scopo della pericolosa missione il gigantesco ex moschettiere è del tutto ignaro e «solo dalle tardive e imbarazzate spiegazioni di Aramis viene informato di non aver affatto sostenuto il re regnante contro l’usurpatore, bensì l’esatto contrario» (G. Paduano, p. 1840). In questa missione dall’esito fallimentare Porthos finirà per perdere la vita.
Alexandre Dumas figlio narrava di aver un giorno sorpreso il padre in lacrime alla scrivania: l’autore dei “Tre moschettieri” piangeva perché aveva appena scritto l’epico capitolo in cui aveva fatto morire il suo adorato Porthos.
Lo stesso Dumas scrisse così a Louis Perrée, direttore del “Siècle”: «Povero Porthos! non so se è un’illusione del mio cuore o del mio orgoglio, ma mi è sembrato che il giorno in cui avete informato la Francia della sua morte, un velo di lutto sia caduto disteso su Parigi. Avevamo immaginato, sapete, che i nostri quattro eroi erano immortali, e quando vedevamo cadere il più forte e forse il migliore di tutti, sentivamo istintivamente che la morte non sarebbe entrata per così poco in questa quadriglia di giganti, e che uno alla tomba, gli altri non avrebbero tardato nel seguirlo lì. Il mestiere di romanziere ha certo i suoi piaceri, le sue gioie, il suo orgoglio soprattutto, ma come lui ha anche le sue tristezze, e una di queste tristezze, una tristezza incomprensibile forse per alcuni, ma vera, ma profonda, ma infinito per me, è aver partorito un carattere, aver allevato, coccolato, visto crescere, e quando arriva il giorno sentire l’implacabile necessità che viene a chiamarti al ritorno alla terra, cioè all’oblio, questo dolce sogno della tua immaginazione di cui eri abituato ad essere il compagno, il consigliere, il padre».
Si ha qui un altro esempio di quell’affettuosità profonda che si crea fra i grandi scrittori e i grandi personaggi: è come se, quando si deve descrivere la fine di un personaggio che si è creato e amato tanto, si perda con lui qualcosa di se stessi, ci si senta impoveriti e quasi mutilati. Simile deve essere stata, da parte di Andrea Camilleri, la “cancellazione” di Montalbano descritta nell’ultimo romanzo della saga del commissario, “Riccardino”.
Nella parte conclusiva del romanzo di Alexandre Dumas “Il visconte di Bragelonne”, in seguito al fallimento della congiura contro Luigi XIV, Aramis (che aveva progettato di sostituire il legittimo re con un suo gemello, a lui identico nell’aspetto e da anni recluso alla Bastiglia) è costretto alla fuga; con lui è il fedele e inconsapevole Porthos, che ha seguito l’amico di sempre pur non comprendendone le reali intenzioni.
I due ex moschettieri si rifugiano nell’isola di Belle Île, in Bretagna, che avevano fortificato pochi mesi prima per conto del sovrintendente alle finanze Nicolas Fouquet.

D’Artagnan riceve dal re lo sgraditissimo incarico di catturare i suoi amici, destinati alla forca. Ma il coraggioso capitano in realtà intende salvare loro la vita, tirandoli fuori dai guai. Arrivato in Bretagna, si mette dunque in contatto con loro sperando di organizzarne la fuga: ma ordini predefiniti del re gli impediscono ogni azione, sicché non può che dimettersi dalla carica di capo dell’esercito e consegnarsi agli uomini del sovrano.
Privi ormai di altri aiuti, Aramis e Porthos con pochi Bretoni fedeli si nascondono nella grotta di Locmaria, sperando di potersi allontanare da lì con una barca.

Arrivano però in massa le truppe del re, per catturarli: ma i moschettieri incaricati dell’azione sono terrorizzati sentendo i nomi di Aramis e Porthos: «in tutti quei giovani coraggiosi l’idea che avrebbero dovuto lottare contro due delle più antiche glorie dell’esercito fece scorrere un brivido, mezzo di entusiasmo e mezzo di terrore. In effetti, quei quattro nomi, D’Artagnan, Athos, Porthos e Aramis, erano venerati tra quanti portavano una spada, come nell’antichità erano venerati i nomi di Ercole, Teseo, Castore e Polluce» (p. 1734).
A questo punto inizia l’epico cap. CCLV, non a caso intitolato da Dumas “Un canto d’Omero”; nella grotta di Locmaria un’enorme pietra impedisce l’uscita: qui allora Porthos compie la sua prima straordinaria impresa: «Porthos prese la gigantesca pietra alla base, vi poggiò la sua robusta spalla e diede un colpo che fece scricchiolare la muraglia. Una nube di polvere cadde dalla volta insieme alle ceneri di diecimila generazioni di uccelli marini, che avevano i nidi attaccati alla roccia come cemento. Al terzo colpo la pietra cedette e oscillò per un minuto. […] Caduta la pietra, si vide la luce, splendente e radiosa, che precipitava nel sotterraneo attraverso l’inquadratura dell’uscita e il mare azzurro apparve ai Bretoni estasiati» (p. 1737).
Proprio nel momento in cui la fuga pare assicurata, la compagnia dei soldati del re irrompe nella grotta. Fra i due amici si svolge allora un breve drammatico scambio di battute: «“Amico mio, ai nostri avversari sono arrivati rinforzi”. “Ah – disse tranquillamente Porthos, – e adesso che facciamo?” “Ricominciare a combattere – disse Aramis – è molto aleatorio”. “Sì – disse Porthos – perché di noi due è difficile che non ne resti ucciso uno, e se uno di noi fosse ucciso, senza dubbio anche l’altro si farebbe uccidere”. Porthos disse queste parole con la natura eroica che in lui era ingrandita da tutte le forze della materia».
Aramis però non intende arrendersi e concepisce un piano audace: mentre Porthos, nascosto in imboscata dietro un pilastro, massacra a uno a uno con la sbarra di ferro i nemici che si incuneano nello stretto passaggio, il suo amico decide di utilizzare i barili di esplosivo per annientare totalmente i soldati del re.
Nel cap. CCLVI (“La morte di un Titano”) si ha l’epilogo tragico: Porthos viene incaricato di scagliare in mezzo ai nemici un enorme barile di polvere da sparo di cui Aramis avrà acceso la miccia; compiuta l’opera, il gigantesco eroe dovrà correre fuori e raggiungere gli altri nella barca pronta a salpare.
All’inizio tutto va come previsto: Porthos appare ai soldati terribile, con il barile in mano: «e compresero ciò che stava per accadere» (p. 1742). L’esplosione avviene subito dopo e viene descritta dall’autore con toni epici: «Le grida, gli urli, le imprecazioni, le esistenze, tutto si spense in un immenso fracasso. I tre primi compartimenti della grotta diventarono un abisso nel quale ricadde, secondo il peso, ogni frammento vegetale, minerale o umano. Poi la sabbia e la cenere più leggera ricaddero a loro volta, stendendosi come un sudario grigiastro e fumante su quelle lugubri esequie. E adesso cercate in quella tomba ardente, in questo vulcano sotterraneo, cercate le guardie del re con gli abiti blu e i galloni d’argento. Cercate gli ufficiali rilucenti d’oro, cercate le armi sulle quali contavano per difendersi, cercate le pietre che li hanno uccisi, cercate il suolo che li ospitava. Un solo uomo ha fatto di tutto ciò un caos più confuso, più informe, più terribile del caos che esisteva un’ora prima che Dio avesse avuto l’idea di creare il mondo» (p. 1743).
In queste righe, tragiche e liriche al tempo stesso, sembra di rileggere le antiche poesie “delle rovine” dell’antichità greca e romana, come ad es. il desolato epigramma di Antipatro di Sidone per la distruzione di Corinto (A. P. IX 151).
A questo punto Porthos, dopo aver lanciato il barile in mezzo ai nemici, fugge verso l’apertura: «Vide a cento passi da sé la barca cullata dalle onde: là stavano i suoi amici, la libertà e la vita dopo la vittoria. Ancora sei delle sue formidabili sgambate, ed era fuori della volta; quando fosse fuori della volta due o tre slanci vigorosi, e arrivava al canotto» (p. 1744).
Sembra fatta: ma avviene l’imprevedibile: «D’improvviso sentì le ginocchia piegarsi, sembravano vuote. E sotto, le gambe si afflosciavano. “Oh – mormorò stupito – “ecco che mi riprende la stanchezza; ecco che non riesco più a camminare: che roba è?”» (“Oh! oh! – murmura-t-il étonné – voilà que ma fatigue me reprend; voilà que je ne peux plus marcher. Qu’est-ce à dire?”, ibid.).
In un precedente capitolo (CCLI, “Gli avi di Porthos”) Porthos aveva confidato ad Aramis di soffrire da qualche tempo di momenti di improvvisa debolezza: una simile patologia aveva già ucciso suo padre e ancora prima suo nonno; sul momento però i due amici non avevano dato peso alla cosa, perché lo stesso gigante aveva prontamente riconfermato le sue eccezionali doti fisiche.
Ora però è arrivato il momento estremo: Aramis chiama l’amico, lo incita disperatamente; ma Porthos pronuncia le parole più incredibili per un uomo dalla forza sovrumana quale era sempre stato: «Non ce la faccio» (“je ne puis”).
L’ultima esplosione sta per avvenire: Porthos raduna tutte le sue forze residue per fare quei pochi, ultimi passi verso la salvezza. Ma non c’è più tempo: «L’esplosione risuonò, la terra si aprì, il fumo che si alzava per le larghe fessure oscurò il cielo, il mare rifluì come cacciato dal soffio del fuoco che scaturiva dalla grotta come dalla gola di una gigantesca chimera; il riflusso trascinò la barca a venti tese, tutte le rocce scricchiolarono alla base e si separarono come spicchi sotto lo sforzo dei cunei» (ibid.).
Porthos si sente mancare il terreno sotto i piedi: allora «stese a destra e a sinistra le sue grandi mani per respingere le rocce che crollavano. Un blocco enorme venne a premere su ognuno dei suoi palmi tesi; curvò la testa, e un terzo masso di granito venne a pesargli sulle spalle. Per un attimo le braccia di Porthos si erano piegate, ma l’ercole unì tutte le sue forze e si videro le due pareti della prigione dove era stato sepolto scostarsi lentamente e fargli posto. Per un momento apparve nella cornice del granito come l’antico angelo del caos, ma scostando le rocce laterali tolse il punto d’appoggio al monolito che pesava sulle sue spalle, e il monolito, premendo con tutto il suo peso, fece cadere il gigante in ginocchio. Le rocce laterali, per un attimo allontanate, si riavvicinarono, e vennero ad aggiungere il loro peso al peso originario che sarebbe bastato a schiacciare dieci uomini. Il gigante cadde senza chiamare aiuto, cadde rispondendo ad Aramis parole di incoraggiamento e di speranza perché per un attimo, grazie al potente arco rampante delle sue mani, poté credersi capace come Encelado di scuotere da sé il triplo peso. Ma a poco a poco Aramis vide il blocco cedere, le mani per un istante contratte e le braccia irrigidite in un ultimo sforzo si piegarono, le spalle tese cedettero, straziate, e la roccia continuò gradualmente ad abbassarsi» (p. 1745).

A questo punto Aramis, il freddo Aramis, l’uomo insensibile, il cinico manipolatore di uomini, si dispera strappandosi i capelli e invocando il nome dell’amico: «Porthos, Porthos! Porthos, dove sei? Parla!». E il gigante riesce solo a rispondere, «con una voce che si spegneva»: «pazienza, pazienza!» (“patience! patience!”, ibid.). Subito dopo un’enorme roccia si abbatte su di lui «e inghiottì Porthos in un sepolcro di pietre spezzate».
A questo punto «Aramis, splendente, superbo, giovane come a vent’anni, si slanciò verso il triplo masso e con le sue mani, delicate come mani di donna, tolse per un miracolo di vigore uno spigolo dell’immenso sepolcro di granito. Allora intravide nelle tenebre della fossa l’occhio ancora brillante dell’amico, a cui la massa sollevata per un attimo aveva restituito la respirazione» (pp. 1745-1746). Ma quando i due Bretoni e l’amico fanno l’unico inutile sforzo con una leva di ferro, «la rude voce di Porthos, vedendoli sfinirsi in una lotta inutile, mormorò in tono beffardo queste parole estreme venutegli alle labbra con l’ultimo respiro: «Troppo pesante!».
Le ultime parole di Porthos (“Trop lourd!”) sono un ironico messaggio di autostima: solo lui avrebbe potuto sollevare quella leva, che per gli altri era invece “troppo pesante”. Ma, subito dopo, «più niente: il gigante dormiva il sonno eterno, nel sepolcro che Dio gli aveva creato, adeguato alla sua statura» (ibid.).
Nell’episodio della morte di Porthos è evidente la presenza dei modelli classici. Il padre di Dumas, che era un generale napoleonico, era stato un appassionato lettore di Plutarco e Cesare, ma era morto quando ancora Alexandre non aveva quattro anni; tuttavia il futuro scrittore fin da bambino fu affascinato dalla mitologia greca: nelle sue “Memorie” ricorda infatti di avere imparato bene i miti greci; inoltre ebbe come insegnante un abate Grégoire, che gli insegnò il latino, approfondendo in particolare Virgilio e Tacito.
Quanto al greco antico, Dumas non lo studiò, ma ammirò moltissimo Omero, da lui letto in traduzione; e quando pubblicò il suo giornale, “Le Mousquetaire”, iniziò a pubblicare traduzioni dell’Iliade (dimostrandosi, più di quanto lo fosse il Monti secondo Foscolo, “gran traduttor de’ traduttor d’Omero”); e a suo figlio consigliò di studiare il greco in modo costante e approfondito, in modo da poter leggere Omero, Eschilo, Sofocle, Euripide e Aristofane nell’originale.
Va detto poi che quando Dumas, a vent’anni, lasciò la sua città natale Villers-Cotterêts e si trasferì a Parigi, entrando come copista al servizio di Luigi Filippo, duca di Orléans (futuro Re dei Francesi), esordì come drammaturgo, in un ambiente ancora fortemente influenzato da Racine, Corneille e dal teatro neoclassico. Infine, non va dimenticato che la saga dei moschettieri fu composta da Dumas in stretta collaborazione con Auguste Maquet, che aveva una solida base culturale classica: i tre romanzi furono inizialmente firmati anche da Maquet, ma dopo un contenzioso giudiziario il collaboratore di Dumas rinunciò alla doppia firma in cambio di un sostanzioso assegno. (Per altre notizie sulla cultura classica di Dumas, cfr. Paul T. M. Jackson, “Alexandre Dumas and the Classics”, sulla rivista “Classics for All”, 1/10/2020).
Insomma, non c’è da meravigliarsi se i capitoli della morte di Porthos, ambientati in una grotta, richiamino da vicino l’episodio omerico di Polifemo, con un finale ancor più tragico per il “gigante”; inoltre le connotazioni del sovrumano moschettiere ricordano da vicino quelle di Aiace, l’eroe “enorme” (πελώριος) descritto da Omero e Sofocle, generoso e audace quanto sventurato.

Nella parte finale del “Visconte di Bragelonne”, morto Porthos, inizia la sua apoteosi.
Anzitutto la fine dell’amico ha annientato del tutto Aramis, che rimane silenzioso, “pallido e gelido”, in preda forse ai sensi di colpa. Quando la sua barca viene soccorsa da un piccolo bastimento, si fa riconoscere come generale dei gesuiti e si salva, ottenendo di far rotta verso la Spagna; ma poi passa la notte insonne, appoggiato al ponte della nave. L’indomani un marinaio «notò che la notte doveva essere stata molto umida, perché il legno sul quale poggiava la testa del vescovo era irrorato come di rugiada. Chissà, forse quella rugiada erano le prime lacrime mai cadute dagli occhi di Aramis. Quale epitafio poteva valere quello?» (p. 1752).
L’ultimo tributo a Porthos avviene nella sua tenuta di Pierrefonds, ove – alla presenza di un addoloratissimo D’Artagnan – avviene la lettura del suo testamento.
Il testamento di Porthos è un ultimo capolavoro di ironia dumasiana, che descrive alla perfezione per l’ultima volta il carattere del suo amatissimo personaggio. Il testatore elenca scrupolosamente i suoi beni: le terre, 20 cavalli da sella e da tiro con tutti i loro nomi, 60 cani, armi da guerra e da caccia, vini squisiti, quadri e statue («che si dice di grande valore»), la sua biblioteca («composta di seimila volumi tutti nuovi e mai aperti»), il vasellame d’argento («forse un po’ logoro, ma che deve pesare da 1000 a 1200 libbre, perché facevo una gran fatica a sollevare lo scrigno che lo contiene e portandolo riuscivo a fare il giro della mia camera soltanto sei volte»!!), la biancheria, ecc. (pp. 1772-1773).
Porthos scrive poi: «Ho vissuto senza avere figli ed è probabile che non ne avrò, cosa che è per me un cocente dolore»; lascia allora tutti i suoi beni a Raul, il visconte di Bragelonne figlio di Athos, non senza incaricarlo di far avere a D’Artagnan quello che vorrà (ma sa bene che l’amico non chiederà niente per sé) e di inviare ad Aramis una “buona indennità… se avesse bisogno di vivere in esilio” (p. 1774).
L’ultimo pensiero di Porthos è per il suo affezionato servitore Mousqueton, cui lascia tutti i suoi abiti «da città, da guerra e da caccia, in numero di 47, nella certezza che li porterà fino a logorarli per amor mio e in ricordo di me» (ibid.). Non sarà così, purtroppo: quando D’Artagnan sale a salutare Mousqueton, lo trova privo di vita, coricato sugli abiti lasciatigli dal padrone: «Mousqueton era morto. Morto come il cane che, avendo perduto il padrone, viene a morire sul suo vestito» (p. 1775).
Ho chiuso “Il visconte di Bragelonne” dopo averne letto, in alcuni giorni, le 1820 pagine.
Nessun senso di stanchezza, di fatica, di noia. Certo, alcune parti (specialmente quando si avrebbe desiderio di procedere con le appassionanti fasi del romanzo) possono apparire più statiche e lente: ma, a ben vedere, sono anch’esse uno spaccato storico importante per contestualizzare al meglio la vicenda (in cui, fra l’altro, compaiono La Fontaine e Molière).

In definitiva, chiudendo il romanzo dopo la morte di D’Artagnan, il lettore affezionato prova una sottile commozione, come se gli venisse a mancare, come era sicuramente avvenuto anche all’autore, una consuetudine ormai consolidata con dei personaggi divenuti ormai più che familiari.
Fra questi personaggi, una particolare malinconia resta al pensiero di Porthos, il gigante ingenuo e al tempo stesso profondo, la persona buona nel cuore e sincera nell’animo; e le pagine che abbiamo ricordato, che ne celebrano l’epilogo, costituiscono un doveroso tributo e un meritato riconoscimento a questo simpaticissimo eroe.

Grazie Mario per questo intrigante emozionante approfondito ma anche emotivamente coinvolgente appassionato articolato ragguaglio su uno dei romanzi che ha segnato l’educazione e la crescita e l’amore per la lettura di tante generazioni. I tre moschettieri, evidentemente in una edizione ridotta, piena di molte figure, fu la mia prima lettura alla scuola elementare e forse fu grazie a quest’opera che ho poi coltivato l’amore per le lettere. siamo in trepidante attesa della prossima puntata. ma anche che grande signorilità e coinvolgimento nell’autore che piange senza schermo per la morte del suo personaggio