Elettra (Elektra) è una tragedia in un atto unico di Hugo von Hofmannsthal (Vienna 1874-1929). Fu rappresentata per la prima volta il 30 ottobre 1903 al Piccolo Teatro (Kleines Theater) di Berlino per la regia di Max Reinhardt. Il successo fu notevole, tanto che la pièce in seguito fu adattata come libretto per l’omonima opera lirica di Richard Strauss (1909).
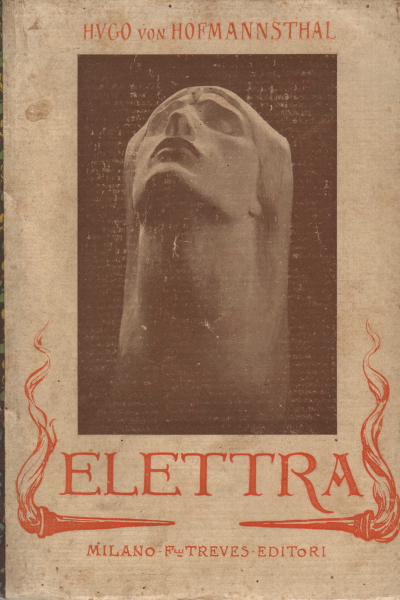
Il debito di Hugo von Hofmannsthal nei confronti di Sofocle è «non solo evidente, ma anche dichiarato. Il sottotitolo del lavoro, composto tra il luglio e il settembre del 1903, recita infatti così: “Tragedia in un atto liberamente tratta da Sofocle”» (Fausto Cercignani, Elettra e la prigione dell’io – La tragedia e il “libretto” di Hofmannsthal, in Studia austriaca XIV, 2006, p. 49). Tuttavia l’autore austriaco fu anche influenzato da teorie freudiane; la sua eroina è dunque dominata da un’ossessiva ed esclusiva sete di vendetta.
Come osserva ancora Fausto Cercignani, «Lo stesso Hofmannsthal precisa così, in un’annotazione del 1903, l’impostazione del suo lavoro rispetto all’originale, che il poeta conosceva nell’ottocentesca traduzione in versi di Georg Thudichum: “Non ho toccato le figure. Ho solo sistemato diversamente le pieghe del mantello di parole che la loro bronzea esistenza ha indosso, così che le parti avvocatorie sono messe in ombra, e quelle poetiche, che parlano al cuore, si trovano esposte alla luce”. Nell’Elettra di Hofmannsthal l’accento si è dunque spostato ancor più drasticamente dall’azione ai singoli personaggi e alla loro prospettiva, poiché “le parti avvocatorie” che il poeta viennese ha voluto oscurare non sono altro che i passi da cui emerge l’insieme di argomentazioni a favore o contro le varie azioni delittuose commesse dagli Atridi, specialmente quelle che la tradizione attribuisce a Elettra e al fratello Oreste. Ciò che invece viene messo in piena luce rispetto al problema morale è la rappresentazione poetica dei tormenti e dei conflitti umani, e in particolare di quelli che riguardano le tre figure femminili che si pongono al centro della tragedia: Elettra, Clitennestra e Crisotemide. Un simile risultato presuppone però qualcosa di ben più incisivo rispetto a un puro e semplice aggiustamento delle pieghe del “mantello di parole”, tanto più che l’eliminazione delle motivazioni tradizionali comporta necessariamente interventi di rilievo anche sulla caratterizzazione dei personaggi» (art. cit., pp. 50-51).
Rinunciando al coro e al prologo, la tragedia si sviluppa in un atto unico privo di ogni cornice sacrale; l’azione si svolge, simbolicamente, non davanti, ma dietro il Palazzo degli Atridi a Micene, in un angusto cortile interno che crea un’atmosfera claustrofobica. L’atto unico non viene suddiviso in scene, ma si fonda su una struttura articolata, che comprende una parte introduttiva (le serve al pozzo), cinque declamazioni dialogiche ed una conclusione (l’uccisione di Clitennestra e poi di Egisto, seguita dalla danza mortale di Elettra).
Sono trascorsi numerosi molti anni da quando Clitemestra ed Egisto hanno ucciso a tradimento Agamennone al ritorno dalla guerra di Troia. La figlia Elettra, costretta a una vita di umiliazioni e soprusi, “vive e non vive”, devastata nella psiche.
Alcune ancelle commentano il comportamento della giovane, definita “maligna, come un gatto selvatico”, sfuggente, infastidita da tutto e da tutti; solo una delle ancelle, molto giovane, esprime il suo rispetto e la sua ammirazione per Elettra: “Io voglio chinarmi dinanzi a lei e baciarle i piedi. È figlia di un re! Perché deve sopportare tante infamie? Voglio metterle dell’unguento sui suoi piedi e poi asciugarli coi capelli. […] Non c’è nulla al mondo più regale di lei (Es gibt nichts auf der Welt, / das königlicher ist als sie). Siede lacera sulla soglia, tuttavia in casa non c’è nessuno che possa sostenere il suo sguardo” (utilizzo qui la traduzione dal tedesco di Laureto Rodoni).
Quando la protagonista esce di casa, le sue prime parole esprimono la sua solitudine e il desolato rimpianto del padre, di cui viene ricordata la morte violenta: “Sola! Ahimè, sola (Allein! Weh, ganz allein). Lontano il padre, scacciato giù nei suoi freddi abissi… [rivolta al suolo] Agamennone! Agamennone! Dove sei, padre mio? Non hai tu la forza di trascinare fino a me il tuo viso? [sottovoce] L’ora è venuta, l’ora in cui la tua sposa e colui che con lei dorme in un letto, nel tuo letto regale, ti hanno sgozzato. Nel bagno ti hanno ammazzato, il tuo sangue scorreva sugli occhi e un vapore di sangue si levava dall’acqua. Poi quel vile ti prese per le spalle e ti ha trascinato fuori dalla stanza, il capo avanti, le gambe inerti al suolo: il tuo occhio sbarrato guardava fisso nella casa. Così tu ritorni, un passo dopo l’altro, appari all’improvviso, con tutti e due gli occhi spalancati, e un cerchio di porpora regale ti cinge le tempie, alimentato dalla ferita aperta del tuo capo”.
Sopraggiunge la sorella minore Crisotemi; ha appreso infatti che Clitemestra ed Egisto meditano di gettare Elettra in una torre oscura.
Crisotemi contrappone alla testarda ostinazione della sorella il suo desiderio di libertà e di una vita “normale”: “Tu con spranghe di ferro mi inchiodi al suolo. Se tu non ci fossi, ci farebbero uscire. Se non ci fossero il tuo odio, la tua mente insonne e inesorabile, per cui essi tremano, ci farebbero uscire dal carcere, sorella! [con passione] Voglio uscire! Non posso dormire qui ogni notte fino alla fine! Voglio vivere prima di morire! [con massimo slancio e ardore] Voglio aver figli prima che sfiorisca il mio corpo, e se anche mi danno un bifolco, per lui metto al mondo i figli e li scaldo con questo mio corpo nelle fredde notti, quando il vento investe la capanna e la squassa! Ma tu mi ascolti? Parlami, sorella! […] Abbi pietà di te e di me! A chi giova tanto strazio? Al padre, forse? Egli è morto e non torna il fratello. Sempre siamo sedute sulla stanga, come due uccelli in catene, volgiamo il capo da ogni parte, ma non viene nessuno, non il fratello, non un suo messaggero, nessuno, non un messaggero di un messaggero! Il tempo scava con coltelli i segni sul tuo viso e sul mio e il sole sorge e cala e le donne che ho conosciuto snelle, son fatte incinte, alla fonte con fatica alzano i secchi, e all’improvviso si sgravano del peso, alla fonte vengono ancora, e dal loro corpo sgorga un dolce succo ed hanno al seno una vita assetata, e i bimbi crescono. No, sono una donna e voglio un destino di donna. È assai meglio morire che vivere e non vivere. [Scoppia in un pianto convulso]
Ma Elettra proclama di non poter e di non voler dimenticare; rimprovera la debole sorella che piange e minaccia di compiere da sola la vendetta.
Crisotemi riferisce che la madre ha sognato (a quanto si dice) Oreste ed ha gridato nel sonno; Elettra afferma allora di essere stata lei a mandare quel sogno, preannunciando la fine violenta della regina.
Entra quindi in scena Clitemestra; come dice la didascalia, “la regina è sovraccarica di gemme e di talismani. Le braccia sono coperte di gioielli. Le dita sono rigide di anelli. Le palpebre degli occhi sembrano troppo gonfie e sembra che le costi una tremenda fatica tenerle aperte”.
Elettra esprime subito il suo incontenibile odio verso la madre; prova orrore di essere nata da quel grembo e di esserne stata “sputata fuori”. La regina chiede però di restare sola con la figlia e le chiede cosa fare perché i suoi incubi la abbandonino. In un drammatico colloquio, Elettra in modo sibillino annuncia che i sogni nefasti finiranno quando morirà una donna, per mano di un uomo, che è al tempo stesso “straniero” e “di casa”. Emerge la domanda se sia meglio dimenticare o ricordare un avvenimento tragico: la figlia vive nel ricordo ossessivo, mentre la madre soffre gli effetti psicofisici della rimozione del crimine.
Giunge la falsa notizia della morte di Oreste; Clitemestra gioisce, mentre Elettra è schiantata dal dolore. Tuttavia, Elettra tenta ancora di convincere Crisotemi ad aiutarla; in una scena concitata, «Elettra esorta, ingiunge, implora, quasi sconfinando nel corteggiamento omosessuale e incestuoso nella rappresentazione di quanto potrà amare e seguire la sorella nella sua vita di donna, vale a dire in tutto ciò che lei stessa non ha mai avuto e non potrà mai avere. Ma Crisotemide fugge, inseguita dalla maledizione di Elettra, la quale si ritrova così ancora una volta isolata nella sua folle determinazione» (F. Cercignani, art. cit., p. 54).
Non riuscendo a convincere la sorella, Elettra decide di agire da sola e, in preda ad un raptus isterico, scava alla ricerca della scure con la quale era stato ucciso il padre Agamennone e che la giovane ha sotterrato e custodito per anni.
A questo punto entra in scena Oreste; al termine di un dialogo drammatico, fratello e sorella si riconoscono; Elettra però si vergogna del suo aspetto:
Elettra [quasi fuori di sé] Ma tu chi sei? Ho paura.
Oreste [dolcemente] Mi conoscono i cani del cortile, e mia sorella no?
Elettra [con un grido] Oreste! [pianissimo, tremante] Oreste! Oreste! Oreste! Non si muove nessuno! Lascia che io guardi i tuoi occhi, sogno, visione a me donata, più bella dei sogni! Superbo, inafferrabile, sublime volto, resta con me! Non dissolverti nel vento, non svanire nel nulla eterno. Dovessi io morire ora e tu ti mostri e mi prendi con te: ecco io muoio più felice di quanto ho vissuto! Oreste! Oreste! [Oreste si china per abbracciarla. Con foga] No, tu non devi abbracciarmi! Scòstati, di te mi vergogno. Non so come mi guardi. Non sono che il cadavere di tua sorella, povero fanciullo mio! Lo so, [sottovoce] nutri ribrezzo di me, ed ero figlia di un re! E credo che ero bella: quando accanto al mio specchio, spegnevo la lampada, mi sentivo castamente rabbrividire. Sentivo il mite raggio della luna che si bagnava nel candore del mio corpo, così come in uno stagno. Tali erano le mie chiome da far tremare gli uomini, questi capelli arruffati, sporchi, stanchi. Vedi, fratello? Tutto ciò che ero, io l’ho sacrificato.
La tragedia si avvia verso la catastrofe. Oreste, entrato nel palazzo, uccide prima Clitemestra e poi Egisto, mentre Elettra, che ha dimenticato di consegnare al fratello la scure, sprofonda nel cortile in una sorta di trance.
Inizia quindi una danza delirante, una Totentanz (“danza della morte”) con la quale celebra il suo trionfo fino a crollare a terra esanime: «La “regale danza della vittoria” che aveva annunciato e immaginato nel suo primo monologo si concretizza ora nel forsennato rito di una mènade, di una baccante che intende concludere l’azione purificatrice riconciliandosi con gli dèi nella danza liberatrice. Ma mentre muove i passi del suo più spasmodico trionfo, e prima ancora che gli altri possano udire il suo appello, Elettra stramazza a terra, così che il rituale dionisiaco della dissoluzione dell’io in quella che dovrebbe essere l’ebbrezza collettiva finisce col celebrare l’autodistruzione fisica della protagonista. Avendo consumato se stessa nell’immaginare il raggiungimento dell’unico scopo della sua vita, Elettra non può sopravvivere al compimento della vendetta, e dunque muore: muore così come ha vissuto, chiusa nella prigione della sua psiche» (F. Cercignani, art. cit., pp. 55-56).
Nell’Elektra di Hofmannsthal Oreste è un personaggio centrale nella vicenda; anche se compare in una sola scena (per quanto importante) è sempre presente nei pensieri e nelle parole degli altri personaggi. Tuttavia il dramma è, fondamentalmente, la storia di donne che sono prigioniere della loro incapacità di agire: «Le grandi figure della rielaborazione di Hofmannsthal sono però tutte femminili: Elettra, con la sua spaventosa nevrosi ossessiva; Clitennestra, tormentata dai sogni e distrutta dall’insonnia; Crisotemide, che vorrebbe dimenticare per vivere la sua vita e che pure potrà gioire, almeno per un attimo, solo grazie a chi non dimentica» (F. Cercignani, art. cit., p. 56).
Una sorta di “follia” accomuna Elettra alla sorella Crisotemi, ma anche all’odiata madre Clitemestra: tutte sono vittime di ossessioni, desiderose di uscire dal carcere in cui sentono di vivere, che le esclude dalla vita; smaniano di uscire da se stesse e di liberare i propri stimoli vitali; nella loro presentazione emerge, in piena evidenza, la contemporanea scoperta dell’inconscio freudiano.
Hofmannsthal evoca una Grecia fortemente anticlassica, pessimistica, arcaica e barbarica, dionisiaca e per niente apollinea, caratterizzata da riti orgiastici e credenze superstiziose.
Il mondo descritto nel dramma è misterioso, inquietante, caratterizzato da passioni irrefrenabili e da un clima nevrotico. Elettra appare sadica, psicopatica e con venature lesbico-incestuose (nei confronti della sorella Crisotemi); in lei confluiscono la baccante dionisiaca arcaica e la donna isterica dell’epoca moderna: «cibo, sesso e maternità riassumono gli anti-valori di Elettra, ossessivamente ribaditi dinanzi a ogni interlocutore; proprio tale ostinata resistenza al flusso della vita rende Elettra un mostro agli occhi delle donne più mature, un idolo agli occhi dell’unica serva adolescente… Nulla è “regale” come l’umiliata figlia del re morto. Hofmannsthal mira a una nobilitas animi indifferente a ogni concretezza storica. Elettra è pura asocialità o nobiltà ideale, che si esprime nella paradossale sintesi di abiezione – perché nulla distingue Elettra dalle sue serve – e purezza interiore – perché tutto, in tale abiezione, fa di Elettra l’inverso dei valori egemoni: e cioè dei valori borghesi» (F. Condello, Elettra – Storia di un mito, Carocci, Roma 2010, pp. 109-110).
La protagonista afferma di non saper dimenticare, ma non dà alcuno spazio alla stirpe, al ghénos cui appartiene; si sente ed è “sola”, si mostra spesso sarcastica, è isterica, ossessionata dall’idea del sesso, portata a identificare assassinio e maternità in un ibrido e mostruoso connubio. Quando Oreste arriva sotto mentite spoglie stenta a riconoscere la sorella in quella ragazza sfatta e umiliata; allorché il fratello si fa riconoscere, Elettra mostra, come si è visto, tutta la sua desolazione; ma poi, quando Oreste colpisce a morte la madre, grida “come un’ossessa” e come il personaggio sofocleo esorta crudelmente il fratello: “Colpisci un’altra volta!”.
La selvaggia danza finale di Elettra si chiude col suo accasciarsi a terra, forse morta; la giovane si consuma e si annienta in questa danza selvaggia che la consegna al mito come un idolo spezzato.

