
Un commovente mito antico narra la storia di Ero e Leandro, due innamorati dal tragico destino. Vivevano rispettivamente nelle città di Sesto (nel Chersoneso tracico) e Abido (nella Misia), situate l’una di fronte all’altra, all’ingresso dello Stretto dei Dardanelli che conduce al Mar Nero; oggi questo territorio appartiene alla Turchia.
La loro vicenda era narrata in un poemetto del V-VI secolo d.C., “Le vicende di Ero e Leandro” (Τὰ καθ’ Ἡρὼ καὶ Λέανδρον), di cui sono sopravvissuti 343 esametri, dedicati ai due giovani amanti; l’autore era Museo Grammatico, molto influenzato sia dagli epilli ellenistici (brevi racconti mitologici, spesso d’argomento amoroso) sia dai romanzi della prima età imperiale.
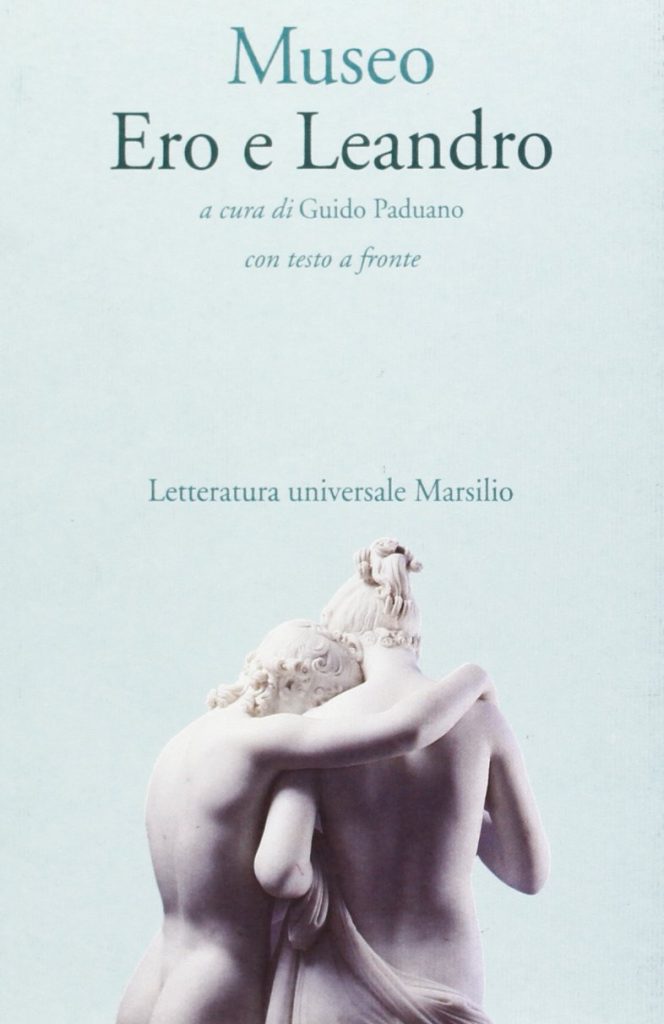
Dopo l’invocazione alla Musa, Museo presenta così i due giovani protagonisti: «L’una abitava a Sesto, l’altro nella città di Abido / di entrambe le città bellissimi astri pari l’uno all’altro. / Se un giorno passerai il mare in quel punto / cerca una torre, dove un tempo Ero di Sesto / stava dritta tenendo la lampada e così indicava la via a Leandro. / Cerca il risonante stretto dell’antica Abido / che ancora piange l’amore e la morte di Leandro» (trad. Paduano).
Una torre battuta dalle onde, il mare aperto davanti, di fronte la costa opposta. Lì la bella Ero aspettava il suo Leandro, che a nuoto attraversava lo stretto per venire da lei. La ragazza lo guidava tenendo accesa una fiaccola sulla torre del tempio, per evitare che si smarrisse in quel tratto di mare battuto da forti venti e agitato da impetuose correnti.
Ma come era nato questo difficile amore?
Un giorno Leandro, originario di Abido, era venuto a Sesto per la festa di Adone e Afrodite, cui affluirono moltissime persone dalle città vicine, ma anche dalle isole egee e da Cipro, dalla Tessaglia e dalla Frigia, dal Libano e dalla Fenicia. In quell’occasione Leandro vide la sacerdotessa della dea, Ero, e se ne innamorò perdutamente. La ragazza ricambiò il suo amore, ma la famiglia le negò il permesso di sposare Leandro: essendo una sacerdotessa, Ero era votata alla castità; fu dunque costretta a vivere in una torre sul mare, con la sola compagnia di una fedele ancella. Nondimeno, da allora Leandro venne ogni notte a visitare la sua amata traversando a nuoto lo stretto, guidato dalla luce della fiaccola che Ero teneva accesa in cima alla sua torre sul lido.
L’erudito latino Plinio il Vecchio si prese la briga di calcolare l’effettiva distanza tra le due città, calcolandola in sette stadi, ovvero 1350 metri (“Naturalis Historia” 2); ma in realtà la traversata era un’impresa molto difficile anche per un provetto nuotatore, a causa dei forti venti e delle correnti impetuose che imperversavano sullo stretto. Tutto riuscì bene diverse volte; ma una notte, in cui il mare era agitatissimo, un colpo di vento spense la fiaccola di Ero. Leandro perse l’orientamento, vagò nei flutti in tempesta e finì per soccombere. Il suo cadavere fu gettato dalle onde sulla riva di Sesto. Ero ritrovò il corpo dell’amato e, pazza di dolore, si stracciò le vesti e si gettò dall’alto della sua torre.
Questa leggenda, romantica “ante litteram”, era già stata fonte di ispirazione per il poeta latino Ovidio, che le dedicò due delle sue “Heroides” (“Le eroine”). L’opera, composta dopo il 15 a.C., appartiene al genere dell’elegia sentimentale e mitologica; si tratta di una raccolta di lettere in distici elegiaci, che il poeta immagina inviate da alcune eroine del mito ai loro amanti lontani. Le epistole sono in tutto ventuno; sei di esse sono disposte a coppie, sicché, oltre alla lettera dell’eroina, si ha anche quella del suo innamorato: è questo il caso delle lettere XVIII (Leandro a Ero) e XIX (Ero a Leandro).
Nella lettera XVIII Leandro presenta con vivide immagini il suo grande amore per Ero. Certo, anziché scrivere, preferirebbe essere di presenza davanti alla sua donna: “Scriverti non vorrei, ma piuttosto nuotare / e muovermi con slancio sulle consuete acque” (vv. 21-22, trad. Leto). Purtroppo però da una settimana il mare è in tempesta: “È la settima notte, ma per me è più di un anno / da quando infuria il mare spinto da rauche ondate” (vv. 25-26). Il giovane siede su una roccia, triste, guardando invano il lido di fronte, dove vive la sua amata; per ben tre volte ha già tentato di immergersi e traversare lo stretto, ma per tre volte “si oppose il gonfio mare al giovanile impulso” (v. 35).
Leandro impreca contro il vento Borea, invitandolo a placarsi. E non potendo far altro, rievoca i primi tempi del suo segreto amore (definito in latino “furtum”, proprio per il suo carattere forzatamente nascosto, v. 54). Durante la prima traversata a nuoto, il giovane aveva invocato la Luna e aveva nuotato audacemente fino ad avvistare il lume acceso da Ero: allora “alle braccia sfinite tornarono le forze, / più cedevole parve l’onda di quanto fosse” (vv. 87-88). Sulla riva, era stato accolto dall’abbraccio della sua Ero: “E mi porgi il mantello tolto dalle tue spalle, / e la chioma grondante d’acqua marina asciughi” (vv. 103-104). Su quello che avvenne dopo, viene steso un velo pudico: “Il resto sa la complice torre, noi e la notte, / e il lume che mi mostra tra le onde la via” (vv. 105-106).
L’indomani mattina, “all’amaro richiamo della nutrice” (v. 115), Leandro ripartì, “esitando”: “Credi al vero, mi sembra, quando giungo, di essere / un nuotatore, un naufrago sono invece al ritorno” (“veniens hic esse natator, / cum redeo, videor naufragus esse mihi”, vv. 119-120).
Leandro ricorda un’altra travagliata storia, quella dei fratelli Elle e Frisso, che su quel mare fuggirono in volo, portati dall’ariete dal vello d’oro: ma Elle era caduta fra le onde e da lei era derivato il nome di quello stretto (“Ellesponto”). Ora il giovane si tormenta, impreca contro la sua sorte, proclama il suo amore immenso; e tuttavia si ripromette, appena possibile, di varcare ancora quel mare insidioso, a qualunque costo: “O avrò fortuna e salvo sarò nella mia audacia, / o morte porrà fine a questo inquieto amore” (vv. 195-196). Ma se dovesse perire, allora spera che il suo corpo raggiunga la sponda opposta e che Ero pianga su di lui, rammaricandosi: “Sono io quella per cui trovò la morte” (“Mortis… huic ego causa fui”, v. 200). Per il momento, prega Ero di accontentarsi di quella lettera, nell’attesa di riabbracciarsi: “Quando il tempo vorrà, io tornerò a nuotare; / ma tu mantieni accesa per sempre quella luce. / E ora che la lettera dorme con te al mio posto, / possa seguirla anch’io dopo assai breve indugio” (vv. 215-218).
Nella Lettera XIX Ero risponde a Leandro con una lettera non meno appassionata: “Ci brucia uguale fuoco (“urimur igne pari”), ma ho minori forze: / credo che l’uomo abbia un animo più fermo” (vv. 5-6). La ragazza divaga sulle differenti occupazioni in cui sono impegnati uomini e donne, rammaricandosi della sua vita isolata: può solo parlare con la nutrice, scrutare le distese del mare e piangere nell’attesa. Di notte non fa che sognare il suo Leandro: “ora mi sembra di vederti che nuoti, / poi che le braccia nude mi posi sulle spalle, / ora di dare, come sempre, vesti alle membra / grondanti e di scaldarti il petto avvinto al mio, / e altre cose che devo per riserbo tacere / dolci a farsi ed invece difficili da dire” (vv. 59-64).
Ero rimprovera il ritardo di Leandro: “Perché da me lontano sei, lento nuotatore?” (v. 70); altre volte, con un mare altrettanto grosso, era venuto da lei: che cosa succede ora? Dove è finita la sua audacia? Di fronte a questi interrogativi, la fanciulla viene assalita da dubbi e sospetti: che Leandro sia stato contagiato dai pregiudizi nei confronti della Tracia (di cui Ero è originaria)?? o, peggio, che Leandro abbia un’altra amante nella sua città? Non lo accetterebbe mai: “Subirò con pazienza qualunque cosa, tranne / che preso da un’amante, con lei tu ti diverta, / che le braccia di un’altra si portino al tuo collo, / che il nuovo amore al nostro possa dare una fine” (vv. 101-104).
La lontananza per Ero non è “come il vento”, ma anzi “induce maggiormente il timore” (v. 110); e tuttavia Ero continua a sperare, invoca Nettuno perché non ostacoli più il loro amore. Poi si rivolge di nuovo a Leandro, gli chiede di venire a ogni costo da lei: Venere lo aiuterà (“lei che dal mare è nata saprà calmare il mare”, v. 160). Arriva persino a proporre al ragazzo un utopistico incontro… a metà strada: “uniamoci, muovendo da sensi opposti, in mare / e scambiamoci baci al livello dell’acqua. / Sarà poco ma sempre sarà di più che nulla” (vv. 167-169).
La lettera si chiude con un nefasto presagio: quando Ero guarda verso il mare, la assale “un senso di freddo e di spavento” (v. 192). Un brutto sogno l’ha turbata: le è sembrato di vedere un delfino nuotare “sulle onde ventose”, che però veniva travolto dalla corrente e si abbatteva morto sulla riva. Timorosa, Ero invita Leandro alla prudenza: “solo al mare calmo affida le tue braccia” (v. 204); nel frattempo, basterà la lettera ricevuta ad alleviare la lunga attesa.
Ovidio ha saputo usare gli elementi del mito tradizionale creando un appassionato “prequel” al drammatico momento conclusivo della triste vicenda. Non vediamo Leandro morire travolto dai flutti, ma raccogliamo indizi disseminati ovunque, che ci anticipano l’esito infausto di questo amore impossibile.
Il tragico finale ci è raccontato da Museo: “Venne l’Aurora ed Ero non vide lo sposo. Allungava gli occhi da tutte le parti sul vasto dorso del mare, se mai riusciva a vedere il suo sposo vagare, dopo che s’era spenta la luce, e quando lo vide ai piedi della torre, morto, straziato dagli scogli, si stracciò sul petto la bella veste e si gettò a capofitto dall’alta torre. Così Ero morì assieme allo sposo morto, e godettero l’uno dell’altra anche nell’ultima sorte” (vv. 335- 343).
Possiamo solo immaginare gli ultimi momenti dello sfortunato giovane: la luce che lo guidava si spegne (metafora triste di morte), lo smarrimento lo pervade, le forze lo abbandonano. Disperato, prima di soccombere alle onde, rivolge un ultimo pensiero alla sua amata Ero (così immaginato da un poeta contemporaneo):
“Se dovevo morire, fanciulla amatissima,
non potevo morire meglio di così,
nel tentativo di raggiungerti
per riabbracciarti ancora.
Ma se un dio crudele
ha distrutto il nostro amore,
per sempre vivrà il nostro ricordo
su questo mare impietoso
che ci ha tolto la speranza.
Resterà la tua torre salda
nei secoli
a diffondere ancora luce
sul destino oscuro degli uomini”.
Il geografo greco Strabone conosceva la storia dei due infelici amanti: chiama «torre di Ero» un’antica torre ai suoi tempi visibile nella città di Sesto (XIII 22), probabilmente un faro che dava la rotta ai naviganti negli attraversamenti notturni dell’Ellesponto.
Il doloroso mito fu citato, tra gli altri, da Virgilio nel III libro delle “Georgiche” (vv. 219-282), da Dante nel XXVIII canto del Purgatorio, da Petrarca nei “Trionfi” (II, v. 21: «Leandro in mare et Ero a la finestra»), da Bernardo Tasso (padre di Torquato), da Christopher Marlowe (autore del poemetto “Hero and Leander”, 1598), da John Keats (che scrisse un sonetto intitolato “Su un quadro che raffigura Leandro”), ecc.
La vicenda colpì in particolare il poeta inglese Byron, che, per rivivere la traversata di Leandro, attraversò l’Ellesponto a nuoto.
Il mito ispirò anche i musicisti: Franz Liszt (ballata n. 2 per pianoforte), Robert Schumann (nel quinto degli otto Fantasiestücke per pianoforte), Arrigo Boito (che scrisse Ero e Leandro, tragedia lirica in due atti nel 1871), Alfredo Catalani (con il poema sinfonico omonimo del 1885).
Fra le tante raffigurazioni pittoriche del mito di Ero e Leandro, ricordo qui quella del pittore inglese William Turner, un olio su tela del 1837 (oggi alla National Gallery di Londra).
Nel dipinto Ero, sulla sua torre, regge due lucerne per guidare ed illuminare il percorso di Leandro; un mare nero e minaccioso quasi si fonde con un cielo altrettanto oscuro, coperto da nubi color cenere. Il pittore offre all’osservatore sia la speranza (le fiaccole di Ero) sia la previsione del tragico destino (il colore plumbeo del contesto naturale).

Sono rimasta affascinata da questo mito che non conoscevo, dall’eco che storicamente avuto e dal Suo straordinario modo di narrare le storie utilizzando molteplici canali comunicativi. Per qualche ragione ( forza d’animo, passione, “bracciate”… ), mi ha ricordato la bella leggenda di Colapesce.Grazie.