Fra i tanti libri che si trovano a casa mia ce n’è uno a me particolarmente caro: è un antico libretto, ingiallito, “dilavato e graffiato”, che era stato di mio padre e risale al 1924. È un libro di testo, quasi totalmente in dialetto siciliano, per la classe V elementare, pubblicato a Firenze (sic!) dagli editori R. Bemporad & figlio.
Il titolo è “Li cosi nuvelli – Indovinelli, proverbi, novelline del popolo siciliano”; gli autori erano Giovanni Antonio Di Giacomo e Luciano Nicastro. Fra i due, Nicastro (1895-1977) fu autore di altri fortunati testi per la scuola e di diversi saggi critici, mentre Di Giacomo diventò poi famoso con lo pseudonimo di Vann’Antò; si tratta infatti del noto scrittore futurista ragusano (1891 – 1960), autore fra l’altro de “Il fante alto da terra” (1932), che in gioventù aveva pubblicato numerosi libri per le scuole.

Fra le tante poesie dialettali comprese nell’antologia, propongo la lettura di una bella lirica di Venerando Gangi, poeta e scultore di Acireale (1748-1816), che si era dedicato alla favolistica ed allo studio dell’antropologia locale; fu considerato da alcuni il maggiore favolista siciliano.

La lirica si intitola “La vurpi e la racìna”, cioè “La volpe e l’uva” (pp. 33-34) e si ispira alla celebre fiaba di Fedro “De vulpe et uva” (IV 3).
Ecco anzitutto il testo della favola di Fedro, seguito da una mia traduzione:
«Fame coacta, vulpes alta in vinea / uvam appetebat, summis saliens viribus; / quam tangere ut non potuit, discedens ait: / “Nondum matura est; nolo acerbam sumere”. / Qui facere quae non possunt verbis elevant, / ascribere hoc debebunt exemplum sibi»
«Spinta dalla fame, una volpe in un’alta pergola / desiderava l’uva, saltando con tutte le forze; / ma poiché non poté toccarla, allontanandosi disse: / “Non è ancora matura; non voglio prenderla acerba”. / Quelli che a parole sminuiscono le cose che non riescono a fare, / dovranno riferire a sé questo esempio».
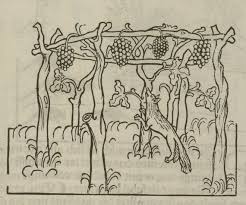
Questa è invece la poesia di Gangi, seguita dalla traduzione (non impeccabile) fornita dagli autori:
«Spincennu l’occhi all’aria, / ‘na vurpi assai affamata, / bella racìna nìura / vitti a na pirgulata. / Bella, ma pri disgrazia / nun era tanta vascia, / e menzi d’acchianàrici, / circànnuli, nun n’àscia. / Si sforza a via di sàuti, / ma nun po’ fari nenti, / e tutti spisi ‘mmàtula / canusci li so’ stenti. / Disfizziata, all’ùrtimu / la ‘ncigna a disprizzari: / “Puh! Racinazza àghira! / chi è cosa di manciari?”. / Spissu cu’ nun po’ ottèniri / ‘na cosa ca disija, / ccu mèntila in discrèditu / la pena so’ sfrazzija».
“Alzando in aria gli occhi, / una volpe affamata / vide in un pergolato / dell’uva nera. / Bella, ma sfortunatamente / non era tanto bassa; / e, quantunque cerchi il mezzo di salirvi, / non lo trova. / Tenta a furia di salti, / ma non ci riesce: / e si convince che i suoi sforzi / sono sprecati. / Delusa, comincia allora a disprezzarla: / “Puh! Uvaccia agra! / Può essere cosa da mangiarsi?”. / Spesso, chi non può ottenere / una cosa che desidera, / sfoga il suo dolore / con lo screditarla”.

Nel testo di Gangi si colgono alcune caratteristiche che rendono la sua “riscrittura” molto libera, personale e colorita.
Anzitutto, della volpe vediamo subito gli occhi “spinti verso l’aria” per la grande fame, in cerca di cibo; ecco poi l’immagine invitante della “bella racìna nìura” (“bella uva nera”): tanto importante e allettante è questa immagine da anticipare il predicato verbale “vitti” (“vide”): “bella racìna nìura / vitti”.
Subito dopo, il semplice “non poté toccarla” di Fedro (“quam tangere ut non potuit”) si trasforma in una considerazione della volpe delusa: “Bella, ma pri disgrazia / nun era tanta vascia”.
Una lunga aggiunta del poeta siciliano è poi la scena successiva, con la ricerca affannosa, da parte della volpe, di mezzi per arrivare all’uva; pur cercandoli, però, non riesce a trovarne nessuno (“circànnuli, nun n’àscia”, dove si trova il verbo antico “asciàri”, che significava “trovare, pervenire a quello che si cerca”).
Vengono poi descritti gli inutili “salti” dell’animale, che alla fine fa un bilancio fallimentare dei suoi tentativi: “tutti spisi ‘mmatula / canusci li so’ stenti” (dove quel “’mmatula” deriva da “ammàtula” che vuol dire “invano”).
A questo punto la volpe è “disfizziata” (cioè priva di “sfizio”, delusa e amareggiata): questo aggettivo efficacissimo è molto più descrittivo rispetto al semplice participio “discedens” (“allontanandosi”) di Fedro.
Molto contrariata, la volpe comincia a disprezzare la tanto agognata uva; ma se nel poeta latino c’era solo una considerazione conclusiva (“Nondum matura est; nolo acerbam sumere”), qui si ha una vera e propria imprecazione rabbiosa: “Puh! Racinazza àghira! / chi è cosa di manciari?”; l’uva bella e gustosa diventa una “racinazza àghira”, una “uvaccia aspra” che non merita alcuna lode.
La morale conclusiva amplifica quella di Fedro (il cosiddetto “epimythion”, posto alla fine della favola): l’antico favolista si limita a dire che la favola riguarda coloro che sminuiscono le cose che non riescono a fare, mentre Venerando Gangi è più circostanziato e didascalico: “Spissu cu’ nun po’ ottèniri / ‘na cosa ca disija, / ccu mèntila in discrèditu / la pena so’ sfrazzija». Qui il verbo “sfrazziàri” ha il valore di “dissimulare”: “mettendo in discredito” (cioè svalutando) l’oggetto del proprio desiderio, si riesce a “dissimulare” meglio la pena e il dolore per l’obiettivo non raggiunto.
P.S.: Nel 1976 mi è venuto in mente di musicare questa antica lirica siciliana; allora creai una semplice melodia, con qualche ironico gorgheggio semiecclesiastico, e la eseguii al piano. Chi non ha proprio di meglio da fare e volesse sentirla, la trova qui su YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=T2pOxiph0nU.
