In un fascicolo di cento anni fa, pubblicato dal Teatro “Carlo Felice” nel 1925, sono riportate le notizie sulle opere in programma nella stagione 1925-1926 (chi fosse interessato può trovarle in questo blog, https://pintacuda.it/2025/05/11/cento-anni-fa-la-stagione-lirica-1925-1926-del-teatro-carlo-felice-di-genova/.
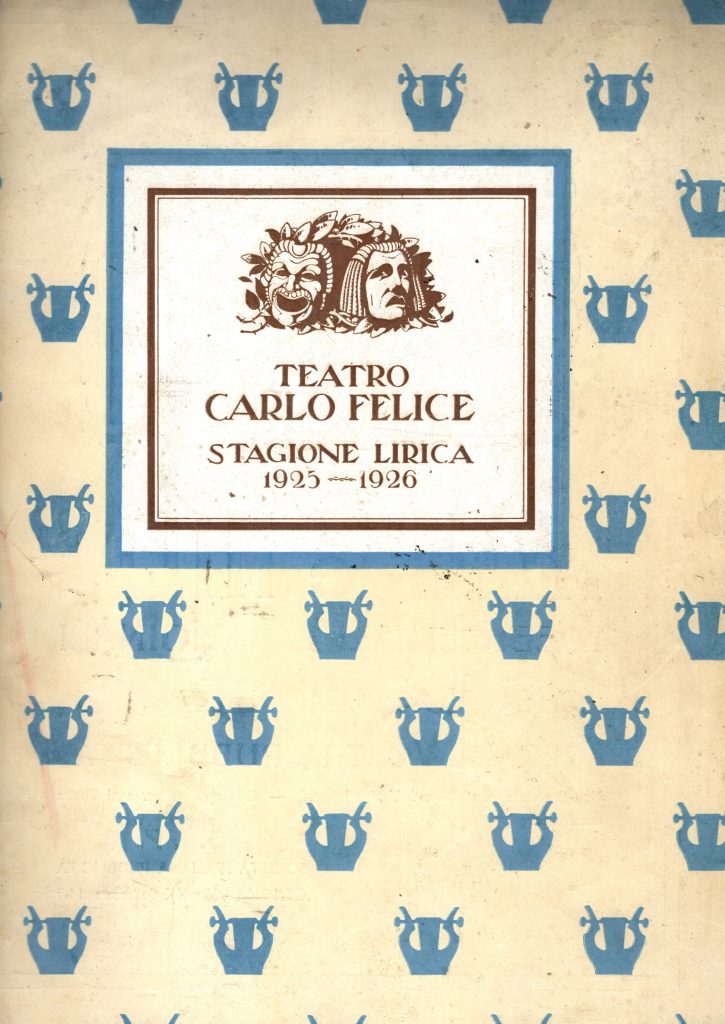
Fra gli articoli di presentazione, è interessante quello relativo all’opera lirica “Fauvette” del compositore e direttore d’orchestra genovese Domenico Monleone (1875-1942), che esordì al “Carlo Felice” il 2 marzo 1926.
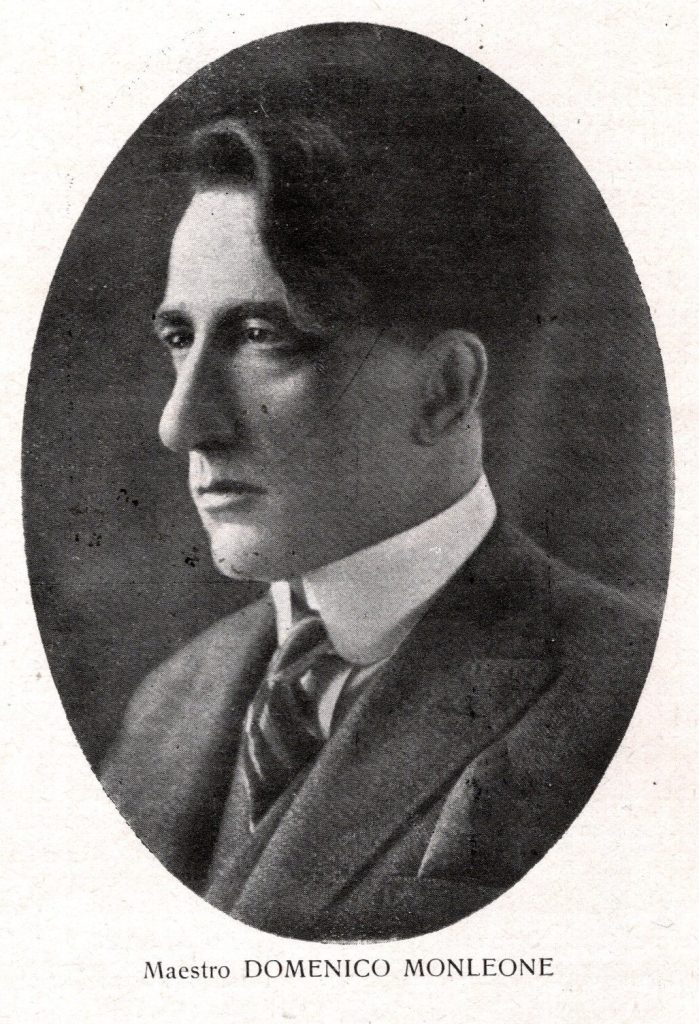
Monleone era già noto per aver musicato nel 1907 una “Cavalleria rusticana” che, per un breve periodo, aveva tenuto testa al successo dell’omonima celeberrima opera di Pietro Mascagni; tuttavia, a causa di una controversia legale con Mascagni e i suoi avvocati, l’opera di Monleone fu interdetta in Italia e in altri Paesi; Monleone tuttavia riutilizzò la sua musica adattandola a un nuovo libretto. All’inizio di questo secolo la “Cavalleria rusticana” di Monleone ha conosciuto un revival, con rappresentazioni e trasmissioni radiofoniche in Albania e in Francia (Montpellier 2001); nel complesso Monleone è considerato una figura significativa del panorama musicale italiano del primo Novecento, anche se la sua fama è stata in parte oscurata dalla vicenda giudiziaria legata all’opera di Mascagni.
Una notizia curiosa è che Monleone compose in seguito un’opera buffa intitolata “Schêuggio Campann-a”, una delle rare opere liriche in dialetto genovese, che fu rappresentata al “Carlo Felice” il 12 maggio 1928 su libretto di E. Canesi e A. Martinelli (da una commedia dello stesso Canesi per Gilberto Govi); in quest’opera il “colore” genovese è reso mediante il ricorso alle cantilene popolari e ai tipici “trallalleri”.
Il musicista genovese è oggi sepolto nel cimitero monumentale di Staglieno.
L’opera “Fauvette”, che fu rappresentata a Genova nel 1926, è ambientata a Parigi; la sua vicenda richiama per atmosfera e tematiche “La Bohème” pucciniana, presentando storie di giovani artisti e amori infelici in un contesto parigino. “Fauvette” fu particolarmente apprezzata da critica e pubblico per la bellezza dei declamati melodici e per la delicatezza della strumentazione, pur evidenziando una certa uniformità nei colori orchestrali. L’opera mostra una vena melodica di stampo pucciniano, con un’analoga cura nell’orchestrazione.
Ritengo interessante trascrivere qui di seguito le parti essenziali dell’articolo, che è firmato Mario Panizzardi (che fu giornalista, pubblicista e profondo studioso di Wagner), poiché forniscono notizie ormai di rara accessibilità (ad es. la trama dell’opera), che possono essere utili agli studiosi di Storia della Musica e di Storia genovese.
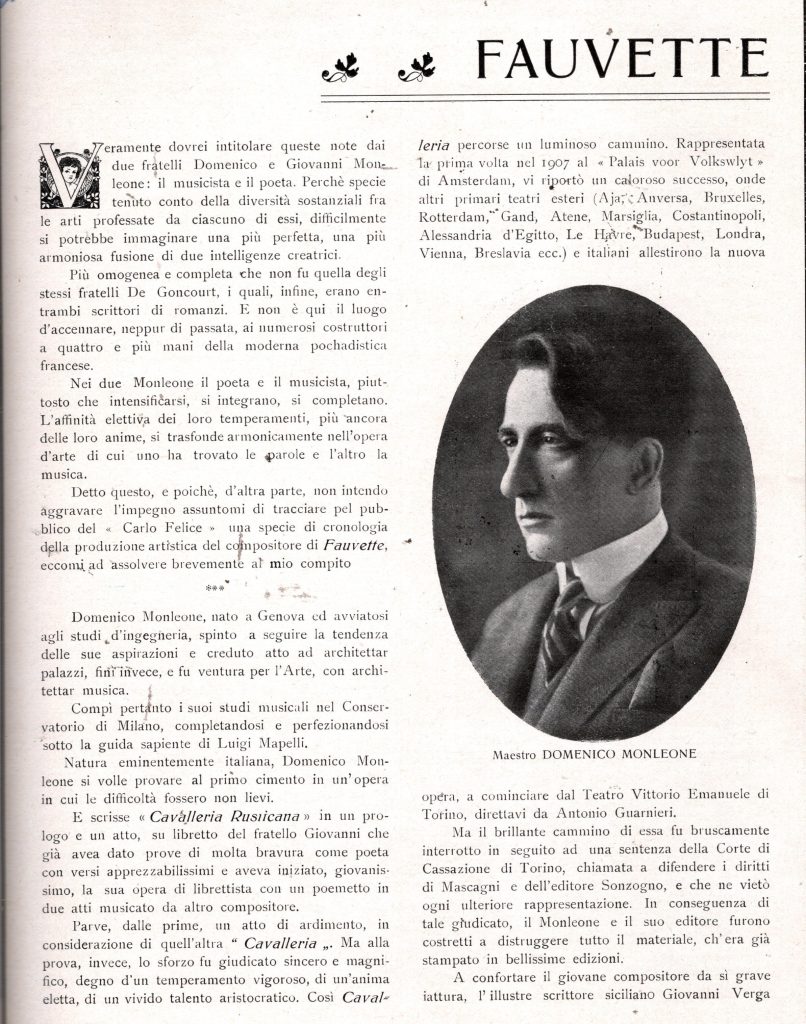
«Domenico Monleone, nato a Genova ed avviatosi agli studi d’ingegneria, spinto a seguire la tendenza delle sue aspirazioni e creduto atto ad architettar palazzi, finì invece, e fu ventura per l’Arte, con architettar musica. Compì pertanto i suoi studi musicali nel Conservatorio di Milano, completandosi e perfezionandosi sotto la guida sapiente di Luigi Mapelli. Natura eminentemente italiana, Domenico Monleone si volle provare al primo cimento in un’opera in cui le difficoltà fossero non lievi. E scrisse “Cavalleria rusticana” in un prologo e un atto, su libretto del fratello Giovanni che già avea dato prove di molta bravura come poeta con versi apprezzabilissimi e aveva iniziato, giovanissimo, la sua opera di librettista con un poemetto in due atti musicato da altro compositore. Parve, dalle prime, un atto di ardimento, in considerazione di quell’altra “Cavalleria”. Ma alla prova, invece, lo sforzo fu giudicato sincero e magnifico, degno d’un temperamento vigoroso, di un’anima eletta, di un vivido talento aristocratico. Così “Cavalleria” percorse un luminoso cammino. Rappresentata la prima volta nel 1907 al “Palais voor Volkswlyt” di Amsterdam, vi riportò un caloroso successo, onde altri primari teatri esteri […] e italiani allestirono la nuova opera, a cominciare dal Teatro Vittorio Emanuele di Torino, direttavi da Antonio Guarnieri.
Ma il brillante cammino di essa fu bruscamente interrotto in seguito ad una sentenza della Corte di Cassazione di Torino, chiamata a difendere i diritti di Mascagni e dell’editore Sonzogno, e che ne vietò ogni ulteriore rappresentazione. In conseguenza di tale giudicato, il Monleone e il suo editore furono costretti a distruggere tutto il materiale, ch’era già stampato in bellissime edizioni.
A confortare il giovane compositore da sì grave iattura, I’ illustre scrittore siciliano Giovanni Verga consentì di collaborare col fratello del musicista ad un nuovo libretto, ed ecco in qual modo. La “Novella Rusticana” del Verga, che riproduce con la vivacità propria della penna del geniale novelliere la costumanza della “sacra rappresentazione” nei paesi di Sicilia, offrì, in origine, lo spunto a Giovanni Monleone per tracciare una trama, molto sommaria, per un’opera e la trasmise al Verga per la sua approvazione. Il Verga la modificò profondamente, aggiunse qualche altro spunto e la restituì incoraggiando il librettista a sceneggiarla e a metterla in versi. Ed è per questo che il Verga può dirsi un vero collaboratore al libretto, dando ai due fratelli Monleone una dimostrazione di solidarietà dopo la sfavorevole sentenza per la “Cavalleria Rusticana”.
L’opera intitolata “Il Mistero”, quinta nell’ordine cronologico della produzione artistica di Domenico Monleone, fu rappresentata nel Maggio 1921 alla “Fenice” di Venezia, protagonisti Aureliano Pertile, Mariano Stabile, Mercedes Llopart, ed ivi, come poi, al “Verdi” di Firenze e successivamente in Germania e nel Belgio tradotta in tedesco e in francese, riportò il più lusinghiero successo.
La seconda opera venne composta dal maestro Monleone per incarico del Municipio di Genova nella ricorrenza cinquantenaria della spedizione dei Mille in Sicilia, su libretto di Giovanni Monleone. Gli autori non chiesero argomento ad una favola di melodramma, ma solo si proposero di dar vita scenica ai frammenti di un’epopea che dal sangue dei Bandiera e di Pisacane ebbe viatico di martirio per le future Vittorie. […] “Alba eroica” venne eseguita nel 1910 al “Carlo Felice”: la critica concordemente ravvisò nel suo autore i caratteri e gli elementi di un vivo e forte temperamento di artista. […]
Prima del “Mistero”, di cui ho già accennato sopra, venne “Suona la ritirata”, andata in scena al “Lirico” di Milano nel 1916 e subito dopo al “Vittorio” di Torino e al “Carlo Felice” nel ’21. Il soggetto è tratto dal noto dramma “La retraite” di F. A. Beyerlein, e la forte drammaticità delle situazioni è commentata con grande efficacia da una musica sempre appropriata e robusta, in cui la nobiltà dell’ispirazione trova adeguata rispondenza nella ricchezza elaborata dello strumentale.
Del resto, per racchiudere in una breve sintesi le qualità molteplici dell’insigne compositore genovese, diremo che nelle varie opere del Monleone la sua tempra si è rivelata creatrice ed originale di stile e di concezione prettamente italiane.
La sua musica possiede gagliardie d’espressioni e di colori insieme con la potenza delle passioni e le finezze del sentimento. In tutte le sue opere, apprezzate in Italia ed all’Estero, il Maestro ha manifestato geniale ispirazione, tecnica sapiente ed elegante, senso aristocratico del dramma musicale moderno, senza velleità di imita zioni e senza scatti di effetti volgari. […]
Nella quiete serena della sua villa di Rapallo l’artista piega la mente e il suo cuore ai sogni più belli e più arditi del rinnovato teatro italiano. E tra il mare multisonante e i giardini variopinti, Monleone non vive che per questo ideale, non è turbato che dalla febbre di accrescere splendore alla fortuna della musica nazionale. In lui insomma è incessante il tormento della battaglia. […]
Ed eccoci a “Fauvette”, la nuova opera di Domenico Monleone, anche questa su libretto del fratello Giovanni. “Fauvette” è in tre atti e quattro quadri.
L’ azione si svolge a Parigi e dintorni, durante il secondo Impero, il cui ambiente politico, artistico e letterario è reso dal librettista con tocchi sobri e felici. Nella pittoresca solitudine di Issy, nella gaiezza di un sole primaverile, Gil, giovine pittore esordiente, lavora ad una sua tela, mentre voci lontane si odono sulla Senna: “Del vento sei respiro – Amore! Del fiore sei olezzo – Amore! Del labbro sei sospiro – Amore! Amore!”. Per il suo Gil sogna Fauvette luce di gioia, luce d’aurora. Ma il povero artista vede tetro e senz’alba il suo cammino. Ed ecco l’amico Bernard annunciargli la visita del grande critico Gastone Lacroix “colui che in un giorno può fare una fama”. II cuore di Gil si riapre alla speranza e la gioia di lui e di Fauvette viene come ad estrinsecarsi in un geniale intermezzo comico determinato dal sopraggiungere sulla scena di tre bizzarri personaggi: Gambin, Gregoire e Peyronnet, nei quali il poeta ha felicemente sintetizzato tutto un ambiente d’artisti pieni di talento, ma assillati dal pensiero del domani. La gioconda scena è interrotta dall’arrivo di Lacroix accompagnato da Bernard, e da alcuni discepoli fanatici. Il celebre critico d’arte, dopo aver osservato con aria d’uomo superiore ed autorevole i dipinti di Gil, pronuncia freddamente la sentenza sfavorevole: “È arte sorpassata / e non arriverà…”. Il povero Gil, mentre la luce del crepuscolo copre d’un velo roseo gli alberi fioriti, ricade nella sua tetra disperazione… Ma Fauvette lo incoraggia: “Tu vincerai: più che la sorte / sia forte il tuo volere”. La voce buona placa ed accarezza l’anima addolorata…
L’atto secondo si svolge a Parigi alcuni anni dopo il precedente. L’artista è ormai celebre. Nel fantastico disordine di un “atelier” parigino Delhi, il servo indiano di Gil, è fatto segno a scherzi salaci da parte di giovani ed avvenenti modelle. Bernard reca a Fauvette la notizia di un nuovo trionfo di Gil al Salon, La Principessa Matilde e tutto il suo “entourage”, la pleiade gloriosa di cui fanno parte Sainte-Beuve, Dumas, Gautier, Merimée, ha reso omaggio al trionfatore. Ma la povera Fauvette nel segreto del suo cuore si sente triste e smarrita; più il suo adorato sale, più si sente piccina e si reputa inutile vicino a lui così grande: “Oh, casetta d’Issy, / dolce nido d’un giorno: / nido d’un sogno breve / che faceva bello e ridente / come un mattin di maggio / lo stesso soffrire!”. Così, più tardi, dopo un altro brioso intermezzo dei tre “bohémiens”, quando la leggiadrissima ed elegante marchesina Flora di Chateaublanc, col pretesto di posare davanti al celebre pittore, cerca di esercitar su lui tutto il fascino della sua eleganza e della sua bellezza, Fauvette che, inosservata, ha assistito alla scena della seduzione, si toglie dal seno un mazzolino di fiori avvizziti e dopo averlo baciato, lascia cadere quel ricordo d’amore, allontanandosi per sempre dalla casa, in cui le sembra d’essere diventata un’ intrusa.
Nel primo quadro dell’atto terzo siamo nel giardino del Castello di Compiégne. È la grande “Rivista” inscenata dalla Principessa di Metternich. Si sussurra che la Contessa di Castiglione apparirà in un’azzurra visione e ballerà una danza di nuovo stile. Scende dalla scala uno stuolo di fanciulle dalle chiome infiorate: sono le Cocodettes, damigelle d’onore dell’imperatrice Eugenia, Sua Maestà Andalusa. Cantano facendo languidi movimenti di danza, e in quelle forme ammaliatrici rivive l’incantesimo eterno. Primavera di cuori! Dolce coro, che aspetta in cielo il bacio d’una stella! In mezzo a tante seduzioni il fedele amico Bernard annuncia a Gil che Fauvette malata lo desidera. Eugenia, la bionda imperatrice, appare in tutto lo sfarzo regale, ma Gil col cuore va incontro all’angiolo che ritorna e saluta la speranza rifiorita sulla soglia dell’anima.
È l’ultimo quadro: la stessa scena del primo atto. L’autunno ha ingiallito la campagna; sui prati e sulla Senna ondeggiano le voci vaghe della notte brumosa, che si spengono in lontani echi di tristezza… Così va spegnendosi la vita di Fauvette. Ella raccomanda a Gil il bambino, frutto del loro amore, fiore tra i fiori… e s’abbandona inerte. Un raggio di sole illumina il suo volto che si ricompone nella serenità dalla morte. È il sole che la cerca e la bacia…
A proposito del libretto di Fauvette ci piace riportare quanto ne scrisse, per il primo, l’illustre Maestro Lorenzo Parodi (sul “Caffaro” del 25 ottobre 1925): “In questo dramma rivive con alto soffio di poesia l’eterna tragedia dell’anima. Non è l’arruffato e farraginoso lavorio di certi libretti d’opera che possa rendere bene questa intima psicologia che non vuole eccessivi colpi di scena e ornamentazioni barocche, fantastiche. Il martirio segreto dei cuori tanto più è sublime quanto più è semplice e non artificioso. Fantasmi che l’anima sogna, fatte] degli anni desolati, giovinezza sfiorita nei tormentosi conati dell’ideale!… E quando pur sia giunto il fastigio della gloria, il dolore batte ancora alla porta dell’anima per insegnare ch’esso deve essere l’estremo compagno dell’artista per rendere più puro il suo ingresso nel]’ immortalità. La gloria aleggia allora bianca, pura, vittoriosa!”
MARIO PANIZZARDI (1925)
