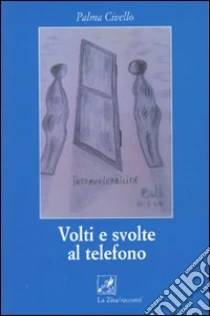La mia cara amica Palma Civello (per noi “Mirella”), poetessa, scrittrice, pittrice, docente, fotografa, versatile mente creatrice e immaginifica, ha pubblicato diverse opere di narrativa (come “Voltie svolte al telefono” nel 2008 e “Nodi di donne” nel 2011) e raccolte di poesia (“Ho liberato le parole” nel 2011 e “Come tela di Penelope” nel 2018).

Una sua “Intervista ad Arianna” è stata inserita nel vol. III di “Grecità – Storia della letteratura greca”, che ho pubblicato con Michela Venuto per l’editore Palumbo (Palermo 2014). Ha ottenuto e continua ad ottenere numerosi premi letterari, che premiano la sua produzione mai banale, frutto di una riflessione profonda e originale.
Il primo volume di racconti di Palma, intitolato “Volti e svolte al telefono”, fu edito da La Zisa nel 2008. In quell’occasione, mi capitò di buttare giù (a mo’ di maldestra recensione) alcune osservazioni su quel testo che mi era sembrato subito interessante e accattivante.
A quei tempi rifuggivo da ogni “social” e quindi queste righe non sono mai state pubblicate; lo faccio ora, nella convinzione e nella speranza di fornire un quadro adeguato di un’opera sicuramente degna di attenzione.
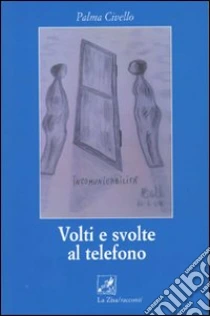
“VOLTI E SVOLTE AL TELEFONO”
Il libro di un autore esordiente, in qualunque momento della sua vita avvenga l’esordio, è esposto a rischi non indifferenti.
Anzitutto c’è il pericolo che si slitti nel facile autobiografismo, nella semplice e meccanica riproposizione, magari abbellita e idealizzata e ripensata, del proprio vissuto.
Poi c’è spesso un palese impaccio, una carburazione ancora difficile, un difficile equilibrismo fra parti narrative e parti dialogate, fra narrazione in prima persona e in terza.
Si aggiunge poi la difficoltà nella scelta del registro espressivo, del linguaggio: correttamente tradizionale? “parlato” e colloquiale fino alla sgrammaticatura? con o senza uso della punteggiatura?
Ancora, emerge a volte un certo desiderio di strafare, di dire tutto e subito, di buttare nelle pagine della propria scrittura tante, troppe istanze a lungo sedimentate e meditate, magari facendo cozzare fra loro istanze divergenti e inconciliabili.
Ma a questo rischio sfugge il libro Volti e svolte al telefono dell’esordiente Palma Civello. Non c’è traccia di facile autobiografismo, nei sei racconti che lo compongono. Certo, si indovina l’estrema sensibilità dell’autrice e chi ben la conosce può andare a scoprire con la lente di Sherlock Holmes alcuni dettagli personali subliminali: “aveva una voce ben impostata da soprano che le aveva dato discrete soddisfazioni, ma un serio problema alle corde vocali l’aveva costretta ad abbandonare i suoi sogni” (p. 109).
Ma le donne di questi racconti non sono Palma Civello, pur essendone chiaramente un’emanazione, pur essendo parte dei suoi pensieri, pur essendo creature della sua mente feconda di intuizioni.
Semmai, ognuna di esse ha qualcosa di lei, ma più in generale ha qualcosa di qualsiasi donna, sentimenti, sensazioni, potenzialità represse, frustrazioni che possono esplodere in modo anche estremo:
1) la donna indaffarata in cento mansioni (“prendi, corri, telefona, prepara, dormi, svegliati, lavora, riposati e poi alzati e gira e corri ancora, ancora”, p. 13; mirabile esempio di periodo asindetico);
2) la donna un po’ scissa (“era la Magda che da un po’ di tempo si era insinuata, si era affacciata, che tentava disperatamente di farsi sentire, che si dimenava, che tentava di prendere consistenza, mentre l’altra Magda, quella ‘perfettina’, l’aveva messa a tacere, l’aveva narcotizzata”, p. 21);
3) la donna che vuole buttare fuori tutto quello che si è abituata a tenere dentro (“gli riversavo sopra valanghe di parole, di emozioni, parlavo a raffica senza pause, con respiri corti e veloci per poter dire tutto quello che mi agitava dentro e che cominciava a venir fuori”, p. 48);
4) la donna che vuole essere “visibile”, esistente, non trasparente, non dimenticata, non vittima di una mortificante e falsa routine (“Da quanto tempo più nessuno mi chiedeva come stavo! Sì, quanti lo chiedono, ma è solo una domanda di routine, frettolosa, che si fa per un usuale inizio di conversazione e dalla quale ci si attende la solita scontata risposta che neanche si ascolta”, p. 49);
5) la donna che fa bilanci, spesso impietosi, con lucida razionalità (“la sua vita era sempre stata una barca che faceva acqua da tutte le parti, ma se ne era resa conto decisamente tardi: allora aveva cercato di otturare quelle falle che aveva potuto, ma ormai il danno maggiore era avvenuto”, p. 59);
6) la donna che reagisce violentemente, che dà un taglio a tutto, come Ilaria, che nel racconto omonimo, emula di Mattia Pascal, cambia vita, nome, taglio di capelli (p. 124);
7) la donna capace di organizzare in modo freddo e scientifico la sua crudele vendetta contro l’uomo che l’ha ingannata (p. 75).
Se tutte queste donne sono, in parte, espressione, oggettivazione, manifestazione del pensiero dell’autrice, gran parte del suo reale mondo interiore è però volutamente accantonato, escluso da questi racconti.
Di ciò è prova un elemento fondamentale: in tutto il libro non compare mai la parola “Dio”, non c’è mai un riferimento alla fede, alla milizia cristiana, alla speranza escatologica. E dire che l’autrice ha una fede profonda, non banale, non esteriore, non occasionale: chi la conosce sa che il suo è impegno di fede forte, reale, costante, solido nel rapporto con gli altri e per gli altri, nella donazione altruista di sé; e anche l’amico cui il libro è dedicato è uomo di fede.
Questa “rimozione”, certo voluta, di un dato personale di tale portata deve fare riflettere sul concetto di autobiografismo che citavamo all’inizio.
Palma Civello si è annullata nei suoi personaggi, ha dato loro una vita autonoma, ne ha fatto delle creature di carne, sangue ed anima, diverse da lei, forse collegate e collegabili a lei, ma indipendenti. E la rimozione dell’elemento “fede”, ribadita dal mesto quadro della stessa autrice riportato in copertina (“Incomunicabilità”), serve probabilmente a chiarire a monte perché questi personaggi siano così tormentati, forse cinici, a volte addirittura perfidi.
È un mondo in cui Dio è assente o totalmente dimenticato; e la Sua mancanza si percepisce nella desolata quotidianità di un mondo arido e meccanicistico, in cui prevale un’angoscia sottile, pungente, lancinante: “Il buio. Quella parola risuonò nella mente di Magda come una sirena che ti sveglia la notte, di soprassalto, e non capisci cosa è perché non sei ancora pienamente cosciente, e allora il cuore comincia a battere all’impazzata e allunghi le mani per ripararti da qualcosa che ti stia assalendo, finché non ti rendi conto che è solo una sirena che ti ha svegliato nel cuore della notte. Ma il cuore ormai è impazzito…” (p. 17).
Il telefono è il Leit-motiv dei racconti, fortemente evidenziato dal titolo stesso della raccolta. Ma è rilevante, nel titolo, il collaterale concetto di “Volti e svolte”.
I personaggi dei sei racconti subiscono una modifica della loro vita, una “svolta”, che parte in ogni caso da un elemento “telefonico”:
1) Matteo che chiama Magda conosciuta per caso tempo prima al cinema dove era andata solo per piangere in Squilla il telefono;
2) i perfidi e misteriosi SMS che l’informatore scientifico Cris riceve a centinaia nel suo cellulare in SMS;
3) il cellulare smarrito da Cloe e ritrovato da un Angelo incarnato in Cellulare smarrito;
4) la telefonata di Ermione al suo carnefice-vittima Carlo nell’hitchcockiano Delitto al telefono (avrà ricordato, l’autrice, la telefonata di Grace Kelly al marito-carnefice Ray Milland in Delitto perfetto del 1954?);
5) il numero di telefono del tamponatore Leandro che dà avvio alla storia romantico-decadente di Effetti collaterali di un cellulare;
6) fino ad Ilaria, la venditrice di cellulari che lascerà squillare invano il cellulare per rendersi, finalmente, irreperibile, irraggiungibile, indisponibile, inarrivabile.
In tutti i racconti i “volti” dei personaggi sono spesso all’inizio maschere pirandelliane, apparenti; sono un’apparenza tenace, consolidata dai pregiudizi. Ma questi volti-maschera diventano sempre più autentici e comprensibili man mano che i muri, accidentalmente o meno, sono abbattuti; man mano che le difese erette, le rocche innalzate, le fortezze blindate, crollano, si afflosciano come castelli di carte.
Non sfugga poi che è un vero ossimoro concettuale, quel termine “volti” collegato al telefono. Infatti al telefono i volti non si vedono (non fanno ancora testo, e comunque non stanno avendo forse il successo commerciale sperato, le “videochiamate”), ma si immaginano. È quello che diceva Fellini: “Nulla si sa; tutto si immagina”.
E il telefono è arma a doppio taglio, esaltazione e poi annullamento della fantasia e dei sentimenti, che può rivelarsi, dopo mille illusioni, semplice “veicolo di parole”: “avevamo affidato ad un cellulare tutto di noi: la nostra storia, le nostre vite, i nostri pensieri; avevamo pensato che un cellulare sarebbe bastato a tenerci stretti. Ma un cellulare è solo un veicolo di parole, non può sostituire lo stare insieme, l’incontrarsi, il guardarsi negli occhi, non può far abituare gradatamente al cambiamento inevitabile che ognuno di noi fa” (p. 101).
Rileviamo qui un altro dato significativo: oggi il telefono si scinde ormai in due entità ben diverse, il telefono fisso e il telefono cellulare, l’uno con fili l’altro privo di fili. E quei fili divengono metafora di una contorsione mentale, psicologica, di un nodo che avvince ed incatena: “E poi quel filo così corto, così aggrovigliato, che dà fastidio solo a guardarlo, che ti rimanda l’immagine dei casini che è la tua vita… Nella sua testa, ormai da troppo tempo, rincorre fili che si spezzano prima che possano prendere vita, a volte invece si intrecciano e non riesce più a dipanarli, fili che non pensava potessero esistere, che nessuno sospetta possano esserci nella sua testa”, pp. 14-15).
D’altro canto il cellulare è creatura effimera, smontabile, rimovibile, neutralizzabile come il computer Hal al termine del celebre film di Kubrick “2001 – Odissea nello spazio”: “allora smontai il cellulare, tolsi la scheda, la batteria, tolsi la vita che aveva, così come lui l’aveva tolta a me e lo nascosi come a volerlo soffocare per sempre” (p. 101).
Quanto alle “svolte”, esse sono attese, auspicate, evocate quasi, dai personaggi dei racconti: alcune risultano illusorie, ma altre sono concrete e definitive. Le svolte esistono, paradossali, imprevedibili; ma esistono. E proprio un oggetto come il telefono ha un potere incredibile, fino a instillare nei personaggi un desiderio di “telefonificazione”, di immedesimazione con l’oggetto carismatico e di annullamento della propria identità di cartapesta: “pensa che le piacerebbe essere un telefono, perché un telefono, anche piccolissimo, riesce a possedere tutti, anche i potenti, li tiene avvinghiati, dipendenti, succubi del suo potere e del suo fascino, mentre lei, la libera Magda, la forte Magda, è posseduta da tutti, lei, l’incrollabile Magda, non sa più dove sta andando” (p. 15).
Tanta carne al fuoco, dunque, nel breve volgere di 124 pagine. Sono racconti che si bevono d’un fiato, gustandone la costruzione sapiente e l’architettura narrativa.
L’autrice ha il dono dell’ironia, come quando descrive (forse su input di un familiare…) gli informatori scientifici: “faceva l’informatore scientifico, ma lui si autodefiniva venditore di sogni: non si vendono sogni, o forse illusioni, quando te ne vai in giro a pubblicizzare una nuova medicina che ha soppiantato quella precedente o tenta di soppiantare quella della casa farmaceutica avversa, e che ti promette di guarire tale e tal’altra malattia?… Fatti salvi tutti gli effetti collaterali che sembravano messi solo per terrorizzare quei poveri malati…” (p. 26); oppure quando descrive il destino delle commesse: “mi sento chiamare col solito: ‘signorina!’ che mi fa sorridere, perché sembra che le commesse non abbiano mai una loro identità, un’età, una storia, ma siano tutte uguali, tutte ‘signorine’” (p. 83); o ancora quando riesce a descrivere in modo impagabile la cura esteriore del personaggio maschile nell’aggiustarsi il nodo della cravatta e nel lisciarsi (alla Sgarbi?) i capelli (p. 30).
Ma Palma Civello è anche scrittrice dalla venatura “gialla”, capace di architettare trame da thriller noir, con una punta di esplicito civettuolo compiacimento: “avrebbe trovato il bandolo di quella matassa degna di un racconto dell’assurdo di Beckett” (p. 34). E soprattutto in Delitto al telefono la protagonista si trasforma gradualmente da creatura “insignificante” a micidiale dark lady.
C’è poi l’abilità icastica nelle descrizioni, vere “pennellate” che ricordano l’altra vena artistica della poliedrica autrice palermitana: “Rimasi qualche istante ad osservarlo: capelli rossi con sfumature tendenti al biondo, una corporatura esile – per quanto potevo vedere dalla sua posizione seduta -, stranamente niente lentiggini, occhio castano tendente al giallo, sguardo dolcissimo e nello stesso tempo pensoso” (p. 46). – “Non era mai stata bella, a dispetto del suo nome che evocava lineamenti e profili classici e statuari. L’immaginario veniva subito smentito non appena la si conosceva: una donna qualunque con niente che meritasse di essere notato. Non era proprio brutta, semmai insignificante e questo per lei forse era anche peggio” (p. 57).
C’è anche la spiccata predilezione per il discorso indiretto (“Gli chiesi se lavorava: mi rispose che faceva il reatauratore…”, p. 87; “Un giorno mi disse che aveva parlato di me alla sua famiglia e che erano felici per lui…”, p. 90; “le chiese solo il nome e se lo appuntò s un’agenda che era su un tavolo all’ingresso. Arial Lai”, p. 113).
Non che manchino i discorsi diretti (agghiacciante quello di p. 74 fra Carlo e la stavolta dannunziana Ermione), ma sono meno frequenti; e questo perché spesso le battute “dirette” sono filtrate dal ragionamento e dal ripensamento, diventano perciò “indirette” come per lasciarle decantare. Il discorso indiretto civelliano è anch’esso metafora dell’incomunicabilità, di un parlarsi che spesso è parlarsi addosso, parlarsi per finta.
C’è qualche sicilianismo: la “carpetta” dell’ingegnere a p. 64 (ma il termine non esiste nel dizionario italiano), la costruzione transitiva di “scendere” a p. 80 (“Devo scendere dall’anta superiore gli abiti invernali”), o anche il “Volevano fatte… foto-ricordo” di p. 44 e gli anni “che si toglievano” i due fratelli a p. 84… Ma l’italiano regionale è ormai consolidata conquista letteraria (Camilleri docet) e nessuno troverà da ridire su queste espressioni, che sono anzi colorite e simpatiche.
Raccomandare la lettura di un libro così stimolante ed intrigante è a questo punto quasi superfluo. Vi si avverte la profonda cultura, la sensibilità, l’intelligenza dell’autrice; ma soprattutto si sente profumo di realtà, di vita, di passioni ed emozioni. E scusate se è poco, in un mondo arido e sbadato come il nostro…
MARIO PINTACUDA
18 giugno 2008