Sino alla legge n. 517 del 4 agosto 1977, il 1° ottobre era in Italia la data di inizio di tutte le scuole. Dato che nella giornata odierna si celebrava San Remigio di Reims, i bambini di prima elementare erano detti “remigini” (ora la Chiesa ha spostato la ricorrenza al 13 gennaio: sic transit gloria sanctorum).
Il calendario scolastico era di “soli” 170 giorni (circa). Per di più, durante l’anno scolastico non mancavano le vacanze: la prima era già il 4 ottobre, festa per il patrono d’Italia, San Francesco. A novembre alla festa dei Santi si univa anche la vacanza per i Morti e la festa delle forze armate del 4 novembre. A dicembre c’erano (come ora) la festa dell’Immacolata e poi le vacanze natalizie fino all’Epifania compresa. Dopo gennaio, oltre alle vacanze pasquali, si restava a casa l’11 febbraio (Patti lateranensi), il 19 marzo (S. Giuseppe), l’Ascensione e il Corpus Domini (due giovedì). Come oggi, c’erano le festività laiche del 25 aprile, del 1° maggio e del 2 giugno. Naturalmente, nei comuni fortunati (non come Genova e Palermo) non mancava la festa del S. Patrono. Le lezioni terminavano intorno al 10 giugno.
Chi osasse affermare che, nonostante i tanti giorni di scuola in meno (ammesso che i 205 giorni attuali siano davvero fatti tutti), alla fine dell’anno i ragazzi di allora uscissero più preparati e motivati, risulterebbe obsoleto, passatista, impopolare, politicamente e ideologicamente scorretto, scontato, disfattista, qualunquista e chi più ne ha più ne obietti. Mi guardo dunque bene dal dirlo, limitandomi a pensarlo, se non altro per continuare cartesianamente ad esistere.
Io iniziai la scuola elementare il 1° ottobre del 1959 alla scuola elementare “Giovanni Carbone – Maddalena Pallavicini” di Genova, in via Luca Cambiaso 6.
I due personaggi cui era dedicata la scuola, sconosciuti a livello nazionale, avevano però notevoli meriti in campo cittadino. Giovanni Carbone era un patriota genovese che nel 1746, all’età di 22 anni, aveva partecipato all’insurrezione della città contro gli Austriaci, riuscendo a riconquistare le chiavi della città; aveva poi portato le chiavi a Palazzo Ducale, consegnandole al doge e ai senatori con alcune fiere parole: “Signori, queste sono le chiavi che con tanta franchezza loro Signori serenissimi hanno dato ai nostri nemici; procurino in avvenire di custodirle meglio, perché noi, col nostro sangue, le abbiamo recuperate”. Quanto a Maddalena Pallavicino, vissuta nel ‘500, fu una poetessa genovese, nobile, bella e colta (soprattutto in latino), autrice di rime e sonetti stampati a Lucca nel 1559 in una raccolta di Lodovico Domenichi (“Rime diverse d’alcune nobilissime et virtuosissime donne”).

Il 1° ottobre 1959 avevo cinque anni e mezzo, essendo nato nel mese di marzo; la legge allora non consentiva l’iscrizione al primo anno ai minori di sei anni, se non come “uditori”. Fui dunque affidato in prova al maestro Douglas Poggi (che aveva questo nome esotico perché figlio di un genovese e di una signora inglese). Il maestro disse ai miei genitori: “Vediamo come va”, tenendomi in classe in prova. Io ero reduce da una brutta e breve esperienza presso un asilo gestito da suore, dove mi ero ben presto stancato (anche perché sapevo già leggere e scrivere e mi seccava fare le aste).
Dopo pochi giorni (come mia madre mi raccontava sempre) il maestro chiamò i miei genitori, che si preoccuparono pensando che dovesse dare loro qualche brutta notizia (invitandoli magari a ritirarmi); ma Poggi disse: “Mi avete portato un gioiello”. E rimasi lì, frequentando il primo anno come uditore e facendo a fine anno un esamino di passaggio in II.

Il maestro Poggi, pelato in testa (come era mio padre e come poi sono diventato io), single, affettuoso quando doveva essere affettuoso e severo quando doveva essere severo, ci insegnò tutto quello che era possibile insegnare in una classe elementare di allora. Conservo alcuni quaderni con le sue correzioni e i suoi voti (in particolare quando dava un “bene” faceva una grande “B” corsiva che somigliava a un β greco). L’esempio di questo maestro, dedito agli alunni come pochi altri, sensibile, paterno anche se non era mai stato padre, giusto di una giustizia inflessibile, scherzoso quando c’era da scherzare e serio quando occorreva essere seri, mi è rimasto nel cuore e nella mente, indelebile; e in tutti gli anni della mia attività didattica il suo ricordo è stato sempre vivo e operativo in me.
Alle elementari conobbi Paolo Romei, che fu mio compagno di banco per 13 anni, dalle elementari alle medie al liceo; dopo il mio trasferimento in Sicilia ci siamo persi di vista, salvo poi a ritrovarci cinque anni fa (quando su insistenza di mio figlio ho trovato la forza di tornare a Genova), riscoprendoci amici come e più di prima (quest’estate abbiamo fatto una lunga scorrazzata nel verde dell’entroterra genovese, come ai vecchi tempi; e ci sentiamo quasi settimanalmente commentando le performances altalenanti del nostro Genoa).


Fra i compagni delle elementari ho recentemente ritrovato e rivisto anche Mario Guglieri, con cui restammo amici anche ai tempi dell’adolescenza.

Lui, Paolo e io eravamo stati nominati dal maestro Poggi “giudici” della classe. I tre “giudici” erano gli aiutanti del maestro (e io, futuro collaboratore di diversi presidi, ne trassi vantaggio imperituro), con alti incarichi organizzativi, didattici e amministrativi.
Conservo ancora diverse copie del giornalino della scuola, “Vita nostra”, con le notizie sulle iniziative dell’anno scolastico (ivi compresa la proiezione dei sussidi audiovisivi), raccontini e aneddoti, notizie varie e – soprattutto – articoletti degli alunni.
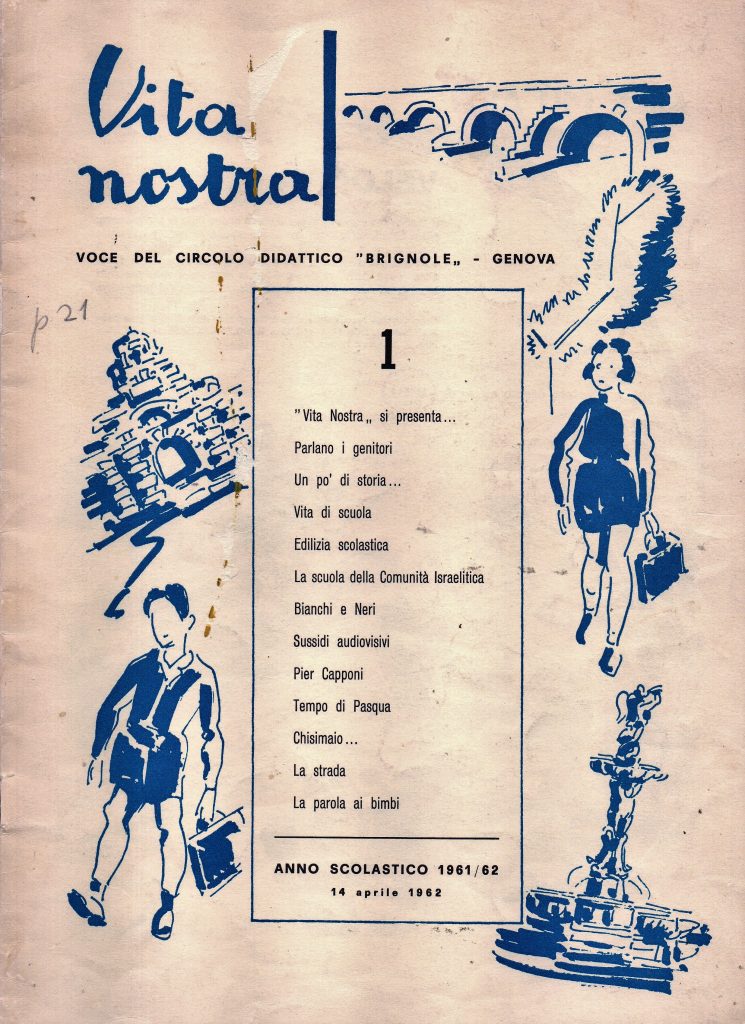
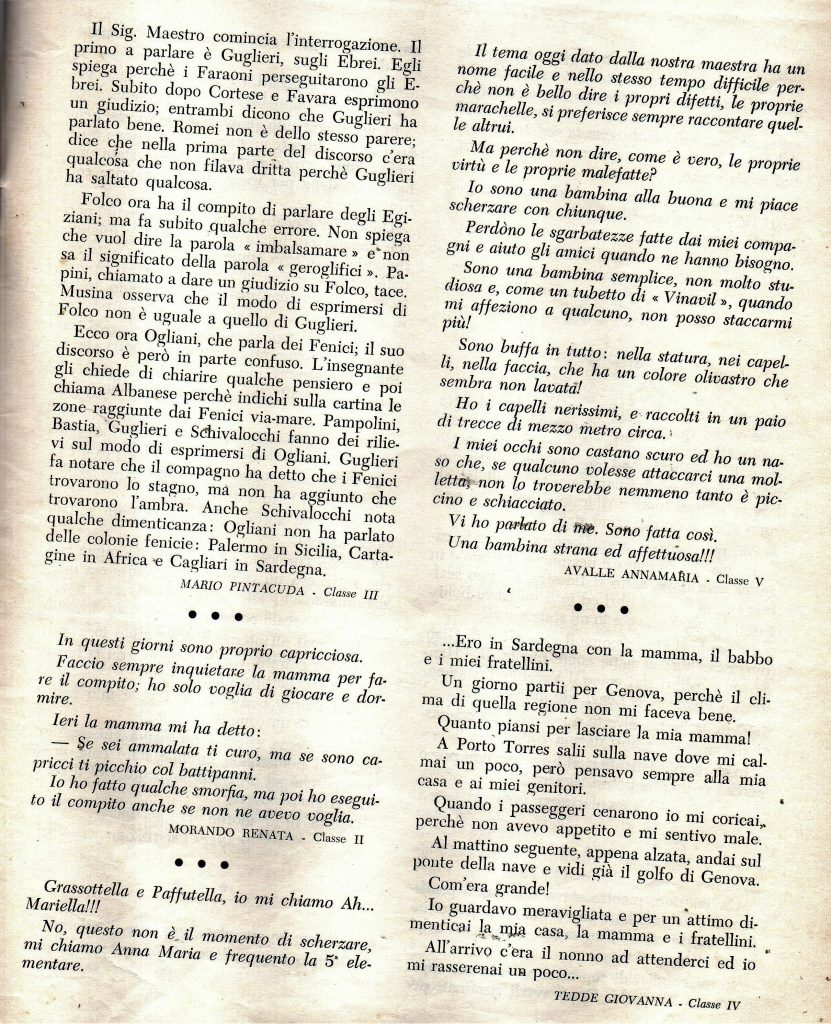
Nel n° 1 della rivista, risalente al 14 aprile 1962, si trova un mio articoletto che consiste in un verbale (fatto appunto in qualità di “giudice”) su un’ora di lezione in classe. L’esordio è quanto mai ufficiale: «Il mio sig. Maestro aveva assegnato all’intera classe il compito di spiegare, con parole proprie, la storia dei principali popoli che si stabilirono sulle rive del Mediterraneo, e cioè i Fenici, gli Ebrei, gli Egizi». Segue il fedele resoconto delle esposizioni di Guglieri, Romei, Folco, Papini, Musina, Ogliani, Albanese, Pampolini, Bastia e Schivalocchi; sono fedelmente riportati (ero un cronista oggettivo e incorruttibile) anche gli errori commessi dai piccoli relatori, le loro incertezze, il loro diverso modo di esprimersi. Oggi un maestro che osasse fare così sarebbe accusato di traumatizzare gli alunni, di metterli quasi l’uno contro l’altro, di sottoporli a grave stress valutativo. In realtà noi affrontavamo le prove che ci erano sottoposte senza turbamenti, abituandoci agli errori, alle correzioni degli errori, all’impegno, alla valutazione di noi stessi e degli altri, al dialogo con tutti, al senso di una giustizia operativa, perché anche i migliori, quando sbagliavano, venivano corretti e invitati a riflettere sugli errori commessi.
In quell’antica scuola elementare alcuni banchi, risalenti a prima della guerra, avevano un grosso foro sulla destra, un tempo destinato al calamaio; indossavamo tutti un grembiulino nero con il fiocco azzurro; in posizione di riposo stavamo con le braccia dietro la schiena; il bidello alle 12 veniva a dare il “finis” (in latino e senza uso di campane registrate); l’educazione fisica si faceva nel cortile e senza tute; all’uscita eravamo schierati a due a due come soldatini e, prima di uscire, sostavamo sull’attenti sulla soglia.


Come si vede, una scuola di sessant’anni fa che dà oggi l’impressione di appartenere a due secoli fa. Il gap generazionale normale è stato brutalmente accelerato nel nuovo millennio; già sembra obsoleto il mondo di dieci anni fa, figuriamoci quale shock proverebbero i ragazzi di oggi a vivere nel contesto neolitico in cui vivevamo noi.
Ma il 1° ottobre 1959, quando i miei mi lasciarono in quella classe sconosciuta, con quel maestro sconosciuto, con quei compagni sconosciuti, mi sedetti un po’ timoroso nel banco guardandomi intorno un po’ smarrito; ma vidi nel corridoio il sorriso dei miei genitori che si allontanavano, vidi i miei nuovi compagni spaventati quanto me e sentii presto la voce del maestro che mi incoraggiava. E quella mattina tornai a casa contento.
Da quel momento non sono mai più uscito dalla scuola; anche ora, che sono in pensione, che dovrei rimuovere dalla mente le mura scolastiche, il mio pensiero sta sempre là, accanto a tutti quelli che hanno la fortuna di operare ancora nella scuola: docenti, non docenti, alunne e alunni. E mi auguro sempre che la scuola, nonostante le ansie, i momenti difficili, gli impegni, le difficoltà, possa ancora fornire sensazioni, ricordi ed esperienze da ricordare poi (come è capitato a me) per tutta la vita.
P.S.: allego quattro foto. La prima mi mostra in III elementare, al primo banco accanto a Paolo Romei; nell’altra mio padre mi accompagna a scuola; la terza mostra me e Romei impettiti all’uscita; la quarta è la copertina del giornalino scolastico “Vita nostra”.
