La storia dell’umanità gronda di esempi di bieco imperialismo, di crudele assoggettamento di Paesi indipendenti e liberi, per di più di giustificazione (ipocrita e mistificante) delle più violente azioni di guerra. In questi giorni questa realtà appare quanto mai evidente ed attuale, considerando la tragedia che si sta verificando in Ucraina.
Sarà il caso dunque di rileggere alcune pagine dello storico greco Tucidide, che a questo proposito sono sempre illuminanti.
Nel 416 a.C. Atene decise di assoggettare Melo, piccola isola delle Cicladi e colonia spartana, che non accettava di aderire alla lega delio-attica, costituendo un nefasto esempio per le altre città.
Già nel 424 a.C. gli Ateniesi avevano inviato sessanta navi con duemila opliti, sotto il comando di Nicia; ma avevano abbandonato l’impresa di fronte alla resistenza degli isolani (cfr. III 91).
Ora, prima di cedere la parola alle armi, gli Ateniesi inviarono gli ambasciatori per imporre ai Meli la resa.
Nell’ampia sezione conclusiva del V libro (capitoli 85-111), Tucidide propone la discussione tra Ateniesi e Meli, che costituisce un vero e proprio esempio di analisi politica dell’imperialismo, ispirato a una visione cinica e pragmatica della realtà.
Rifiutando di invocare i precedenti successi sui Persiani, che avevano sempre sbandierato come il momento più fulgido della storia della città, gli Ateniesi proclamano, a chiare lettere, la legge del più forte (in quegli anni sostenuta dal sofista Crizia): «Noi crediamo infatti che per legge di natura chi è più forte comanda: che questo lo faccia la divinità lo crediamo per convinzione, che lo facciano gli uomini lo crediamo perché è evidente. E ci serviamo di questa legge senza averla istituita noi per primi, ma perché l’abbiamo ricevuta già esistente e la lasceremo valida per tutta l’eternità, certi che voi e altri vi sareste comportati nello stesso modo se vi foste trovati padroni della stessa nostra potenza» (V 103; uso qui la traduzione di Franco Ferrari).
La Machtpolitik, la politica fondata sulla forza, sarà ugualmente presente nelle parole di Trasimaco nel I libro della Repubblica di Platone: “io affermo che la giustizia non è altro che l’interesse del più forte” (338 c, trad. Lozza).
I Meli tentano di convincere i loro interlocutori appellandosi all’utile che potrebbe derivare loro da un atteggiamento conciliante (in caso di sconfitta finale, gli Ateniesi sconteranno a caro prezzo le loro scelte imperialistiche, V 90); citano inoltre il favore divino (“giacché noi, pii, ci opponiamo a persone ingiuste”, V 104) e la loro alleanza con Sparta (“se non altro per dovere di consanguineità e per sentimento di onore”, V 104).
La replica degli ambasciatori smonta le attese degli isolani, dal momento che: non hanno alcun timore per la fine della propria ἀρχή (V 91); ritengono inutile confidare negli dèi, poiché legge divina e legge naturale si identificano (V 105); considerano vana la fiducia dei Meli in un intervento dei Lacedemoni, giacché costoro “considerano onesto ciò che è piacevole e giusto ciò che è utile” (V 105).
Nella lunga rhesis finale (V 111), i legati ateniesi ripropongono le loro tesi e attaccano esplicitamente il “cosiddetto sentimento dell’onore” (τὸ αἰσχρὸν καλούμενον) che, “aiutato dalla forza di un nome ingannevole” (V 111, 3), ha condotto molti alla rovina. Certe formule idealistiche, dunque, sono ormai screditate e inconcludenti: il sentimento dell’onore è solo un miraggio, che deve essere fugato da un’osservazione disincantata della realtà.
Il brano costituisce un unicum nell’opera dello storico ateniese per la sua particolare forma narrativa, basata non su due grandi discorsi contrapposti, bensì su un vero e proprio contraddittorio, con una serie alternata di affermazioni di ognuna delle due parti, senza neppure le consuete didascalie introduttive. L’insolito schema è stato fatto risalire all’influsso delle “antilogie” sofistiche, oppure è stato spiegato con l’incompletezza del V libro (che, come l’VIII, presenta tracce evidenti di una revisione soltanto parziale).
Dionigi di Alicarnasso biasimava Tucidide per aver fatto pronunciare agli Ateniesi affermazioni sconvenienti, che neanche “un pirata o un brigante” avrebbero osato fare; inoltre il retore screditava l’attendibilità del dialogo, sostenendo che Tucidide si trovava allora in Tracia e non poteva quindi essere adeguatamente informato su questi eventi (De Thucydide 41).
Dal canto loro i moderni, analizzando il dialogo, si sono chiesti inevitabilmente quale fosse il pensiero dell’autore. Secondo Jaeger, nel brano Tucidide mostra “l’imperialismo di Atene nella sua logica estrema e all’apogeo della sua consapevolezza. Ch’egli non voglia né possa dare una risoluzione di tale contrasto è cosa voluta dall’indole stessa della forma da lui prescelta, giacché la forza dei discorsi antitetici sofistici sta appunto nel dare dialetticamente la consapevolezza della duplicità d’un problema, e non nella sua soluzione” (Paideia – La formazione dell’uomo greco, tr. it., La Nuova Italia, Firenze 1982, vol. I, p. 673). Oggi infatti si tende a credere che l’autore assuma una posizione oggettiva, senza alcun intento apologetico nei confronti dell’imperialismo ateniese, ma senza nemmeno una vera comprensione per il dramma dei Meli, colpevoli per lo meno di un’errata valutazione delle circostanze.
Tuttavia è altrettanto intuibile un’implicita condanna della decisione degli Ateniesi, privi di lungimiranza.
Rispetto all’Epitafio di Pericle (II 35-46), viene mostrata nel dialogo una ben diversa immagine di Atene: la città “scuola dell’Ellade” (παίδευσις) è divenuta la città “tirannica”; ma a questo mutamento (del resto già implicito nella prospettiva periclea) aveva indotto la guerra, con il suo deleterio effetto corruttore, ottimamente descritto nel III libro dallo stesso Tucidide: “ché in tempo di pace e di prosperità le città e i privati cittadini provano sentimenti migliori, per il fatto che non incontrano necessità che si oppongono al libero volere; al contrario, la guerra, che toglie il benessere delle abitudini giornaliere, è una maestra violenta (βίαιος διδάσκαλος) e adatta alla situazione del momento i sentimenti della folla” (III 82, 2).
Per l’appunto.
La guerra è “una maestra violenta”, stravolge giudizi e criteri, onnubila le menti, induce reazioni, innesca sempre nuovi odi.
I Meli sono come gli ucraini di oggi: si oppongono fermamente a una potenza superiore, che si arroga il diritto di imporre la sua forza, giustificandone anzi l’uso come “necessario”.
Ma se Putin conoscesse la storia (cosa che, guardando lui e le sue frequentazioni, appare in dubbio), saprebbe anche come andò a finire quella guerra imperialista condotta dall’antica Atene. Dopo il disastro di Egospotami, assediata per terra e mare, nel marzo del 404 a.C. Atene si arrese agli Spartani: dovette consegnare la sua flotta, sciogliere la lega delio-attica, abbattere le Lunghe Mura, accettare al Pireo una guarnigione spartana e modificare le istituzioni in senso oligarchico (e ne derivò un anno di spietata repressione attuata dai “Trenta tiranni” filospartani).
Chi maneggia i fuochi d’artificio, rischia di vedersi esplodere gli ordigni fra le mani.
Chi affida le sue speranze di dominio alle armi, rischia di vedersele ritorcere contro.
Chi pensa di avere in tasca una vittoria semplice ed immediata, rischia di impantanarsi in un conflitto endemico e sanguinoso, dai costi umani ed economici altissimi.
Lo dicevano, in fondo, gli antichi Meli ai soverchiatori Ateniesi: «Noi conosciamo le vicende della guerra, che talvolta danno una sorte comune alle due parti avverse più di quanto ci si potrebbe aspettare dalla disparità delle forze; e per noi il cedere immediatamente ci priva di ogni speranza, mentre con l’agire c’è ancora qualche speranza di restare ritti in piedi» (V 102).
E oggi, a far apparire gli invasori per quello che sono veramente, bastano le immagini dei bambini spaventati che piangono, delle famiglie che scappano dalle loro case, dei condomini sventrati dai missili, di un popolo che imbraccia le armi e combatte senza arrendersi e senza umiliarsi.
La storia, “maestra violenta”, dovrebbe essere studiata meglio, da tutti.
La “legge del più forte”, a ben vedere, si basa sull’opinione (proclamata unilateralmente) di credersi “più forti” e di mettersi dalla parte di una presunta “ragione”. Ma sono i fatti e gli eventi a dimostrare, col tempo e senza ombra di dubbio, chi era davvero “più forte”.
E comunque la “forza” non consiste certo nel dispiegamento di armi e truppe, bensì nell’adesione incondizionata ai principi di libertà, dignità e parità fra tutti gli uomini di tutti i Paesi, nel rifiuto di ogni atto unilaterale di violenza, nello smascheramento di tutte le menzogne, nella ferma opposizione a ogni prepotenza mascherata sotto ragioni pretestuose.
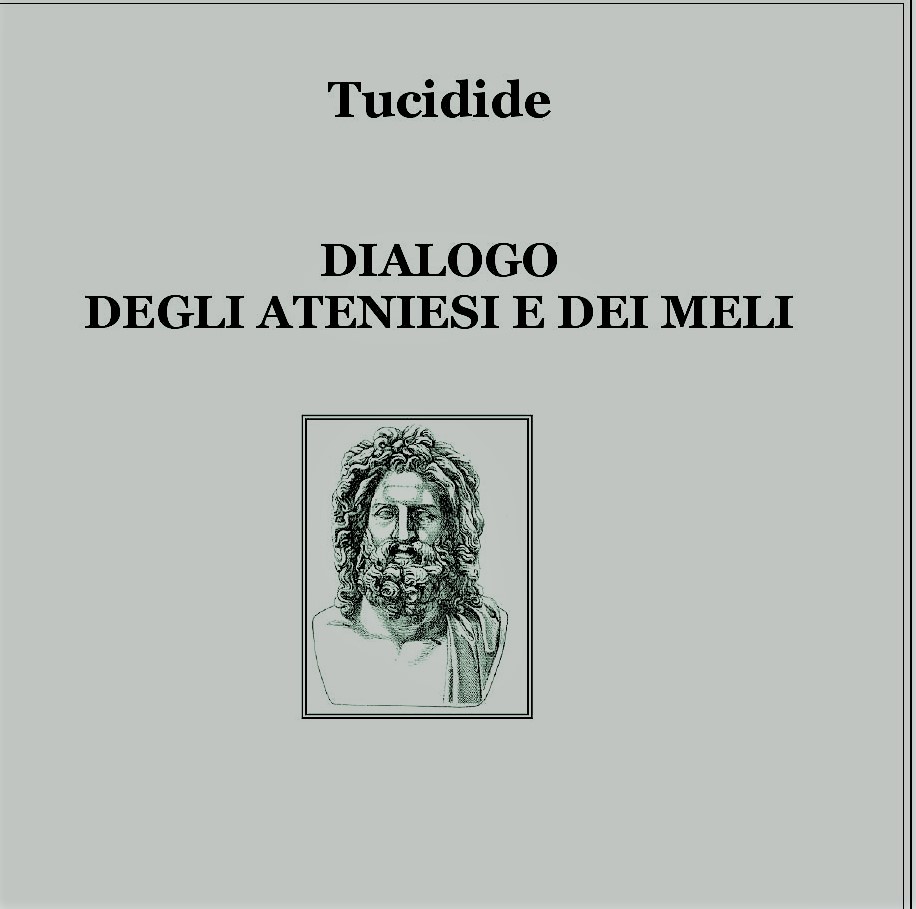
Mi pare che il dialogo in questione, e l’immagine di Atene, si prestino meglio ad un parallelo con l’imperialismo americano che con quello russo (al limite più simile alle istanze spartane, nella guerra del Peloponneso) che ormai da trent’anni ha disseminato per il mondo guerre e morti in nome della sua democrazia. E non a caso sia gli USA che Atene si caraterizzano come due imperi talassocratici, con annessa retorica di liberatori e garanti della democrazia. Ho finito di rileggere l’opera di Tucidide proprio qualche settimana fa, sorprendendomi a rilevare incredibili coincidenze fra le pretese americane e quelle ateniesi.