La cosa bella era, anzitutto, arrampicarsi su una sedia, raggiungere lo scaffale, prendere con circospezione il grande scatolone di cartone.
Poi lo mettevamo rigorosamente a terra e lo aprivamo.
Ne venivano fuori, come conigli e conigli e conigli da un magico cilindro, decine di soldatini colorati in legno (non ancora in plastica!).

C’erano quelli con la divisa blu della cavalleria americana, c’era un immancabile Davy Crockett con il cappello di pelliccia, c’era un trombettiere che suonava costantemente la sua trombetta.
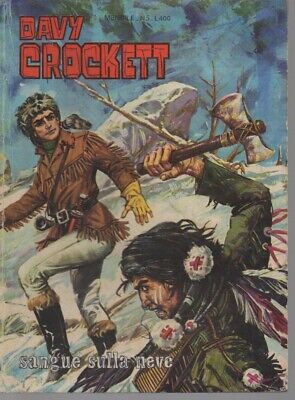
C’erano anche tanti minacciosi indiani cattivi (quando eravamo piccoli gli indiani erano rossi e cattivi, John Ford ce li presentava così e Kevin Costner era soltanto un nostro coetaneo).
Tiravamo anche fuori qualche albero, pezzi di steccato, l’immancabile bandierina a stelle e strisce.
Poi veniva fuori il fortino, che fosse Fort Apache o Fort Nevada o Fort Lincoln o Fort Atlanta o Fort Chissaquale poco importava. Pochi tocchi ed era di nuovo pronto, operativo, bellissimo. Era quello che ci piaceva di più: dava l’idea dell’avamposto da proteggere a ogni costo, del “nido” da difendere (fanciullini pascoliani, eravamo in quell’epoca).
Sistemavamo i soldatini sugli spalti. Gli indiani stavano fuori, nello spazio antistante.
Poi scoppiava la battaglia. E ovviamente la facevamo noi, urlando, sbraitando, riproducendo (come nei fumetti) i suoni del combattimento: bang, bum, crack, crash, pam, zang tumb tumb (questo lo aggiungeva sempre Marinetti).
Noi bambini, allora, giocavamo alla guerra: sia così, buttati a terra coi soldatini e il fortino, sia quando ci riunivamo fra noi e indossavamo elmetti, pistole, fucili, cappelli da cow-boy.
Ne venivano fuori vicende degne del cinema americano dell’epoca; diventavamo tutti John Wayne, Gary Cooper, Henry Fonda, Glenn Ford, Kirk Douglas.
Per noi non c’erano film più belli, allora, di “Sfida all’Ok Corral” di John Sturges (1957), “Quel treno per Yuma” di Delmer Daves (1957), “Un dollaro d’onore” di Howard Hawks (1959), “I magnifici sette” di John Sturges (1960), “La battaglia di Alamo” di John Wayne (1960).
Ricordo l’emozione straordinaria che provai all’età di nove anni, quando mio padre nel 1963 mi portò al cinema a vedere “La conquista del West”, diretto da vari registi (John Ford, Henry Hathaway, George Marshall e Richard Thorpe) e girato con la tecnica (allora rivoluzionaria) del “Cinerama”.

L’immagine era immensa, panoramica, larghissima, offrendo agli spettatori una visione periferica simile alla percezione dell’occhio umano; le scene infatti erano state riprese da tre cineprese diverse disposte a semicerchio, mentre la proiezione avveniva tramite tre proiettori sincronizzati, tutti diretti sullo stesso schermo; veniva poi utilizzata una colonna sonora a sette canali su un nastro magnetico separato, che forniva un sonoro per l’epoca rivoluzionario. Il tema conduttore di quel film rimane, per me, l’essenza stessa del West americano; solo la genialità di Ennio Morricone poté anni dopo aggiungere altre magiche e indimenticabili sensazioni alla musica western.
Insomma, eravamo tutti piccoli cow-boys: e intorno al nostro Fort Apache potevamo passare anche delle ore.
Poi la mamma ci richiamava all’ordine, perché era ora di pranzo o di cena, perché non si poteva stare tutto il tempo buttati a terra a fare sparatorie fra soldatini destinati a morire e rinascere mille volte.
Ma a me era stato insegnato di essere ordinato, anzi molto presto lo fui senza neanche più bisogno che me lo dicesse nessuno: allora, finita la battaglia, svuotavo il fortino, raccoglievo morti e feriti (destinati a pronta guarigione e riesumazione l’indomani), riponevo delicatamente nello scatolo i soldatini.
Poi prendevo il grosso scatolone e mi inerpicavo sulla sedia per posarlo nel suo scaffale, non senza un sospirone – a volte – per aver dovuto interrompere sul più bello un’appassionante carneficina.

Il mio Fort Apache sopravvisse per molti anni. Anzi forse c’è ancora, in un soppalco di casa mia.
Mio figlio non sa cosa sia. Lui appartiene alla generazione post-soldatinesca: quando era piccolo al posto delle belle stragi di soldatini si erano già affermati profani videogiochi non meno sanguinari. Lui non avrà un Fort Apache da ricordare, ma potrà tutt’al più rievocare i furti e le rapine di GTA.
I soldatini, però, io non li posso dimenticare: alcuni (di legno) sono rimasti, in pensione ormai da tanti anni, mutilati nelle braccia, nelle gambe, nella faccia.
E qualche volta, assurdamente, a questo vecchio ormai vicino alla settantina piacerebbe salire sulla sedia, prendere lo scatolone, buttarsi a terra e replicare i giochi coi soldatini, urlando e sbraitando bang pum bum. Poi il problema sarebbe rialzarsi e rimettersi in piedi… ma ne varrebbe la pena.
