Come tutti sanno, il commissario Montalbano (creato dalla mirabile fantasia di Andrea Camilleri) ama molto il cibo: «era sempre stato goloso e ingordo fin da picciliddro, tanto che suo patre lo chiamava “liccu cannarutu” che significava esattamente goloso e ingordo» (“L’odore della notte”, 2001, p. 93).
In casa il commissario si affida alla cameriera Adelina, che gli cucina leccornie e gliele mette in frigo o nel forno. Adelina è una donna ignorante e un po’ scorbutica (in particolare non sopporta Livia, la fidanzata di Montalbano che vive a Genova) ed è la madre di due pregiudicati; ma i piatti da lei preparati sono straordinari e provocano sempre sensazioni afrodisiache.
Tale, ad esempio, è l’effetto della degustazione degli arancini di Adelina, descritta non solo nel racconto “Gli arancini di Montalbano” (1999), ma anche nel romanzo “Il gioco degli specchi” (2011): «Gustare l’arancini d’Adelina era ‘na spirenzia assoluta, esistenziali, ‘na vota che uno l’aviva assaggiati ne consirvava eterna mimoria come di un paradiso pirduto» (p. 39).

Le scorpacciate pantagrueliche del commissario a volte appaiono spropositate per un funzionario di polizia in orario di lavoro; ma l’autore si affretta a chiarire: “A certe pirsone il mangiare anneglia il ciriveddro; a Montalbano, fatta qualichi rara cizzioni, produciva l’effetto contrario” (“Riccardino”, p. 201).
All’ora di pranzo, il commissario mangia in trattoria; la sua preferita è stata a lungo l’osteria San Calogero, ma nel romanzo “Il giro di boa” (2003) il proprietario chiude e va in pensione. Per diversi giorni, il commissario vaga disperato da una trattoria all’altra, finché scopre un ristorante all’altezza del precedente, “da Enzo”. Da quel momento, Enzo diventa il punto di riferimento costante di Montalbano, la sua stella polare; e parallelamente il ristoratore non nasconde la sua simpatia e gratitudine per il cliente: «Dottore, vali la pena di tiniri ‘sta trattoria sulo per il piaciri di vidiri a vossia mentri che mangia» (“Riccardino”, p. 200).
Al commissario piace mangiare lentamente, da solo o, se in compagnia, in perfetto silenzio: «Gustare un piatto fatto come Dio comanda è uno dei piaceri solitari più raffinati che l’omo possa godere, da non spartirsi con nessuno, manco con la pirsona alla quale vuoi più bene» (“Gli arancini di Montalbano”, dalla raccolta omonima, p. 329).
Non a caso Montalbano è molto contrariato quando, nel romanzo “La rete di protezione” (2017), Vigàta viene invasa da una troupe svedese, impegnata a girare una fiction ambientata negli anni Cinquanta, per cui la sua trattoria preferita viene “invasa” e profanata: «La truppi, naturalmente, aviva ‘nvaso macari la trattoria di Enzo, e la cosa che distrubbava Montalbano chiossà era il grannissimo burdello, frastuono, casino che svidisi e italiani arriniscivano a fari mentri che mangiavano. Cosa per lui insopportabili dato che il silenzio era il companatico sò” (p. 16).
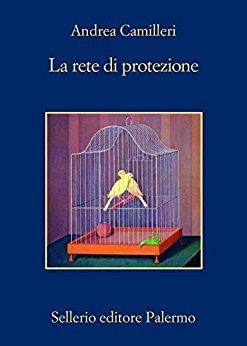
Assolutamente nefasti sono, per Montalbano, i ristoranti “di nuova tendenza”, il catering e gli apericena. Sempre ne “La rete di protezione” il commissario si trova a disagio alla cerimonia del gemellaggio fra Vigàta e la cittadina svedese di Kalmar, dato che il menu consiste in una serie di “finghirfud” (finger food) da mangiare appunto con le mani e fatto venire appositamente da Palermo: «’na serie di cosuzze che si ponno mangiari sulo con le dita, ‘nfatti supra ai tavolini non si vidiva né a un cucchiaro, né a una furchetta, né a un cuteddro, a pagarli a piso d’oro» (pp. 20-21).

La “degustazione” (nefasta) dei “finghirfud”, con la relativa fantozziana esperienza del commissario, viene descritta in modo esilarante: «C‘erano ‘nveci ‘na quantità di vaschette e bicchieruzzi chini di roba colorata, di difficili identificazioni, quindi i vigatisi strammati non osaro allungare il vrazzo per pigliarisi a ‘sti finghirfud. Fu la mogliere del sinnaco a dare l’esempio. Pigliò un bicchierino trasparenti che continiva, come spiegò, una spuma di baccalà condito con un mirtillo e ‘na foglia d’alloro e, usanno la foglia como cucchiarino, accomenzò a mangiarisillo. Qualichi curaggioso allura ne seguì l’esempio. Montalbano agguantò ‘na vaschetta e la taliò attentamente. A prima vista continiva ‘na purpetta con allato ‘na cosa biancastra che poteva passare per purè. Cchiù confuso che persuaso pigliò con dù dita la purpetta e ci detti un muzzicuni. Non era carni, come aviva pensato, ma ‘na speci di pasticcio malfatto di broccoli crudi e fasoli stracotti, con un cori di salmone, evidenti tributo alla svidisità. Gli vinni gana di sputarla ma gli parsi malo e se l’agliuttì chiuienno l’occhi. Per livarisi il sapurazzo dalla yucca affonnò dù dita nella cosa biancastra e fu pejo pirchì la cosa biancastra s’arrivilò esseri ‘na speci di stracchino ànnato a male, con un sapori duciastro di noci di cocco. Posò la vaschettina e s’addunò che non c’erano cchiù fazzulettini di carta per puliziarisi. Santianno, tirò fora dalla sacchetta il fazzuletto allordannosi naturalmenti la giacchetta, si puliziò e po’, avenno stimato che il doveri sò l’aveva fatto, votò le spalli alla compagnia e si avviò verso la porta addiciso a ghirisinni a mangiare da Enzo» (p. 21).
Nonostante la mangiata fatta poi nella trattoria preferita, Montalbano passa «’na nuttata ‘nfami»; infatti «il fituso sapori della pseudo purpetta e dell’altrittanto finto purè gli si era ‘mpiccicato nel palato, per cui si dovitti susiri santianno dù o tri vote per annare in bagno a sciacquarisi la vucca, senza peraltro arrinesciri ad ottiniri nisciun risultato» (p. 25).
Un’esperienza non meno catastrofica si legge nel romanzo “La pista di sabbia” (2007): invitato in una villa frequentata da pomatosi imprenditori e uomini d’affari, Montalbano siede a cena con la bella Rachele Esterman e un altro commensale.
Anzitutto «s’appresentò un cammareri con tre piatti, li distribuì e sinni annò. Era ‘na ministrina giallastra con striature virdognole, il cui aduri stava tra la birra marciuta e la trementina» (p. 110). Montalbano, molto preoccupato, è costretto a degustare: «Montalbano inchì il cucchiaio, se lo portò alle labbra, chiuì l’occhi e agliuttì. Spirava che almeno aviva quel sapori-non sapori delle ministrine del “Boccone del povero“, invece era pejo. Abbrusciava il cannarozzo. L’avevano forse condita con l’acito muriatico. Alla secunna cucchiarata, mezzo assufficato, raprì l’occhi e s’addunò che, in un vidiri e svidiri, Rachele se l’era mangiata tutta pirchì aviva davanti il piatto vacante. “Se non le va, la dia a me” disse Rachele. Ma com’era possibili che le piaciva quella gran fitinzia? Le passò il piatto. Lei lo pigliò, si calò tanticchia di lato, lo svacantò sull’erba del prato, glielo ripassò. “Questo è il vantaggio di un tavolo poco illuminato”».
Iniziata male, la cena prosegue peggio; infatti poco dopo «arrivò il cammareri con i soliti tre piatti. Stavolta c’erano triglie fritte. Nelle nasche del commissario, atterrito, arrivò l’inconfondibile feto del pisci defunto da ‘na simanata» (p. 112). Non a caso avviene «una vera e propia fuitina dalla triglia» e Montalbano si allontana con Rachele pur di evitare un ulteriore tormento.
Ma i tempi più duri arrivano anni dopo: infatti nel romanzo “Il metodo Catalanotti” (2018) l’eterna fidanzata Livia, in occasione della sua ultima discesa a Vigàta, ha deciso di mettere rigorosamente a dieta l’attempato partner e gli ha appiccicato un perentorio “pizzino” sul frigorifero. Nel foglietto Livia ricorda a Salvo che il suo metabolismo è cambiato, che ormai gli bastano poche calorie per raggiungere il fabbisogno giornaliero e che dunque gli sono ormai vietati carboidrati, dolci, fritti, alcol. Per chiudere in bellezza, «ci stava addisignata ‘na crozza di morto e appresso, sempri con il pinnarello russo: ABOLIRE IL WHISKY» (p. 64). Montalbano disubbidisce alle imposizioni della “zita”, ma per telefono millanta di aver cambiato regime alimentare: «Gamberetti bolliti con un filo d’olio e un po’ di limone. Pane integrale, e un mezzo bicchiere di vino. Come vedi, sto rispettando le tue regole» (p. 65).
La dieta, reale o presunta, naufraga però ben presto anche per l’insubordinazione della cameriera Adelina, che – contravvenendo alle istruzioni dell’odiata Livia – prepara al commissario prima “’na miravigliosa, sopraffina, squasi cilistiali, pasta ‘ncasciata” (p. 123) e poi addirittura un barocco sartù di riso (id., p. 159) e un timballo di maccheroni in crosta “priciso ‘ntifico a quello contato nel Gattopardo” (id., p. 249).
P.S.: Per queste e altre osservazioni sul commissario camilleriano, rimando al mio volume “Camilleriade – I luoghi, il commissario, i romanzi storici”, scritto con Vito Lo Scrudato e Bernardo Puleio e pubblicato da Diogene Multimedia.

Ricevo dal collega e amico Bernardo Puleio la seguente utilissima riflessione (di cui lo ringrazio):
«Come al solito una straordinaria ricostruzione di Mario Pintacuda. Due semplici riflessioni.
1) Il primo letterato siciliano che ha dato grande risalto alla gastronomia è stato il palermitano Giovanni Meli che ha descritto la bontà dei monasteri femminili dove soprattutto si realizzavano, con grande abilità e fantasia, dolci straordinari. Li cosi duci de li batii fa salire zuccheri e trigliceridi solo gustando La golosa lettura. Quanto alla golosità del Commissario Montalbano va detto che Cristina Cassar Scalia ne ha riproposto nel vicequestore Vanina Guarrasi l’esatto fac simile. Come il modello di Camilleri anche l’investigatrice in gonnella ama mangiare in una trattoria abbuffandosi di tutto e di più. E siccome Vanina è una palermitana trapiantata a Catania non accetta che le arancine siano chiamate arancini. Peraltro il ruolo che nei testi di Montalbano è svolto da Adelina cuoca straordinaria nei gialli della dottoressa cassar Scalia è svolto da Bettina, la padrona di casa della dottoressa Guarrasi che le prepara leccornie straordinarie, soprattutto dolci
2) Ed ecco la seconda riflessione che, si impone a maggior ragione oggi, dopo che ieri 13 dicembre, a Palermo è stata festeggiata Santa Arancina, con fedeli ossequiosi in lunghe code – miracolo dell’arancina e della gola! code ordinate per lo più-, dietro ai templi, le rosticcerie dove si celebra con voracità la liturgia della abbuffata.
Come notorio, c’è un contrasto tra la parte occidentale dove le arancine sono femmine e tonde e la parte orientale dell’isola. Come ricordato da Mario uno dei più famosi e famelici testi di Camilleri si intitola “Gli arancini di Montalbano”, cosa piuttosto strana per un siciliano della Sicilia occidentale. Vorrei ricordare soprattutto agli amici catanesi una piccola precisazione di ordine filologico, oggi messa da parte. Proprio uno dei più grandi scrittori catanesi, Federico de Roberto, parla di arancine anche lui facendo riferimento come il Meli alle cucine straordinarie dell’Abbazia dei Benedettini che sarebbe poi stata confiscata dopo l’unificazione. Ecco un passo tratto da “I Vicerè”, sesto capitolo della prima parte: “In città, la cucina dei Benedettini era passata in proverbio; il timballo di maccheroni con la crosta di pasta frolla, le arancine di riso grosse ciascuna come un mellone, le olive imbottite, i crespelli melati erano piatti che nessun altro cuoco sapeva lavorare; e pei gelati, per lo spumone, per la cassata gelata, i Padri avevano chiamato apposta da Napoli don Tino, il giovane del caffè di Benvenuto. Di tutta quella roba se ne faceva poi tanta, che ne mandavano in regalo alle famiglie dei Padri e dei novizii, e i camerieri, rivendendo gli avanzi, ci ripigliavano giornalmente quando quattro e quando sei tarì ciascuno”.