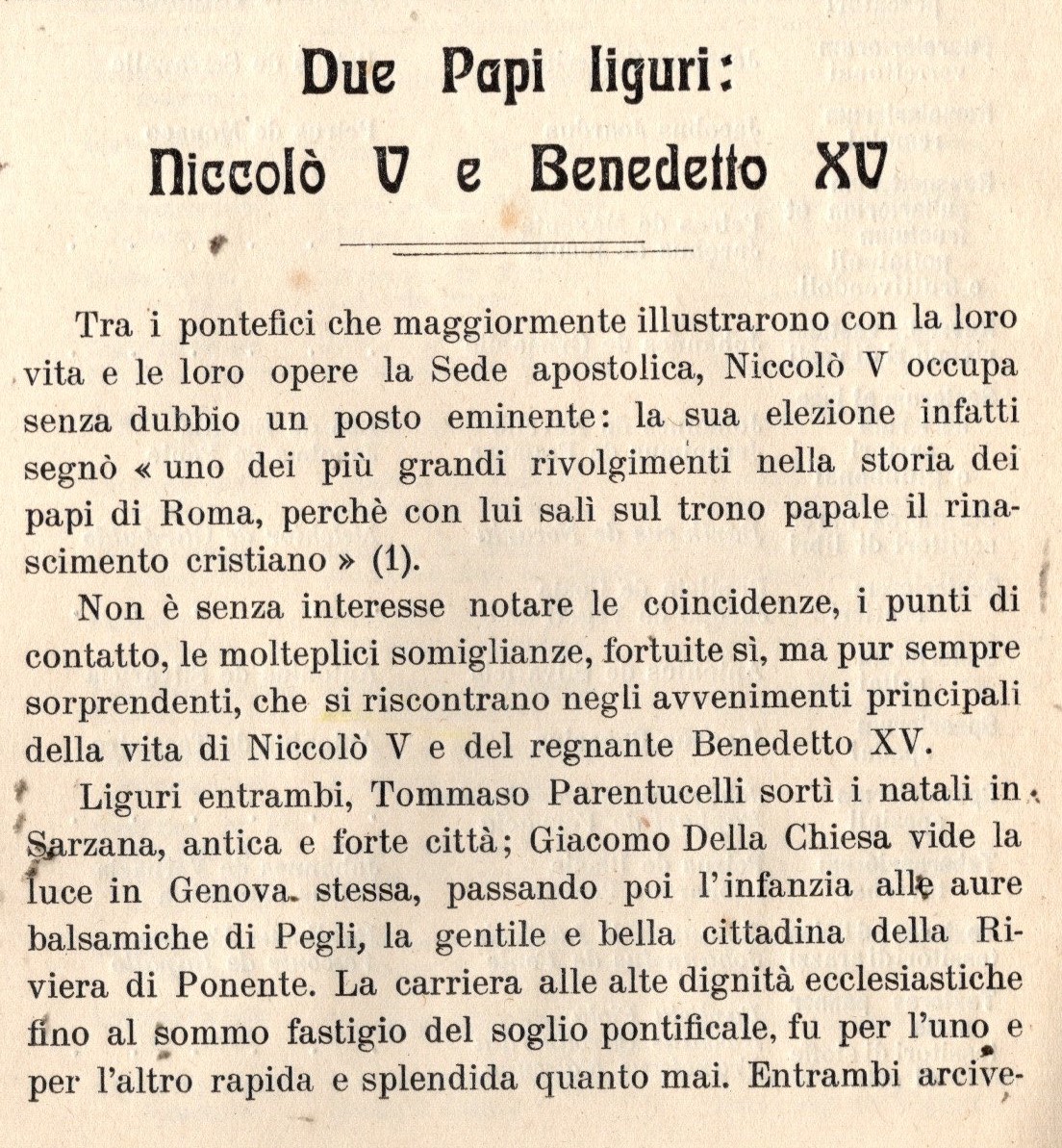In questo periodo di sede pontificia vacante e di imminente conclave, ho casualmente trovato nel mio archivio un numero della “Gazzetta di Genova” n. 12 del 31 dicembre 1914; la rivista, che era allora al suo ottantaduesimo anno di vita, era diretta dal prof. Giovanni Monleone ed edita dai fratelli Pagano, con sede a Genova in Vico Stella 4 (tra via Luccoli e piazza Fontane Marose). In questo numero compare un articolo a firma A. Tranfaglia O.S.B. (doveva trattarsi dunque di un benedettino), intitolato “Due papi liguri: Niccolò V e Benedetto XV” (pagg. 8-10).
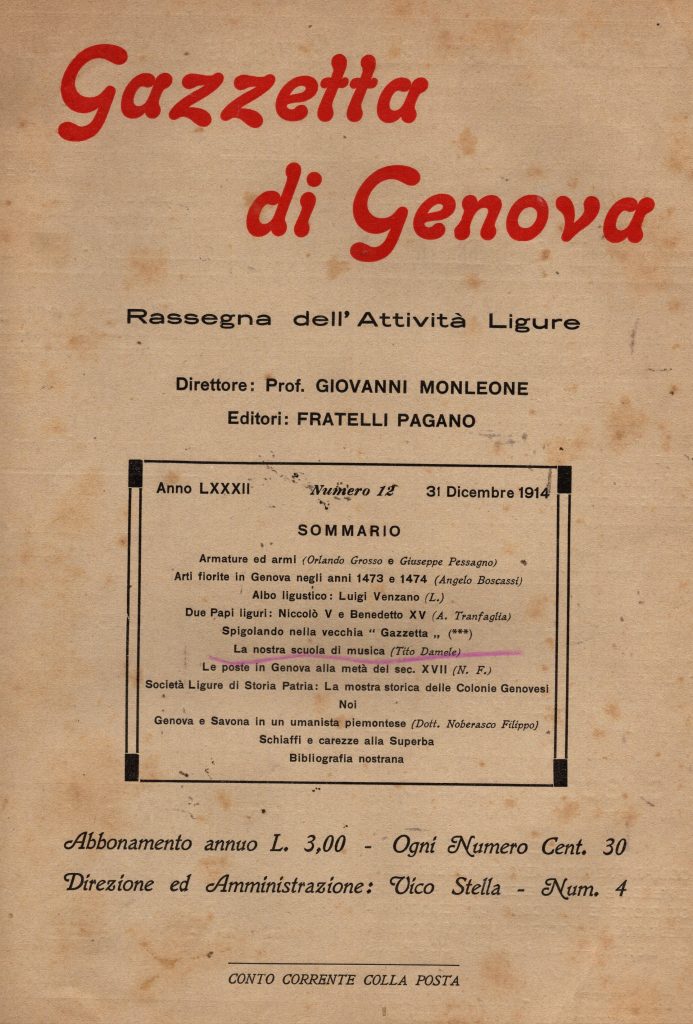
Preliminarmente, mi sembra opportuno fornire qualche breve informazione storica su questi due pontefici.
Niccolò V, nato Tommaso Parentucelli, era nato a Sarzana il 15 novembre 1397 da una famiglia di umili origini; rimasto orfano di padre, fu educato sotto la protezione del cardinale Niccolò Albergati. Ordinato sacerdote nel 1422, divenne cardinale nel 1446 e fu eletto papa il 6 marzo 1447, prendendo il nome di Niccolò V in onore del suo benefattore. Il suo pontificato durò otto anni, fino alla morte avvenuta a Roma il 24 marzo 1455.

Papa Niccolò V è considerato il primo papa umanista: promosse infatti la cultura e gli studi umanistici, sostenendo intellettuali come Lorenzo Valla e Giannozzo Manetti e favorendo la traduzione in latino delle opere greche, pagane e cristiane. Fu un coltissimo mecenate che avviò importanti lavori di ristrutturazione a Roma, in particolare la ricostruzione del Palazzo Vaticano e della Basilica di San Pietro. Politicamente, si distinse per la sua attività diplomatica; il suo pontificato fu però segnato dalla caduta di Costantinopoli in mano ai Turchi nel 1453, evento che lo addolorò profondamente. Indisse il Giubileo del 1450, contribuendo al rilancio spirituale e urbanistico di Roma. Fu sepolto nelle Grotte Vaticane, con un’epigrafe celebrativa scritta da Enea Silvio Piccolomini, il futuro papa Pio II.
Quanto a Benedetto XV, il suo nome di nascita era Giacomo Paolo Giovanni Battista Della Chiesa (“nomina sunt omina”…); era nato a Genova il 21 novembre 1854 e fu eletto papa il 3 settembre 1914, a pochi giorni dall’inizio della Prima guerra mondiale. Originario di una famiglia nobile genovese, era noto per la sua esperienza diplomatica e per la sua posizione “super partes”, che favorì la sua elezione nonostante fosse cardinale da soli tre mesi. Il suo pontificato, durato fino alla morte avvenuta il 22 gennaio 1922, fu contraddistinto da una ferma e tenace opposizione alla I guerra mondiale, definita una «inutile strage», e da numerosi (quanto vani) appelli alla pace rivolti ai governanti delle nazioni belligeranti.

Benedetto XV promosse anche importanti riforme interne alla Chiesa, come la promulgazione del Codice di diritto canonico nel 1917 e l’istituzione dell’Università Cattolica del Sacro Cuore a Milano. Fu inoltre impegnato nel superamento delle divisioni interne al cattolicesimo e nella promozione della carità e della solidarietà in un’Europa devastata dal conflitto. Fu sepolto nelle Grotte Vaticane.
L’articolo della “Gazzetta di Genova”, che qui di seguito riporterò per intero, intende anzitutto evidenziare alcune fortuite somiglianze fra i due pontefici liguri (dei quali il secondo era in quel momento regnante): «La carriera alle alte dignità ecclesiastiche fino al sommo fastigio del soglio pontificale, fu per l’uno e per l’altro rapida e splendida quanto mai. Entrambi arcivescovi di Bologna, entrambi cardinali per brevissimo tempo soltanto, perché passati appena pochi mesi dall’imposizione del cappello, entrambi elevati alla prima dignità della terra; Niccolò dopo circa due mesi e mezzo (23 dicembre 1446 – 6 marzo 1447), Benedetto dopo poco più di tre mesi (28 maggio – 3 settembre 1914)».
Altrettanto simile appare all’articolista la elezione dei due papi: «anche le due elezioni si corrispondono perfettamente, perché non prevedibili, né previste dai facili profeti, che nei giorni di conclave pullulano un po’ dappertutto e con gran sicurezza dispensano voti, sentenziano di probabilità, e ognuno ha in petto il suo candidato bell’e sicuro» (l’ammonimento contro i “facili profeti” è quanto mai attuale, in questo periodo di “toto-papa” in cui i pronostici si sprecano e potrebbero rivelarsi poco attendibili).
Entrambi i pontefici liguri, poi, appaiono a Tranfaglia particolarmente adatti al ruolo assunto: «Egregie doti però di mente e di animo, una dottrina non comune, un’acutezza d’intelligenza, accoppiate a una pietà edificante, li facevano ben degni di ascendere così in alto».
Un’altra analogia consiste nella “universale stima e ammirazione d’ogni partito e d’ogni paese” e nella “viva simpatia” destata dai due papi; e questo nonostante la scarsa avvenenza fisica di entrambi: «i contemporanei ci descrivono Niccolò piccolo di statura, asciutto, di faccia profilato, di colorito pallidissimo; e Benedetto, tutti oramai lo sanno, non è imponente di persona, anzi a nessuno è ignota la sua andatura caratteristica, che Egli stesso piacevolmente definì “pencolante”»
Fra i meriti di Niccolò V viene sottolineata la fondazione della Biblioteca Vaticana, che (scrive il redattore) «arricchita di codici e pergamene e manoscritti pregiatissimi, resta monumento eterno eretto alla sapienza greco-romana».
Un altro aspetto comune ai due pontefici liguri è l’avversione alla guerra e l’impegno per la pace. Di Niccolò si racconta la seguente risposta data a un libraio fiorentino, Vespasiano da Bisticci, che lo aveva pregato “di metter pace all’Italia”: «lo prego Dio che mi dia grazia che io possa metter in opera quello che io ho in niente, che è di far cotesto effetto, e non usare altra arme nel mio pontificato, che quella che mi ha data Cristo, per mia difesa, che è la sua croce, e questa userò in tutto il mio pontificato».
Il riferimento induce Tranfaglia a volgere lo sguardo alla sua epoca, dominata dallo scenario crudele della guerra mondiale; in questo “eccidio odierno”, papa Benedetto XV «volge uno sguardo ai suoi figli, e colpito d’orrore e d’inesplicabile amarezza per l’immane spettacolo di così grande guerra, vedendo tanta parte d’Europa messa a ferro e fuoco rosseggiare di sangue cristiano, pronunzia la grave parola, che nessuno dei monarchi s’attendeva d’esprimere così forte: Pace».
A noi, che le abbiamo ancora vive nella memoria, viene spontaneo il paragone con le ultime parole di Papa Francesco, affidate al messaggio pasquale del 20 aprile 2025: «Nessuna pace è possibile laddove non c’è libertà religiosa o dove non c’è libertà di pensiero e di parola e il rispetto delle opinioni altrui. Nessuna pace è possibile senza un vero disarmo! L’esigenza che ogni popolo ha di provvedere alla propria difesa non può trasformarsi in una corsa generale al riarmo».
L’articolista riferisce poi un commento pubblicato dal giornalista e saggista bolognese Mario Missiroli (futuro direttore del “Corriere della Sera” dal 1952 al 1961) sul “Giornale d’Italia” del 9 ottobre 1914 e riferito all’azione di Benedetto XV: «Egli è il solo che oggi, nella bufera tremenda, che si è scatenata sopra la terra, nell’olocausto di migliaia e migliaia di vite umane, abbia il diritto di portare una parola di pace, riaffermando ancora una volta quelle norme supreme, che solo possono porre un termine alle guerre, agli eccidi, alle violenze, a tutte le crudeltà raffinate della vita moderna, che si dibatte in una lotta incessante senza tregua, senza misericordia e senza rimorsi».
Solo che, aggiunge amaramente l’articolo, «gli uomini erano troppo distolti dal frastuono delle armi, non intesero la parola del Papa e tirarono avanti nella loro opera di distruzione, nell’ebbrezza dei primi trionfi ottenuti o al miraggio della rivincita per tanti anni agognata e augurata».
E tuttavia viene riferita la ferma intenzione del pontefice genovese in carica: «È nostro fermo e deliberato proposito di niente tralasciare di quanto sia in nostro potere, che valga ad accelerare la fine di questa calamità» (“Certum ac deliberatum nobis est, quantum in nostra erit potestate, nihil facere reliqui, quod ad celerandum huius calamitatis finem pertineat”); il papa dunque, «con un lavorio assiduo, paziente, irto purtroppo d’ostacoli d’ogni sorta, lotterà ancora per il conseguimento del suo ideale nobilissimo».
Il finale dell’articolo risente della retorica del tempo, ma è segnato da un ardente auspicio di pace: «È Natale; che l’opera del Pontefice e l’augurio ardente di tutti di giorni migliori, non cada invano in questo tempo benedetto! Spunti adunque la lagrimata pace, la balda gioventù dai campi sanguinosi di guerra ritorni al lavoro fecondo della terra, le officine risuonino dei canti usati e del rombar delle macchine, i vascelli a cento a cento solchino i liberi mari nello scambio del traffico tra i popoli, divenuti di nuovo fratelli alla voce del loro Padre comune».

Possiamo aggiungere un’ultima considerazione. Quando fu eletto papa nel 2005, Joseph Ratzinger scelse il nome Benedetto XVI come omaggio a due figure principali: San Benedetto da Norcia (patrono d’Europa, simbolo delle radici cristiane del continente e riferimento per l’unità culturale europea) e per l’appunto Benedetto XV, pontefice durante la Prima guerra mondiale, definito “coraggioso profeta di pace” per i suoi sforzi diplomatici per fermare il conflitto, da lui chiamato “inutile strage”. La scelta del nome segnò una ripresa del nome “Benedetto” dopo 83 anni, rompendo la tradizione dei papi post-conciliari che preferivano “Giovanni Paolo”. Ratzinger spiegò pubblicamente la sua doppia ispirazione il 27 aprile 2005, collegando il suo pontificato all’eredità di pace dell’omonimo predecessore e alla spiritualità benedettina.
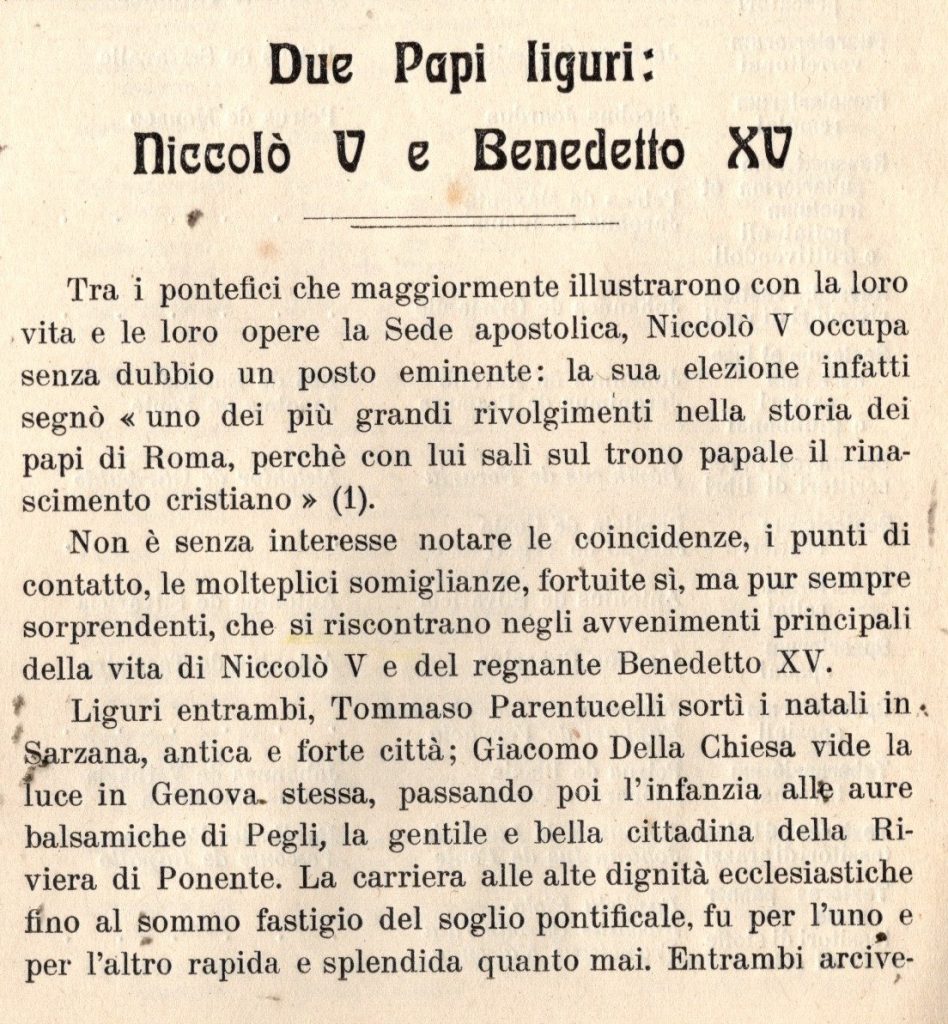
Ecco infine l’articolo della “Gazzetta di Genova” nel suo testo integrale:
Tra i pontefici che maggiormente illustrarono con la loro vita e le loro opere la Sede apostolica, Niccolò V occupa senza dubbio un posto eminente: la sua elezione infatti segnò «uno dei più grandi rivolgimenti nella storia dei papi di Roma, perché con lui salì sul trono papale il rinascimento cristiano» (1).
Non è senza interesse notare le coincidenze, i punti di contatto, le molteplici somiglianze, fortuite sì, ma pur sempre sorprendenti, che si riscontrano negli avvenimenti principali della vita di Niccolò V e del regnante Benedetto XV.
Liguri entrambi, Tommaso Parentucelli sortì i natali in Sarzana, antica e forte città; Giacomo Della Chiesa vide la luce in Genova stessa, passando poi l’infanzia alle aure balsamiche di Pegli, la gentile e bella cittadina della Riviera di Ponente. La carriera alle alte dignità ecclesiastiche fino al sommo fastigio del soglio pontificale, fu per l’uno e per l’altro rapida e splendida quanto mai. Entrambi arcivescovi di Bologna, entrambi cardinali per brevissimo tempo soltanto, perché passati appena pochi mesi dall’imposizione del cappello, entrambi elevati alla prima dignità della terra; Niccolò dopo circa due mesi e mezzo (23 dicembre 1446 – 6 marzo 1447), Benedetto dopo poco più di tre mesi (28 maggio – 3 settembre 1914).
Ma anche le due elezioni si corrispondono perfettamente, perché non prevedibili, né previste dai facili profeti, che nei giorni di conclave pullulano un po’ dappertutto e con gran sicurezza dispensano voti, sentenziano di probabilità, e ognuno ha in petto il suo candidato bell’e sicuro. L’elezione del Parentucelli fu una sorpresa per tutti, per gli stessi porporati; il cardinale portoghese Antonio Martini, uscendo dal conclave, e richiesto se i cardinali avessero eletto il papa, rispose risoluto: “Non già; Dio ha scelto il papa, non i cardinali” (2). Nessuno aveva pensato all’umile maestro di Sarzana allora, come nessuno aveva sospettato adesso che i voti dovessero raccogliersi nella persona di Giacomo Della Chiesa. Mentre nell’ultimo conclave i giornali si sbizzarrivano nella solita gazzarra intorno ai nomi, Aurelio Galli, deputato a tener l’orazione di rito, ammoniva con apostolica franchezza i Padri del Sacro Collegio, che nelle loro mani era posto un affare d’ incredibile gravità e di massima importanza, di cui avrebbero dovuto un giorno rendere severo conto al Principe dei Pastori (3). E usciva eletto, contro ogni aspettazione, Giacomo Della Chiesa.
Egregie doti però di mente e di animo, una dottrina non comune, un’acutezza d’intelligenza, accoppiate a una pietà edificante, li facevano ben degni di ascendere così in alto. Le quali doti, come a Niccolò (4) così a Benedetto, conquistarono d’un tratto l’universale stima e ammirazione d’ogni partito e d’ogni paese, e anche una viva simpatia, tanto maggiormente notevole, quanto meno le forme fisiche in entrambi si presentavano belle e appariscenti. I contemporanei ci descrivono Niccolò
piccolo di statura, asciutto, di faccia profilato, di colorito pallidissimo; e Benedetto, tutti oramai lo sanno, non è imponente di persona, anzi a nessuno è ignota la sua andatura caratteristica, che Egli stesso piacevolmente definì “pencolante”.
Appena il coltissimo Niccolò fu sul trono papale, usando dell’autorità e delle ricchezze del potere, chiamò l’arte e la scienza alla glorificazione della grande idea mondiale del papato. Roma, centro della Chiesa, doveva incarnare con l’espressione multiforme del genio umano tale idea; la tomba del Principe degli Apostoli, su cui egli voleva innalzata la chiesa più meravigliosa che mai si vedesse, secondo la sua concezione grandiosa, sarebbe divenuta il faro, da cui s’irraggiasse la potenza del pontificato romano e del verbo cristiano nel mondo intero. Il gran pontefice umanista al suo disegno volle che contribuisse anche la scienza; divenne quindi munifico mecenate di dotti e letterati, che si dettero convegno a Roma d’ogni parte; fondò poi quella biblioteca vaticana, che arricchita di codici e pergamene e manoscritti pregiatissimi, resta monumento eterno eretto alla sapienza greco-romana.
Una mente eletta nutrita di forti studi classici, un ingegno versato in ogni disciplina sacra e profana, un passato brillante, auspicavano di Benedetto XV un pontefice, che con la magnifica liberalità tutta sua propria, facesse rivivere nella mutata condizione dei tempi, lo splendido mecenatismo di Niccolò (5). Ma l’alba del suo pontificato spuntava sul mondo, quando una parte di questo era divenuta un vasto campo sanguinoso di lotta parricida, preparato ai popoli della moderna civiltà razionalista. Fin dal primo istante Egli dovette volgere tutte le sue cure, ogni sua industria e pensiero a cercare d’alleviare, per quanto gli era consentito, gli effetti terribili del conflitto sciagurato.
Cosi anche in questo adoperarsi per la pace, si trovava a esser simile a Niccolò, uno dei pontefici che più si studiarono di mantenere la pace durante il loro regno, come egli stesso manifestò fin dall’inizio del suo pontificato. Recatosi a porgergli i suoi complimenti per l’elezione il libraio fiorentino Vespasiano da Bisticci, suo grande amico, e pregatolo di metter pace all’Italia, Niccolò, come riferisce lo stesso Vespasiano “a questa parte rispose e disse: lo prego Dio che mi dia grazia che io possa metter in opera quello che io ho in niente, che è di far cotesto effetto. e non usare altra arme nel mio pontificato, che quella che mi ha data Cristo, per mia difesa, che è la sua croce, e questa userò in tutto il mio pontificato” (6). E tenne fede alla parola.
Nell’eccidio odierno il Padre della cristianità volge uno sguardo ai suoi figli, e colpito d’orrore e d’inesplicabile amarezza per l’immane spettacolo di così grande guerra, vedendo tanta parte d’Europa messa a ferro e fuoco rosseggiare di sangue cristiano (7); pronunzia la grave parola, che nessuno dei monarchi s’attendeva d’esprimere così forte: Pace. La sua parola risuonò in tanta tristezza e perturbazione, di cose ammonitrice e consolante a un tempo, dettata da quella carità, che tutti i popoli affratella in Cristo, non d’altro armata che della Croce, non d’altro forte che dei diritti divini e umani delle genti.
La coscienza della propria missione altissima, universale sulla terra, che aveva guidata Niccolò, ispirava ora la parola di Benedetto nell’opera di pacificazione, in quell’opera che a Lui solo si appartiene in modo affatto speciale, come rappresentante di Cristo, Principe della Pace. Bene a questo proposito osservava Mario Missiroli, parlando del Papa: “Egli è il solo se oggi, nella bufera tremenda, che si è scatenata sopra la terra, nell’olocausto di migliaia e migliaia di vite umane, abbia il diritto di portare una parola di pace, riaffermando ancora una volta quelle norme supreme, che solo possono porre un termine alle guerre, agli eccidi, alle violenze, a tutte le crudeltà raffinate della vita moderna, che si dibatte in una lotta incessante senza tregua, senza misericordia e senza rimorsi” (8).
Ma gli uomini erano troppo distolti dal frastuono delle armi, non intesero la parola del Papa e tirarono avanti nella loro opera di distruzione, nell’ebbrezza dei primi trionfi ottenuti o al miraggio della rivincita per tanti anni agognata e augurata.
Cesserà per questo l’attività di Benedetto XV? Egli l’ha detto: “È nostro fermo e deliberato proposito di niente tralasciare di quanto sia in nostro potere, che valga ad accelerare la fine di questa calamità” (9) e con un lavorio assiduo, paziente, irto purtroppo d’ostacoli d’ogni sorta, lotterà ancora per il conseguimento del suo ideale nobilissimo.
È Natale; che l’opera del Pontefice e l’augurio ardente di tutti di giorni migliori, non cada invano in questo tempo benedetto! Spunti adunque la lagrimata pace, la balda gioventù dai campi sanguinosi di guerra ritorni al lavoro fecondo della terra, le officine risuonino dei canti usati e del rombar delle macchine, i vascelli a cento a cento solchino i liberi mari nello scambio del traffico tra i popoli, divenuti di nuovo fratelli alla voce del loro Padre comune.
A. TRANFAGLIA 0. S. B. (Ordo Sancti Benedicti)
Note
(1) L. Pastor: «Storia dei Papi», Vol. 1, l. III, § I.
(2) Presso il Pastor I. c.
(3) Oratio de eligendo Summo Pontifice in Acta Apostolicae Sedis, vol. VI, p. 477.
(4) F. Gregorovius: Geschichte der Stadt Rom in Mittelalter, vom fünften bis zum sechzehnten Jahrhundert. Vol. VII, 104.
(5) Della sua liberalità ne fa fede la cospicua somma elargita ai poveri di Roma in occasione della sua Incoronazione; del suo mecenatismo. oltre una buona somma, è splendido testimonio la lettera inviata all’arcivescovo di Ravenna per le feste centenarie dell’Alighieri. in cui afferma di voler seguire le orme dei suoi Predecessori, Mecenati delle arti e delle scienze. Cf. Acta Ap. S. Vol. p. 582.
(6) Vite di uomini illustri del secolo XVI. Nicola V, § 18.
(7) Benedicti PP. XV: Ad universos orbis catholicos hortatio. Cf. Acta Ap. S. Vol. VI, p. 501.
(8) Cf. Giornale d’Italia, 9 ottobre: «La parola del Papa».
(9) Certum ac deliberatum nobis est, quantum in nostra erit potestate, nihil facere reliqui, quod ad celerandum huius calamitatis finem pertineat. Acta I. c. L’ Enciclica Ad beatissimi Apostolorum Principis, ritorna, per altro, al tema della pace. Cf. Acta Ap. S. p. 567 segg.
MARIO PINTACUDA
Palermo, 29 aprile 2025