“Di ognuno la vita si fa storia, / di ognuno la storia si fa mito, / si fa sogno e poesia”. Queste parole sono poste da Lidia Ferrigno come epigrafe iniziale del suo bellissimo libro “Il mio paese è Macondo – Racconti Miti Poesie”, edito da Armando Siciliano nel 2018.
Lidia Ferrigno, originaria di Vittoria (RG), è una delle presenze culturali più importanti dell’intera Sicilia. Dopo la laurea in Lettere Classiche, ha dedicato la sua vita all’insegnamento e alla promozione della cultura letteraria nel territorio in cui vive. Poetessa sensibile e scrittrice ispirata, ha pubblicato diversi volumi in poesia e prosa, partecipando a concorsi nazionali e conseguendo importanti riconoscimenti; diverse sue poesie sono state inserite in antologie e riviste.

Alcuni mesi fa, Lidia mi ha inviato una copia del suo “Macondo”: leggendolo ed “assaporandolo”, ho avuto la conferma del fatto che la sua scrittura è sempre di alto livello, è poesia anche quando è prosa, è testimonianza storica, etnologica, culturale. Mi dispiace aver conosciuto così tardi, a sette anni dalla sua pubblicazione, un libro così interessante e coinvolgente; ma ritengo una fortuna e un onore aver potuto conoscere Lidia e di avere ormai in lei non solo un’insigne collega ma anche una preziosa amica.
Il fatto è che la produzione di Lidia si distingue per la capacità di coniugare retroterra culturale, riflessione esistenziale e recupero delle memorie antiche, sempre però con viva attenzione alla sensibilità contemporanea e ai problemi dell’oggi e con una scrittura “alta” e al tempo stesso limpida, che pochissimi autori al giorno d’oggi sono in grado di realizzare.
“Il mio paese è Macondo” riprende da “Cent’anni di solitudine” di Garcia Márquez l’idea del “mito” che ciascuno di noi crea sui luoghi della propria infanzia; tutti noi infatti abbiamo un luogo-simbolo, un luogo dell’anima, acquattato nei nostri ricordi, purtroppo sempre più stravolto dall’impietoso trascorrere del tempo e fagocitato dalla voracità smodata del cosiddetto “progresso”.
Come ha avuto modo di dichiarare l’autrice in occasione di una presentazione del volume, “Il mio paese è Macondo” si caratterizza proprio per i ricordi legati all’infanzia: «Gli occhi che ci guardano sono quelli dei bambini, dei semplici, che hanno il dono di vedere più in là e prima degli adulti, di sapere andare dritto al cuore delle cose e coglierne l’essenza che spesso sfugge al mondo e agli occhi dei grandi. L’infanzia infatti, come il mito, è una sorta di condizione edenica, proprio perché connotata da quella che si può definire fantasia leggera, che sembra aver abbandonato per sempre la mente e l’animo dell’uomo tecnologico». E tuttavia, fra Platone, Pascoli, Pavese e Garcia Márquez, la prospettiva che ne viene fuori è personalissima, ricca di spunti originali e fortemente evocatrice, nell’efficace descrizione di cose e persone che prorompono vivide dalle pagine del libro.
Tutti i testi di questo volume sono ricchi di spunti suggestivi; oggi però, 30 settembre, mi pare opportuno proporre la lettura di “Stagioni” (pp. 43-45), che si riferisce per l’appunto a questo “passaggio” settembre-ottobre / estate-autunno, con una serie di notazioni che ci riportano in epoche lontane ma sempre vive nel ricordo.
Si tratta di un racconto che è anche diario, è testimonianza esistenziale, è lirica dei sentimenti e delle memorie. Eccone l’esordio: «Ottobre fino a qualche decennio fa segnava la fine delle vacanze estive e l’inizio di un nuovo anno scolastico che cominciava il primo ottobre, ed era bello ritornare tra i banchi a parlottare eccitati dalle novità che il nuovo anno scolastico ci riservava, quando erano finite le inclementi vampate di calore estivo e il cielo aveva assunto un colore più tenue, meno intenso e abbagliante dei lunghi mesi estivi».
Le nuove generazioni non sanno (o hanno solo sentito dire) che la scuola allora iniziava il 1° ottobre; non a caso i bambini che andavano per la prima volta a scuola col grembiulino e il panierino erano chiamati “remigini” dal santo di quel giorno, San Remigio.
Dopo i mesi estivi, si era stanchi del lungo “stand-by” e si aspettava il ritorno a scuola senza fastidio; ecco come queste sensazioni sono rese dall’autrice: «Col passare delle settimane cominciava infatti a serpeggiare, a farsi strada senza che magari ce ne rendessimo conto ben bene, il rimpianto, la nostalgia della scuola come luogo tutto nostro dove stare insieme agli altri, dove imparare, ridere, e talora anche piangere per qualche insuccesso scolastico e, perché no, anche per una delusione d’amore che allora, mentre si viveva, sembrava insormontabile, e le compagne lì attorno, a consolare o a spettegolare, malignare».
Ecco dunque che settembre diventava un confine, un momento di passaggio: «Settembre faceva da spartiacque tra l’euforia estiva, in cui si era come cani senza padrone e si diventava incontrollabili con grande costernazione delle mamme che non vedevano l’ora che l’estate finisse per poterci nuovamente riacciuffare e tenere in pugno, e la nostalgia, la tristezza della spiaggia vuota, del paese prima esplosivo di figure, voci, suoni, del rosso delle angurie, dei fuochi a mare, dei tramonti su un orizzonte che evocava terre lontane, paradisi di palme e di spiagge ondulate, e ora svuotato come i gusci di conchiglie sulle spiagge desolate, deserte».
Con l’estate, a settembre svanivano le “storie mai cominciate”, i volti “già annebbiati dalla lontananza”. I giorni scorrevano via uno dopo l’altro, come le onde del mare: «Il dondolìo dei giorni come onde, le stesse che avevano a lungo tenuto i nostri corpi a galleggiare a fior d’acqua, a saltarle e assecondarne l’impeto quando il vento di ponente le increspava e le alzava sempre più in alto e la risacca ci lasciava sbattuti sulla battigia intrisi di sabbia e alghe».
In quel lontano, mitico settembre c’erano ancora le stelle nel cielo della sera, stelle oggi celate dalle troppe luci del progresso, stelle che non riusciamo nemmeno più a immaginare e “de-siderare” (e dire che “de-siderare” deriva proprio da “sidus”, cioè “stella”, a indicare chi – caduto dalle stelle – “de-sidera” tornarvi…). Indimenticabili, allora, quelle sere in cui si osservava il cielo sul mare di Scoglitti: «Le sere punteggiate di stelle che all’orizzonte si confondevano con le luci delle lampare, lì tutte in fila, lucette piccole a tratti rese ancor più visibili dal fascio del faro che si spostava a ritmo intermittente creando strani effetti di chiaroscuro interrotto appena dalle luci della costa».
In quelle serate di fine estate, scorrevano i sogni, i desideri, le speranze: «andare, andare via, volare, crescere e ancora volare, dove, in qualche parte del mondo, in quale parte del mondo, non importava, non allora, non in quei momenti in cui bastava seguire il ritmo del cuore in sintonia con una suggestione dettata dalle parole, dalle note di una canzone».
Settembre dunque non era odiato; anzi era «mese amato da sempre, perché riconcilia l’anima con se stessa, la riconduce nei suoi meandri più segreti, la rimette in pace con il mondo. Ancora un libro da leggere, ancora una storia da scoprire e da vivere, ed era già ottobre che si portava via rimpianti e nostalgie, volti rumori suoni».
Ottobre, poi, era il mese del ritorno a scuola, ma questo ritorno era preceduto da una serie di preliminari rituali: «Un nuovo anno iniziava preceduto dalle incursioni in libreria per accaparrarsi al più presto i libri di testo prima che finissero e poi si dovesse aspettare del tempo per averli. L’odore dei libri: era bello annusarli nuovi di zecca, foderarli con della carta spessa e plastificata perché non si sporcassero o si sgualcissero per l’uso, sfogliarli con curiosità e pensare che forse non saremmo riusciti a capire, a imparare tutto ciò che vedevamo scritto in essi: chissà…».
Ricordo che nei primi giorni di scuola, quando ormai ero un insegnante e vedevo le cose da un’altra prospettiva, invitavo alunne e alunni a sfogliare in classe i loro libri nuovi di zecca, a studiarne l’indice, a toccarli ed annusarli, a guardarne le figure (che di anno in anno aumentavano sempre più, via via che si affermava l’attuale civiltà dell’immagine). Molti ragazzi confessavano di non aver degnato finora di uno sguardo quei libri, di non aver neanche lontanamente immaginato quello che ognuno di essi avrebbe potuto dargli; oggi infatti sono ben altre le attrattive dello shopping prescolastico, ridotto a un consumistico assalto allo zainetto firmato o al diario più “trendy” o all’ultimo “gadget” escogitato dalla moda.
Generazioni diverse, tempi diversi, miti diversi. Diversi anche i ricordi, ricordi che Lidia Ferrigno sintetizza in un capoverso ricco di citazioni che non sono tanto letterarie quanto umane, rievocando il patrimonio di cultura che le pagine dei nostri libri riversavano in noi: «La mente si riempiva di nozioni formule regole date; l’anima si perdeva dietro “I cipressi che a Bolgheri alti e schietti …”, “O cavallina, cavallina storna …”, Ettore che spaventa con le sue armi il figlioletto, Achille che sta per uccidere l’arrogante Agamennone e viene fermato in tempo, preso per i biondi capelli dalla dea Atena, le tante avventure di Ulisse, adesso anche lui amato perché non più l’uomo astuto e anche lui prepotente come tutti i grandi della terra, ma uomo di pena, come l’uomo senza patria, Enea, e poi “il tremolar de la marina” di Dante e “l’alpe passai con voce di dolore” di Cino da Pistoia che piange Selvaggia, il “com’erba patita scoloro” di Saffo, e Catullo che odia e ama Lesbia, Orazio che costruisce un monumento più duraturo del bronzo con le sue opere, la tragedia greca in cui si consumano e si condensano tutti i moti possibili del cuore: poesia che ha scandito i nostri anni, il nostro tempo, segnato tutte le stagioni dell’anima, la mia».
Non solo la sua. Non solo l’anima dell’autrice, ma l’anima di intere generazioni, che in quelle aule antiquate, con quei banchi paleolitici (a volte ancora con il buco per il calamaio), mentre fuori pioveva come Dio la mandava, iniziavano un anno scolastico nuovo con mille speranze e mille sogni nel cuore. E anche se era ottobre, si poteva essere felici.
Dagli stralci citati credo si possa già comprendere il livello della scrittura di Lidia Ferrigno; non occorre certo aggiungere ulteriori lodi a un’autrice già universalmente apprezzata, ma mi limiterò a un’unica osservazione conclusiva.
Tanti, troppi, sono coloro che oggi si credono “scrittori”. Tanti, troppi, ricorrendo magari all’acefalo contributo dell’intelligenza artificiale, compongono ed “editano” testi di cui finiscono per non comprendere niente loro stessi. Tanti, troppi, con l’accesso facile e immediato alle piattaforme digitali, si autodefiniscono “scrittori” e si cimentano nella scrittura senza nessuna competenza, preparazione o esperienza, ma soprattutto senza rispettare i tempi, le modalità, la tecnica, la riflessione, la precisione e soprattutto la passione che la scrittura richiede. Scrivere non è solo mettere insieme parole e srotolare frasi spontanee: è un’arte, che in quanto tale richiede doti che dovrebbero essere addestrate, ma che spesso vengono trascurate per la fregola di “comunicare”. In questo contesto, la lettura di testi “ben scritti” diventa anche uno stimolo, un esempio da seguire, un obiettivo da emulare; tali indubbiamente sono gli scritti di Lidia Ferrigno, che possiamo solo ringraziare perché, “miscendo utile dulci”, riesce nell’ardua impresa di “di-vertirci” e di arricchirci.
MARIO PINTACUDA
30 settembre 2025
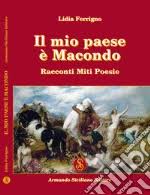
Inquadrato nel tuo commento, il racconto acquista una risonanza diversa persino ai miei occhi inevitabilmente inumiditi per le memorie ed emozioni evocate.
Quando il mondo era diverso e quegli autori formavano il nostro essere persona, diventavano parte integrante di noi.
Allora, pur nella consapevolezza della nostra fragilità, non si aveva paura di crescere.
Oggi sì, purtroppo.
Grazie, Mario.
La tua attenzione è un grande privilegio, e di ciò ti sono veramente grata.
Due grandi, onore al merito a entrambi ❤