Domani, 30 giugno 2024, ricorrerà il settantesimo anniversario della scomparsa di Mario Cappello.
Ah sì – direte voi – ma chi era costui?
Beh, non è affatto un Carneade, ma è l’autore della più famosa canzone genovese, divenuta emblema e simbolo della “genovesità” (“zeneixitæ”), “Ma se ghe penso” (“Ma se ci penso”), da lui composta nel 1925 in collaborazione con il Maestro Attilio Margutti.

Tutte le grandi città hanno la loro “canzone del cuore”: Milano ha la sua “bela Madunina”, Roma ha il suo “arrivederci” e tante altre canzoni, Napoli ha l’imbarazzo della scelta, a Firenze si porta sempre “un bacione” (solo Palermo non ha una canzone, perché i palermitani amano troppo se stessi per amare la loro città).
Genova, città molto amata dai suoi abitanti, superbi di essere nati nella Superba, non aveva neanche lei, fino al 1925, una sua canzone-manifesto. Fu proprio Mario Cappello a comporne i versi e la musica, che però fu poi arrangiata e riveduta dal Maestro Attilio Margutti (che lavorava in Via Porta degli Archi n. 15, vicino via XX Settembre).
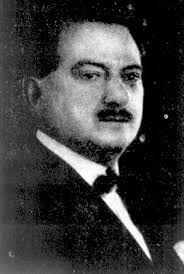
“Ma se ghe penso” fu presentata nella “Festa della canzone genovese” (organizzata dalla rivista letteraria «La Superba») che si tenne a Genova nel 1925 e che mirava a far nascere anche nella città della Lanterna una canzone moderna in dialetto, che in qualche modo si differenziasse dalla tradizionale produzione dei canti popolari liguri, gli antichi “trallallero” polifonici dell’entroterra genovese.
La canzone (in cui le “o” senza accento vanno sempre pronunciate “u”), racconta la storia di un genovese che trent’anni prima (quindi alla fine dell’800) era emigrato in Sud America in cerca di fortuna.
Era partito “sénsa ‘na palanca” (“senza un soldo”) e “l’àia lotòu pe métte i dinæ a-a bànca / e poéisene un giórno vegnî in zu” (“aveva lottato per mettere i soldi in banca / e potersene un giorno tornare a casa”).
“Vegnî in zu”, “venirsene giù”, è l’espressione affettuosa che indica il ritorno a Genova: il ricordo della città natale diventa immediatamente, nella nuova vita sudamericana, un obiettivo futuro, con il desiderio di tornarvi quanto prima, dopo aver realizzato però i propri sogni: “fâse a palassinn-a e o giardinétto, / co-o ranpicante, co-a cantinn-a e o vin, / a branda attacâ a-i èrboi, a ûso letto, / pe dâghe ‘na schenâ seja e matìn” (“farsi la palazzina e il giardinetto, / con il rampicante, con la cantina e il vino, / la branda attaccata agli alberi a uso letto, / per coricarcisi alla sera e al mattino”). In questa descrizione, quel “dâghe ‘na schenâ” (come se fosse un “darvi una schienata”) è impagabile nel descrivere il sogno di un attimo di relax dopo il duro lavoro di ogni giorno.
Questi erano i sogni e gli obiettivi dell’emigrante, che però (anno dopo anno) sente crescere nel cuore, invincibile, la nostalgia della sua “Zena”.
Suo figlio, nato in Sudamerica, non capisce e si dissocia: “Ma o figgio o ghe dixeiva: «No ghe pensâ! / A Zena cöse ti ghe vêu tornâ?!» (“Ma il figlio gli diceva: «Non pensarci: / a Genova, che ci vuoi tornare a fare?»”).
Una parola, “non pensarci”.
Come si fa, soprattutto la sera al tramonto, o al sorgere del sole, o in certi momenti del giorno, come si fa a dimenticare com’erano quei momenti vissuti in quella città meravigliosa e ritrosa, imprigionata fra i monti e il mare?
Come si fa, a non pensarci più?
E allora i ricordi vengono fuori, uno dopo l’altro, a far rivivere ogni angolo più caro di Genova: “Ma se ghe penso alôa mi veddo o mâ, / véddo i mæ mónti e a ciàssa da Nonçiâ, / rivéddo o Righi e me s’astrenze o cheu, / véddo a Lanterna, a Cava, lazù o Meu… / Rivéddo a-a seja Zêna ilûminâ, / véddo la-a Fôxe e sento franze o mâ / e alôa mi pénso ancón de ritornâ / a pösâ e òsse dôve ò mæ madonâ” (“Ma se ci penso allora io vedo il mare, / vedo i miei monti e la piazza della Nunziata, / rivedo il Righi e mi si stringe il cuore, / vedo la Lanterna, la cava, laggiù il molo… / Rivedo la sera Genova illuminata, / vedo là la Foce e sento frangere il mare / e allora io penso ancora di ritornare / a posare le ossa dove è mia nonna”).

Sogni, follie di un “vêgio”, di un vecchio che rimpiange immagini e sensazioni di troppi anni prima; e il figlio non manca di dirlo all’ostinato padre: “O l’êa passòu do ténpo, fòrse tròppo, / o figgio o l’inscisteiva: «Stémmo ben, / dôve t’êu andâ, papà?… pensiêmo dòppo, / o viâgio, o mâ, t’ê vêgio, no convén!»” (“Ed era passato del tempo, forse troppo, / il figlio insisteva: «Stiamo bene, / dove vuoi andare, papà?… penseremo dopo; / il viaggio, il mare, sei vecchio, non conviene!»”).
Sagge parole, quelle del figlio. Non stanno bene, laggiù in America? Che cosa gli manca, ormai? E poi, ormai, il papà è troppo anziano: il viaggio è lungo e di mezzo c’è il mare, il mare immenso, infinito.
Ma per i genovesi il mare non è un ostacolo.
Mai.
E il vecchio risponde vigorosamente, con orgoglio e puntiglio: «Òh no, òh no! mi me sento ancón in gamba, / son stùffo e no ne pòsso pròpio ciù. / L’è in pö che sento dî: ‘señor, caramba’, / mi vêuggio ritornâmene ancón in zû… / Ti t’ê nasciûo e t’æ parlòu spagnòllo, / mi son nasciûo zeneize e… no me mòllo!» (Oh no, oh no! mi sento ancora in gamba, / sono stanco e non ne posso proprio più, / sono stufo di sentire: ‘señor, carramba’, / io voglio ritornarmene ancora in giù… / Tu sei nato e hai parlato spagnolo, / io sono nato genovese e… non mollo!”).
Il ritornello torna a riproporre i ricordi tanto cari; ma alla fine, dopo che viene ripetuto il desiderio insopprimibile di andare a “posare le ossa” dove riposano gli avi, il sogno si realizza: “E sénsa tante cöse o l’é partîo / e a Zêna o gh’à formòu tórna o seu nîo” (“E senza tanti indugi è partito / e a Genova ha formato di nuovo il suo nido”).

Il figlio non l’avrà capito. I figli hanno il diritto di non capire.
Anche mio padre era “emigrato” da tanti anni a Genova dalla sua Bagheria.
Al conservatorio “Paganini”, come docente di Storia della Musica e come bibliotecario, aveva scoperto e rivelato alla città di Genova testimonianze perdute e inesplorate della sua storia musicale, non solo paganiniana. A Genova, a casa nostra, arrivavano da tutto il mondo (Australia compresa) lettere di studiosi che chiedevano a mio padre un documento, un microfilm, un’indicazione bibliografica. Era diventato, insomma, un “genovese d’adozione” che forse era più genovese di molti genovesi doc.
Ma, come dice Peppuccio Tornatore in “Nuovo Cinema Paradiso”, anche mio padre “si fece fottere dalla nostalgia”. E nel 1976, dopo 26 anni a Genova, decise di tornare “in giù” pure lui. E visse i suoi ultimi anni nella sua Bagheria.
Io però non fui come quel figlio della canzone “Ma se ghe penso”, non mi opposi quanto e come avrei dovuto. Avevo 22 anni, ero appena laureato, a quei tempi in certe famiglie siciliane non era previsto dal regolamento che un figlio “si dissociasse” da certe decisioni.
Il risultato è paradossale.
Oggi, a rimpiangere la mia città, sono io.

E anche io, se ci penso, “alôa mi veddo o mâ, / véddo i mæ mónti e a ciàssa da Nonçiâ, / rivéddo o Righi e me s’astrenze o cheu, / véddo a Lanterna, a Cava, lazù o Meu… / Rivéddo a-a seja Zêna ilûminâ, / véddo la-a Fôxe e sento franze o mâ”.
Ma io non penso di tornare più, perché (tra l’altro) mia nonna le ossa le ha posate qui in Sicilia.
Posso solo ascoltare ancora una volta la canzone, in una delle tante versioni che si trovano su YouTube (Mina, Gino Paoli, Bruno Lauzi, Joe Sentieri, soprattutto l’esecuzione “parlata” del grande Gilberto Govi, ecc.).
E posso, settimanalmente, cambiare lo sfondo del mio desktop con l’immancabile foto di Genova e rivedere almeno, a ogni accensione di pc, la mia città, che porto e porterò sempre nel cuore.
Cosa significa aver nostalgia di un luogo che vi ha visto bambini, o in cui siamo cresciuti? Dove ci si sente a casa, dove facciamo parte di quel luogo?
Anche per me è Genova ricordo e vita vissuta. Dove sono veramente a casa? Tra le mie quattro mura. Forse per questo piene di ricordi…..