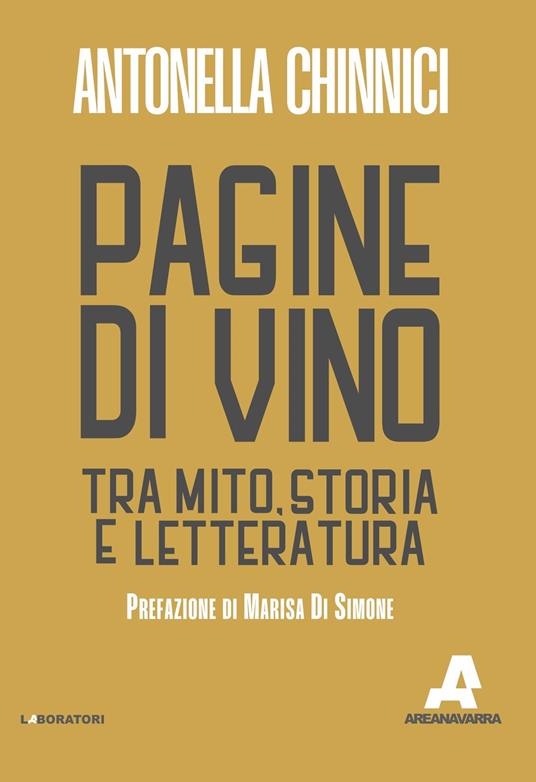“Pagine di vino – Tra mito, storia e letteratura” è il titolo dato da Antonella Chinnici a un suo piacevolissimo volumetto di 72 pagine, pubblicato recentemente dall’editore Navarra.
L’autrice è docente di Italiano e Latino presso il liceo Classico Internazionale “Umberto I” di Palermo e ha al suo attivo diversi saggi e articoli di critica letteraria su riviste specializzate. In particolare, si occupa di ermeneutica testuale con grande attenzione ai testi letterari siciliani: ha curato con Alessandra Colonna Romano e Daniela Musumeci l’antologia “L’isola singolare” per i tipi del Liceo “Umberto I” (2021); con le stesse due coautrici ha pubblicato per Navarra “Tessere di Luce. Letture siciliane dal Duecento ad oggi” (2022) e “A che i poeti nei tempi bui? Versi di oggi contro la guerra” (2024).
In “Pagine di vino” la prof. Chinnici ripropone spunti mitografici, storici e letterari accomunati dal tema del vino, con una carrellata che procede dai tempi biblici al Novecento. Come scrive Marisa Di Simone nella Prefazione al volume, «ogni filare è un frammento di storia, ogni vite documento di civiltà passate, ogni chicco speranza di prosperità» (p. 5).

La rassegna di riferimenti, informazioni e citazioni, ricca e circostanziata nella sua sinteticità, è accompagnata qua e là da note e commenti dell’autrice, che costituiscono a mio parere la risorsa più originale, coinvolgente e interessante del libro.
Ecco dunque che il vino siciliano, celebrato nel XII secolo dal poeta arabo-siculo Abd ar Rahman (che fu membro della corte normanna di Ruggero II), appare come «antidoto dell’angoscia» (p. 25); e mantiene la stessa funzione diversi secoli dopo, quando viene presentato nelle “pagine vinose” di Nino Martoglio nella “sapida commedia in siciliano” intitolata “Annata ricca”: anche qui infatti «il vino, nell’empatia di stati emotivi da esso agevolati, è ora sollecitazione eppure causa di smemoratezza, ora rifugio di malinconici stati di solitudine» (p. 35).
Ecco, anche, il commento puntuale della presenza del vino in Pirandello, non tanto e non solo nella notissima commedia “Liolà”, quanto in altre opere (ad es. la novella “Il vitalizio” del 1915), ove l’autore agrigentino «tratteggia la durezza e la fatica, nonché la precarietà d’una condizione dipendente dall’imprevedibilità del dato meteorologico, la dedizione accanita e caparbia di chi vive la terra come un destino ed una forma di religione professata con quotidiana ed incessante fedeltà» (p. 36). Sempre in Pirandello, nella commedia “La giara”, la prof. Chinnici individua «un’opera in cui il vino si fa generatore di gioia delirante, quasi infantile, e marcatore, come dire, di quella capacità, d’una sorta di resilienza solidale e condivisa tra gente contadina che fa esitare in liberatorio clima di spasso e allegrezza sfrenata un altrimenti monotono destino di fatiche e miserie, un’altrimenti monotona vita di stenti e vessazioni» (p. 31).
È proprio in pagine come queste che il commento “sfugge” all’autrice, liberandola dall’ordinata e impeccabile struttura storico-filologica dell’opera e trasformandosi in digressione ricca di pathos. Lo si nota ancor di più nei momenti in cui, messa in stand-by la scorribanda spazio-temporale, l’autrice lascia libero spazio all’analisi della sua Sicilia, condividendone nell’anima le più profonde istanze interiori e, si direbbe, “genetiche”.
Si legga ad es. la partecipe analisi del semplice pasto dei contadini siciliani, che diventa un vero stralcio lirico che potrebbe sussistere di per sé e diventare a sua volta pagina “vinosa” nuova e inedita: «Il pranzo, inevitabilmente frugale, in cui non può mancare il pane associato sempre al vino nell’alimentazione dei contadini siciliani, è assaporato con voluttà e con una lentezza che ne dilata il piacere in quel tempo di tregua, della pausa che è parte di quel giorno di strenua fatica e quell’incollarsi le labbra al buchino del barilotto – quello che i contadini sollevano per aria passandoselo di mano in mano – è un momento di gioia conviviale gratificante e condiviso, probabilmente più gratificante d’un lussuoso banchetto a corte o in salotti esclusivi perché è la metafora d’una condivisione profonda in cui la religione contadina del lavoro si sposa con il culto d’una fatica che salva perché redime dalla fame, perché mentre stanca salva, pure, da quell’ozio che il vero contadino siciliano rifiuta ed espunge dal proprio sistema valoriale, da ogni suo orizzonte d’attesa. Come sempre, quindi, il lavoro contadino si svolge in un contesto di naturalità, in una plaga di luce in cui alita e s’insinua una connaturata sensualità che attraversa l’aria, gli uomini, le cose, che si diffonde come quell’odore che dà le vertigini, che si coglie in quell’uva pigiata ridotta molle e succulenta» (p. 42).
Come l’autrice coglie la gioia del vino, così ne sottolinea anche il valore consolatorio, affondando la sua analisi antropologica (che si muta in irresistibile vena lirica) nella descrizione del “cùnsulu” siciliano, cioè la pietosa offerta di un ricco pasto “consolatorio” ai parenti di una persona defunta: «Il vino nel “cùnsulu” […] allevia il dolore, lenisce la pena di chi è affranto dalla perdita mentre evoca pure – nella realtà dei paesi siciliani e del popolo siciliano assai condizionato dalla ortodossia cattolica e con un immaginario collettivo fortemente costellato di simbologia e ritualità cristiane – quel Dio che si lascia mangiare e bere nel vino/sangue proprio per recuperare la propria sacertà divina e la conseguente immortalità. Si coglie nel “cunsulu”, nel mangiare e bere vino, la volontà come di emulazione d’una resurrezione da sperare per il definito e la volontà di resurrezione tutta umana e terrena per chi sopravvive e deve ritornare alla vita normale dopo il tempo sospeso del dolore cocente che interrompe la vita, i suoi ritmi serrati, la sua quotidiana ordinarietà» (pp. 46-47).
La stessa vena narrativa e affabulatoria è stimolata dalle pagine sensuali de “L’assaggiatrice” di Giuseppina Torregrossa, laddove del vino viene colta la dimensione “trasgressiva”, obnubilatoria, smemorata e smemorante: «Così, in una scrittura venata di sensualità anche in crescendo, il vino è sempre più volano, in queste pagine, per raggiungere spazi di disinibizione e libertà imprevisti e imprevedibili nelle prosaiche dimensioni domestiche d’ogni giorno, nelle claustranti forche caudine dell’abitudine e di quel comodo e rassicurante mondo del “consentito”, dell’accettato dai più; tali fughe dalla realtà diventano possibili in contesti “vinosi” che sanno, a volte, sradicare gli individui dai loro ancoraggi quotidiani, dai loro tabù, dai loro schematismi rigidi o da asfittiche dimensioni create dalla cultura di appartenenza e dalle proprie e diverse convenzioni sociali» (p. 49).
Laddove poi i testi “vinosi” analizzati possiedono di per sé un particolare rilievo emozionale, grazie alla particolare vena narrativa di qualche autrice o autore, il “commento” della prof. Chinnici prorompe senza più limiti, “rivive” i testi proposti e li “rielabora” in un fiume emozionale felicemente incontrollato. È questo il caso, ad esempio, della digressione originata dalla lettura dei racconti di Vito Lo Scrudato, contenuti nella raccolta “Le porte di Camico Soprana” (2014); tale digressione diventa un piccolo testo di sociologia siciliana e, al tempo stesso, una testimonianza incalzante di “sicilitudine”: «Insomma, in questi ed in altri racconti de “Le porte di Gamico Soprana”, il vino è protagonista di buffi e parossistici momenti di vita paesana di personaggi che, nella loro asfissia e miseria esistenziale, sono sempre pronti a rintuzzare il proprio e l’altrui piacere cercando sempre di consegnare la propria esistenza ad un destino di prosaico e continuo grigiore di giorni uguali tra i quali non c’è posto né per sentimenti profondi, né tanto meno per momenti di vero ed oblioso piacere. C’è sempre qualche grillo parlante – un padre che sa quale sia il giusto partito per figlia, una sorella che sa quale sia la giusta misura nel bere che il fratello debba e possa concedersi – che sa cosa sia giusto e cosa no; invero si tratta di un mondo in cui la vita è riassunta in quel modo di dire e di rispondere dei siciliani quando gli si chiede come vada la vita o come si stia: “Cuntrastamu! oppure “Nni cuntamu i ‘ngustie”. Insomma, in questa atavica cultura contadina gravata pure da forti istanze religiose che plaudono ed esortano al sacrificio, di fronte ad un popolo contadino che si fa forte di una necessaria pazienza per sopportare la precarietà d’una condizione esistenziale quasi sempre dipendente, se non altro, dagli agenti atmosferici e da altre e continue situazioni di povertà, fatica vessante e spesso assai sperequata rispetto alle situazioni di vita che si ottengono, di frequente si assiste, tra i contadini, ad una estrema esigenza di vita parca, dura, che si abitua al patimento e in fondo, a volte, lo cerca e lo custodisce quale cartina al tornasole d’una vita eroica, sudata» (pp. 55-56).
Il libro si chiude con uno “zoom” su proverbi e motti siciliani, ascoltati sin dall’infanzia dalla voce dei genitori (in particolare da mamma Nora, “dotta cultrice di storia, letteratura e racconti siciliani, aneddoti, detti celebri in vernacolo”, p. 63), nelle campagne di Belmonte Mezzagno e Pianetto. L’elencazione dei motti costituisce un’ulteriore immersione nell’anima della Sicilia, con la presentazione di convinzioni («Cu ‘avi ‘na bona vigna, / avi vinu, pani e ligna»), fissazioni («Li vigni di lu vicinu pàrinu cchiù carichi»), sentenze («U vinu fa cantari, / l’acqua fa allintari», «U vinu annea i mali pinseri»), consigli («A la vigna vacci, a la putìa stacci»), esperienze («A San Martinu / ogni mustu addiventa vinu»).
Alle memorie infantili e giovanili si sovrappone, nell’ultima pagina, l’esperienza della docente, che tante volte ha proposto in classe ai suoi alunni i proverbi della saggezza greca e latina (p. 66). Ed è, questo finale, una specie di sussulto vendicativo dell’anima filologica, professionale e “intellettuale” di Antonella Chinnici dopo tante pagine in cui, con irrefrenabile e liberatoria vena narrativa, ha alternato alla ricostruzione paziente, competente ed esaustiva delle fonti l’esternazione di emozioni vere e profonde, con una notevole verve di abile e coinvolgente narratrice.
A questo punto, nel consigliare ai lettori appassionati di vino (e di Sicilia) queste “Pagine” così ricche di notizie e stimoli culturali, posso solo augurare alla bravissima collega di regalarci presto altre pagine narrative, in cui alle sue ben note doti culturali e professionali si affianchino liberamente la sua creatività e la sua scrittura ricca di emozioni vere e sentite.