Publio Ovidio Nasone, nativo di Sulmona in Abruzzo (“Sulmo mihi patria est, gelidis uberrimis undis”, IV 10, 3), fu uno dei più acclamati e ammirati poeti di Roma. Era nato nell’anno 43 a.C., l’anno in cui i due consoli Irzio e Pansa perirono insieme durante la guerra di Modena.
Per motivi anagrafici, Ovidio evitò l’epoca drammatica delle guerre civili: quando aveva appena 12 anni, Ottaviano rimase unico padrone di Roma dopo la vittoria di Azio su Antonio e Cleopatra; come scrive Gian Biagio Conte, “quando [Ovidio] entra nella scena letteraria […] la pace è ormai consolidata e cresce l’aspirazione a forme di vita più rilassate, a un costume meno severo, agli agi e alle raffinatezze che le conquiste orientali hanno fatto conoscere a Roma e che informano la società mondana della capitale”.
Di questa Roma “dalla dolce vita” Ovidio fu entusiasta, disprezzando invece le reliquie del passato: “Piacciano ad altri le cose antiche: io mi compiaccio d’essere nato ora; questo tempo è adatto alla mia indole” (“Prisca iuvent alios: ego me nunc denique natum/ gratulor: haec aetas moribus apta meis”, Ars amatoria III 121-122). Posizione per lo meno scomoda, come si vedrà, in una Roma che dal nascente regime augusteo veniva ricondotta, almeno nelle intenzioni, sui binari di un austero mos maiorum tradizionale.

Ovidio aveva avuto sempre una straordinaria, innata fantasia creativa: suo padre aveva tentato più volte di dissuaderlo dalla poesia (“carmina non dant panem”), ma era stato tutto inutile: come scrive in un’elegia autobiografica dei Tristia, “Spontaneamente il carme veniva nei ritmi adatti, / e tutto ciò che tentavo di scrivere era verso” (“Sponte sua carmen numeros veniebat ad aptos, / et quod temptabam scribere, versus erat”, IV, 10, 25-26).
La stessa elegia aggiunge altre notizie biografiche: Ovidio aveva conosciuto Properzio, che gli recitava i suoi “versi di fiamma” (“ignes”, v. 45); quanto a Virgilio, lo aveva solo visto di sfuggita (“Vergilium vidi tantum”, v. 51), ma aveva potuto apprezzare i canti di Orazio; quanto a Tibullo, era morto troppo precocemente per diventare suo amico. Dopo Cornelio Gallo, Tibullo e Properzio, Ovidio fu il quarto poeta elegiaco dell’età augustea: “quartus ab hic serie temporis ipse fui” (v. 54); aveva però stemperato l’ardore sentimentale dei precedenti poeti, diventando il “tenerorum lusor amorum”, lo “scherzoso cantore dei teneri amori” (v. 1), ed ottenendo uno straordinario successo nell’Urbe.
Cantò una donna di nome Corinna (figura evanescente, che riassumeva forse diverse effimere avventure amorose) e si sposò tre volte: la prima volta, quando era molto giovane, con una donna “non degna né adatta” (v. 69) con cui visse per poco tempo; poi con un’altra donna con cui restò brevemente; infine con una terza compagna, che gli restò legata per sempre: quest’ultima “sopportò di essere moglie di un esule” (v. 74).
Infatti, mentre Ovidio era all’apice del successo, nell’8 d.C. fu improvvisamente colpito da un drastico provvedimento “ad personam” di Augusto, che lo relegò a Tomi nel Mar Nero (attuale Costanza in Romania). Le cause di questa relegazione non sono chiare, perché il poeta (evidentemente timoroso di ulteriori punizioni) vi accenna con parole oscure: “Mi rovinarono due accuse, un carme e un errore” (“Perdiderint cum me duo crimina, carmen et error”, Tristia II 1, 207). E se il carmen si può identificare verosimilmente con l’Ars amatoria (spregiudicato poema didascalico che impartiva smaliziati consigli sulla seduzione reciproca fra uomini e donne), sull’error permangono molti dubbi: forse Ovidio fu coinvolto in uno scandalo legato a un adulterio di Giulia Minore, nipote di Augusto, che nello stesso anno 8 fu relegata a sua volta nelle Isole Tremiti; in un’elegia dei Tristia Ovidio confessa di aver visto qualcosa che non doveva vedere (Peccatumque oculos est habuisse meum “Il mio peccato è stato quello di avere degli occhi”, III 5, 50). In un saggio del 2001 (Il perdono negato. Ovidio e la corrente filoantoniana, Bari 2001), Aldo Luisi ha ipotizzato che la vera causa fosse politica: Ovidio avrebbe frequentato circoli antiaugustei.

All’età di cinquant’anni, dunque, Ovidio dovette abbandonare Roma, lasciandovi la terza moglie e una figlia (che lo aveva reso due volte nonno): la partenza per l’esilio è rievocata in una struggente elegia dell’addio (Tristia I 3: “cum repeto noctem, qua tot mihi cara reliqui”, “quando ripenso alla notte in cui lasciai tante cose a me care”).
Ed ecco il frivolo, smaliziato poeta mondano sradicato dalla vita elegante di Roma e proiettato in una dimensione alienata e frustrante.

Anzitutto Ovidio, che della magica potenza evocativa della parola aveva fatto la sua arma principale (in questo precorrendo di molti secoli il suo conterraneo Gabriele D’Annunzio), si trova costretto ad esprimersi a gesti, riducendosi al livello di un “barbaro”: “qui io sono un barbaro e non sono capito da nessuno, e i Geti ridono, stolti, delle parole latine” (“Barbarus hic ego sum, qui non intellegor ulli, / et rident stolidi verba Latina Getae”, Tristia V 10, 37-38).
Poi, il clima è profondamente diverso rispetto al Lazio: in inverno la neve e il ghiaccio imperversano, il Danubio e il Mar Nero congelano. Il poeta stupefatto cammina sulle distese ghiacciate (“calcai il mare congelato, e la cima dell’onda stava sotto il mio piede asciutto”, Tristia III 10, 39-40); il vino viene surgelato nel suo recipiente “conservando la forma del vaso” (id. v. 23), mentre gli abitanti locali si difendono con pelli e brache dal freddo micidiale: “di tutto il corpo resta scoperto solo il viso” (“oraque de toto corpore sola patent”, id. v. 20).
Infine, Ovidio vive “in mezzo alla barbarie” (“in media… barbaria”, id., v. 4); circondato da Sarmati, Bessi e Geti, è costretto spesso a difendersi dalle incursioni delle popolazioni vicine impugnando (per la prima volta in vita sua) le armi. La sua inedita attività militare viene commentata amaramente: “Gli aspri scontri guerreschi da giovane io li evitai, / né mai impugnai armi se non per gioco; / ora, ben più anziano, mi cingo la spada al fianco e con la sinistra imbraccio lo scudo, / e poggio un elmo sulla mia canizie” (Tristia IV 1, 71-74).
In un’epistola a Fabia, il poeta – che ha somatizzato il suo malessere – descrive la sua infelice condizione: “Come pensi che mi senta, infermo come sono, / in questa orribile terra, fra i sarmati ed i geti? / Non sopporto il clima, a quest’acqua non riesco ad abituarmi, / questo paese proprio non mi va, non so dirti il motivo. / La casa non va bene, non c’è del cibo adatto ad un malato, / non c’è un medico che con la sua arte curi la malattia. / Non ho un amico che mi conforti e con i suoi racconti / inganni il tempo che mi scorre lento. / Sfinito giaccio tra genti e luoghi estremi, e nel delirio / ora mi sovviene di tutto quello che ho perduto” (“Tristia” III 3, 5-14, trad. Gazich).
Alessandro Barchiesi, in un suo libro (“Il poeta e il principe. Ovidio e il discorso augusteo”, Roma-Bari 1994), si è chiesto se Ovidio non abbia caricato eccessivamente le tinte, esagerando il suo disagio probabilmente per impietosire i suoi lettori a Roma (che, oltre ai familiari e agli amici, sperava fossero anche i potenti membri della corte imperiale o l’imperatore stesso), in vista di una possibile revisione della sua pena.
Comunque sia, Ovidio apprese la lingua getica e in getico compose un poemetto perduto (lo definisce “Geticum libellum”, Ep. ex P. IV 13, 19); inoltre realizzò un poema didascalico sulla pesca (Halieutica) elencando i pesci del Mar Nero (ricordo che il prof. Della Corte all’Università di Genova ci fece imparare tutto questo patrimonio ittico rumeno…), nonché un poemetto (Ibis) contro un ex amico che a Roma lo diffamava. Continuò poi la sua produzione elegiaca nei già citati cinque libri di Tristia e nei quattro di Epistulae ex Ponto, sia pure mutando i precedenti toni scanzonati e leggeri in una piagnucolosa e ossessiva serie di considerazioni deprimenti, struggenti autodifese e vane suppliche; in tal modo Ovidio, che già aveva rinnovato in molti aspetti la letteratura latina in opere come le Heroides, l’Ars amatoria e le Metamorfosi, ebbe anche il merito di ricondurre l’elegia alle sue origini classiche greche, come poesia del pianto e del lamento.
Gli scrittori romeni hanno trasfigurato la figura di Ovidio, considerandolo in un certo senso il fondatore della loro cultura. In un romanzo del 1960 intitolato Dio è nato in esilio. Diario di Ovidio a Tomi Vintilă Horia (1915-1992), scrittore romeno residente in Francia (anche lui esule, profugo dal regime sovietico), realizzò una riscrittura delle opere composte da Ovidio durante il suo esilio a Tomi, scegliendo il poeta stesso come narratore in prima persona di una sorta di “diario segreto” in otto capitoli, tanti quanti i suoi anni d’esilio (in realtà Ovidio, che morì a Tomi nel 17 o 18, vi restò quasi dieci anni). Il romanzo vinse il prestigioso Premio Goncourt (cui però lo scrittore rinunciò in seguito ad alcune polemiche politiche).

Nell’opera Horia descrive l’iniziale disperazione di Ovidio nella sua nuova destinazione, il suo lento adattamento, la sua tenace e vana speranza di un’amnistia. A Tomi il poeta stringe amicizia con la governante Dokia e il soldato Onorio che gli fa da sorvegliante; conosce inoltre due prostitute (Artemide e Gaia) e un oste greco (Erimone), che – grazie alle doti poetiche di Ovidio – conquista la sua Lydia. Viene anche narrato un pellegrinaggio del Sulmonese sui monti Carpazi al santuario di Zalmoxis, l’unico dio venerato dalla popolazione locale; qui incontra un anziano sacerdote che gli infonde un desiderio di religiosità precedentemente mai provato. Altrettanta influenza spirituale ha su di lui il medico greco Teodoro, che aveva vissuto in Egitto e in Palestina, rivolgendosi alla fede ebraica; e a Betlemme aveva conosciuto i re Magi. Dopo la morte di Augusto, con la successione di Tiberio si insedia a Tomi una nuova guarnigione, il cui capo, Valerio, è avverso al poeta esule. Intanto Onorio ha disertato dopo avere sposato Dokia, mentre Erimone, che ha ucciso la moglie per sposare Lydia, si uccide per il rimorso. Ovidio, stanco e rassegnato, senza più speranze di tornare in patria, progetta di fuggire da Tomi per vivere con Onorio e la sua famiglia, ma si ammala gravemente interrompendo il suo diario.
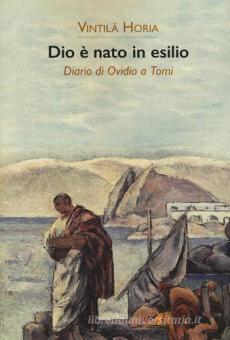
Come scrive Italo Lana, nel romanzo di Horia Ovidio “matura una nuova religiosità, trova finalmente Dio”; infatti “venuto casualmente a conoscenza delle profezie ebraiche e dell’attesa messianica diffusa anche fra i popoli più remoti, ha l’intuizione della venuta del Cristo, del mirabile mistero che si sta compiendo proprio in quegli anni sulla terra”. Lo dimostra il seguente passo del romanzo, in cui Ovidio, rileggendo alcuni suoi versi delle Metamorfosi nei quali Pitagora parla dell’immortalità delle anime (“L’anima non conosce la morte ma vive in eterno e, lasciata una sede, va ad abitare in un’altra che l’accoglie”, XV 158-159, trad. Faranda Villa), si meraviglia di se stesso: “L’anima è dunque sottratta alla morte. Lo sapevo. Come lo sapevo? Chi me l’aveva detto, poiché in questi versi Pitagora sono io? Un io che si nascondeva dietro la mia esistenza di ogni giorno”. Il risultato di queste riflessioni è uno sbandamento, una ricerca di Dio destinata forse a essere interrotta dalla morte: “Vacillo, ubriaco di incertezza e di preghiere, fra Tiberio e Dio”.
Così anche la fase “calante” di Ovidio, la sua triste esperienza in una terra lontana e diversa, ha potuto – sia nella realtà sia nella ricostruzione romanzesca – costituire (suo malgrado) un arricchimento ulteriore per lui e per la cultura latina, nonché ispirazione fertile di riflessioni e approfondimenti nelle epoche successive.
Oggi la piazza principale di Costanza (l’antica Tomi) è Plata Ovidiu (Piazza Ovidio); e davanti al Museo nazionale di storia e archeologia si trova una statua di Ovidio scolpita dall’italiano Ettore Ferrari.

Non basta: l’università di Costanza è intestata al poeta latino (Universitatea Ovidius din Constanța). Nel distretto di Costanza, poi, nella regione storica della Dobrugia, si trova la città di Ovidiu, che prese il nome attuale nel 1930 ricavandolo da quello di una piccola isola che si trova sul Lago Siutghiol, su cui si affaccia e dove si presume sia sepolto il poeta Ovidio.
E forse il poeta esule, che al successo e al ricordo teneva così tanto, sarebbe lusingato di queste attestazioni di stima “post mortem”; forse, chissà, avrebbe attenuato alcuni suoi versi così disperati e lamentosi, come quelli rivolti alla moglie Fabia: “Come pensi che mi senta, infermo come sono, / in questa orribile terra, tra i Sarmati ed i Geti? / Non sopporto il clima, a quest’acqua non riesco ad abituarmi, / questo paese proprio non mi va, non so dirti il motivo. / […] / Non ho un amico che mi conforti e con i suoi racconti / inganni il tempo che mi scorre lento. / Sfinito giaccio tra genti e luoghi estremi, e nel delirio / ora mi sovviene di quello che ho perduto. / Di tutto mi sovviene, ma più di tutto di te, mia sposa, / che tieni la parte maggiore della mia anima” (“Tristia” 3, 5-16, trad. Gazizh).
