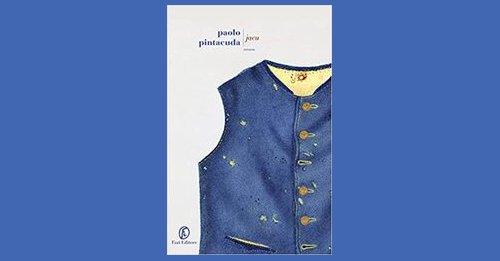Di “Jacu”, il nuovo romanzo di Paolo Pintacuda, edito da Fazi editore a Roma ed appena uscito nelle librerie, colpisce anzitutto la poliedricità narrativa, che ne fa un racconto ora visionario, ora immaginifico, ora – con stridente contrasto ossimorico – fortemente realistico.
In questo variegato tessuto sperimentale, la ricerca e la documentazione archivistica, le indagini tra i documenti storici dell’anagrafe e la scrupolosa consultazione di fonti e testimoni si fondono con le invenzioni della fantasia, con le divagazioni liriche e a tratti epiche, realizzando un insieme che – proprio dalla disarmonia dei suoi elementi costitutivi – attinge una forte e pregnante originalità.
Si potrebbero invocare parentele con il “realismo magico” novecentesco (Bontempelli, Buzzati, Borges, Garcia Marquez) o con tanta narrativa di alto livello (siciliana e non) che unisce abilmente sogno e realtà, fantasia e concretezza, leggenda e storia, echi del passato e allusioni al presente; ma il risultato complessivo, a ben vedere, non è inquadrabile in nessun canone precostituito ed effettivamente, come si legge nella nota introduttiva di copertina, il libro è una “narrazione originale che mescola ricostruzione storica e romanzo in una maniera completamente spiazzante”.
Non è strano trovare questo mix ingegnoso in questo bravo sceneggiatore e scrittore bagherese, che ha avuto la fortuna di avere per Maestro suo padre, il fotografo Mimmo Pintacuda, proiezionista cinematografico e maestro di fotografia di Giuseppe Tornatore, che a lui si ispirò per il personaggio di Alfredo di “Nuovo Cinema Paradiso”.
Paolo, nato a Bagheria nel 1974, ha già dietro di sé un brillante curriculum artistico e culturale, sia come scrittore sia come sceneggiatore: ha vinto il Premio Solinas 2010 per “Scuru”; nel 2015 è stato fra gli sceneggiatori de “Il bambino di Vetro”, selezionato come unico film italiano in concorso ad “Alice nella città”, sezione parallela della Festa del Cinema di Roma; è stato co-autore del soggetto e della sceneggiatura del film-commedia “Tuttapposto” (Medusa Film 2019), diretto da Gianni Costantino con protagonista Roberto Lipari. In campo narrativo, aveva finora pubblicato “L’uomo tra la folla” (2000), “Il Paese delle ombre” (2000) e “L’eroe di Paternò” (2015).

A proposito di “Jacu”, in una recente intervista Paolo ha dichiarato: «Mio padre possedeva il dono del racconto attraverso l’arte del cinema e della fotografia. Questo ha segnato la mia infanzia e certamente è presente nel libro. Mi narrava spesso episodi di vita vissuta e credo che il primo seme di “Jacu” sia nato in seguito a uno dei suoi racconti sulla partenza per la Prima Guerra Mondiale di mio nonno, che a soli diciassette anni lasciò tutto in cambio di aerei, carri armati, fucili e dirigibili. Da quel momento rivolsi a me stesso una riflessione che poi divenne uno dei fili conduttori del romanzo: cosa sarebbe accaduto a un giovane di quel tempo, come fu mio nonno, se si fosse trovato a dover uccidere qualcuno, sapendo però di possedere il dono della guarigione?» (cfr. https://www.sicilianpost.it/guerra-cinema-e-magia-jacu-di-paolo-pintacuda-e-il-potere-della-speranza/).

[Detto fra parentesi, il nonno di Paolo era Giuseppe “Peppinieddu” Pintacuda, nato anche lui settimino a fine ‘800 e anche lui, nonostante il suo antimilitarismo, arruolato giovanissimo nella guerra mondiale, affrontata con il terrore di “dover uccidere qualcuno”. In realtà poi, nella sua vita, Peppinieddu colpì molti bersagli senza uccidere nessuno, non con le armi ma con i suoi pungenti versi dialettali, sempre arguti, geniali e profondi. Io lo ricordo bene, con la sua voce cavernosa e la sua faccia costellata di rughe, intento a declamare a mio padre (erano cugini) le sue poesie. La sua creatività, certo, doveva a volte fare i conti con le difficoltà economiche (povera e nuda va la poesia…); ma Peppinieddu era sempre positivo, ironico, spiritoso, divertente. Ne conservo le immagini in un antico filmino 8mm del 1963 nel quale, davanti alla “carnezzeria” di Luigi Zarcone nello “stratuneddu”, il poeta – ripreso da mio padre – denigra con buffi gesti plateali la qualità della carne esposta dal macellaio, che lo guarda sorridendo e… tollerando].
Dunque il protagonista del libro, Jacu, possiede questa qualità taumaturgica: «negli ultimi giorni del 1899, la misera quiete di Scurovalle, un grumo di case su di un anonimo monte siciliano, è turbata da un incredibile evento: Vittoria, ventidue anni e già vedova, partorisce l’ultimo settimino del secolo, un bambino che, secondo le credenze popolari, avrà poteri magici e curativi e sarà in grado di assistere qualsiasi sventurato. Sebbene Vittoria tenti di assicurare un’infanzia normale al figlio, sin dalla tenera età il piccolo Jacu dimostra di possedere questo dono prodigioso, diventando un punto di riferimento irrinunciabile per tutti i compaesani» (dalla Nota di copertina).
Sulle miracolose qualità dei settimini non mancano leggende popolari, di cui si trova traccia già nel Cinquecento, ad es. nel “De occulta philosophia” (1533) del tedesco Heinrich Cornelius Agrippa di Nettesheim; si credeva che i settimini, nascendo prematuramente, non fossero ancora completamente incarnati, sicché erano ritenuti chiaroveggenti, sensitivi e capaci di guarire le malattie. Il tema è stato sfruttato molte volte da scrittori di ogni Paese: per limitarci ai volumi pubblicati in Italia negli ultimi anni, nel 2016 lo scrittore astigiano Fabrizio Borgio (nato prematuro anche lui) ha pubblicato un “noir” paranormale intitolato appunto “Il settimino”.
Il tema, ricco di suggestioni e spunti, si prestava dunque a più di una chiave di lettura; ed è merito di Paolo quello di aver scelto un percorso narrativo efficace, che assembla lo sfondo “fantastico” in un solido contesto storico-culturale.
La storia è ambientata, nella prima parte, nell’immaginario paese di Scurovalle.
Si potrebbe divagare sui motivi che hanno indotto Paolo a coniare questo toponimo, che risulta pure sbilanciato a livello di concordanza grammaticale: “scuro” e “valle”, rispettivamente al maschile al femminile, avrebbero potuto fondersi semmai in un nome come “Vallescura” (che a me personalmente avrebbe ricordato però una frazione del comune di Fontanigorda, vicino alla mia città natale Genova) o “Vallechiara” (inducendo in me un’inevitabile associazione di idee con il film del 1938 “Avventura a Vallechiara”, di John G. Blystone, c on gli indimenticabili Stan Laurel e Oliver Hardy). In realtà, come il paese di Mezzojuso fra Palermo ed Agrigento, la location è immaginata «da qualche parte al centro di una montagna ancora senza nome fra i circondari di Girgenti e Palermo» (p. 9): la “valle” dunque sta sotto, mentre il paese come tutte le località di sogno – è «difficile da raggiungere pure a dorso di mulo» (id.). Una specie di “Nefelococcugìa” aristofanesca, sospesa a metà fra terra e cielo, in una sua dimensione solitaria e unica.
Di questo paese di “mezza montagna” vengono fornite precise coordinate statistiche: «contava quattrocentoundici viventi, quindici vacche, tre vitelli che non sarebbero sopravvissuti all’inverno, cinquantadue pecore e un numero imprecisato di randagi fra cani e gatti».
La meticolosità di questo minuzioso elenco contrasta volutamente con la dimensione immaginifica: qui cogliamo subito un elemento fondamentale nel romanzo, cioè la volontà di fornire una base concreta agli eventi, di calare la vicenda in una prospettiva apparentemente e ineccepibilmente “storica”. A questo mira la scrupolosa documentazione dell’autore, che in sede di “Ringraziamenti” finali ricorda le sue accurate ricerche storico-legali («di cui avevo assoluto bisogno»), le assidue consultazioni dei documenti anagrafici, le collaborazioni preziose, le indagini difficili.
Da questo intenso lavoro preparatorio deriva la meticolosa cornice dei capitoli, con tanto di datazione immancabile degli eventi (fin dalla nascita del protagonista, avvenuta il 12 dicembre 1899 e attestata da un minuzioso atto di nascita redatto in perfetto burocratese, pp. 15-16). C’è qualcosa di inconsciamente manzoniano, in questa citazione di date e documenti: un’altra chicca (forse più “camilleriana”) è la secca comunicazione, da parte del Distretto Militare di Girgenti, della morte in guerra di un ragazzo del paese, con le compassate espressioni di circostanza di un tale colonnello-comandante G. Battista Tofano (p. 66).
A disinnescare, però, una frettolosa identificazione del libro nel genere del romanzo storico, il narratore ricorre spesso a formule come “si dice”, “si racconta”, “si narra”, che contrastano con la suddetta tendenza a fornire date esatte e attestano invece la latente labilità del contesto documentale (e, in seconda istanza, l’ironico distacco dell’autore dalla materia da lui inventata).
Comunque sia, l’impeccabile ricostruzione di giorni, mesi e anni viene delegata dall’autore alla figura del narratore; costui (la cui identità viene rivelata alla fine del romanzo, con un abile colpo di scena) è scrupolosissimo: consulta (anche lui!) documenti, ricerca testimoni e testimonianze sulla vita di Jacu, indaga su fatti antichi con una curiosità e una dedizione encomiabili.
Vanno però considerate le conseguenze della scelta di un tale tipo di approccio narrativo. Il narratore è “esterno” a Jacu, ne ricostruisce le vicende attraverso occhi e orecchie degli altri, ne apprende e ne commenta le mitiche manifestazioni taumaturgiche, ne immagina sentimenti e passioni, ne ipotizza le motivazioni. Più che “narrare”, “ricostruisce”, ricompone un complicato puzzle, fra depistaggi, imprecisioni, ipotesi e faticose ricerche di una verità quanto mai sfuggente.
Ma questa indagine è, per l’appunto, “esterna”: l’interiorità di Jacu, personaggio molto più complesso di quanto possa sembrare a prima vista, resta per molti versi insondata e insondabile.
Jacu non è, si badi bene, un “remake” dello “Jeli il pastore” verghiano, un “primitivo” che attinge dal contatto simbiotico con la natura la sua ragione di vita. Al contrario, il settimino consegue nel tempo una profonda cultura, partendo dall’interesse per gli stralci dei “Beati Paoli” di Natoli (p. 31), passando per gli studi alla scuola parrocchiale (p. 34), arrivando a imparare il latino e il greco (p. 53) e finendo per approfondire le sue letture presso la Biblioteca Lucchesiana di Girgenti nelle pause della sua attività di postino, passandovi – come sua madre riferisce al narratore – «ore e ore a leggere libri scritti da gente morta da secoli» (p. 50).
Jacu è dunque persona colta, sensibile, ma condannata (anche per questo? proprio per questo?) alla solitudine e all’incomprensione generale; e il fatto di essere sempre “narrato” da fuori, di essere “oggetto” e non soggetto di questa narrazione, ne rende i connotati più misteriosi e sfuggenti.
Di lui dobbiamo dunque cogliere e intuire e collezionare via via, in questa prospettiva “esterna”, in questa inquadratura “in piano americano”, pensieri e sentimenti: dallo stato di «torpore innaturale» (p. 48) che lo coglie quando opera i suoi miracoli taumaturgici, al difficile rapporto con i compaesani e in particolare con i coetanei («tutti i ragazzini, senza che si fossero messi d’accordo tra loro, cambiarono posto allontanandosi da lui come da un appestato», p. 29); dalla sua tenacia e dalla «prepotente curiosità» (p. 34) nel desiderare un’istruzione («Jacu spiò con un’insistenza ossessiva le lezioni che si svolgevano puntuali dalle due alle sei del pomeriggio», p. 32) all’«ostinata determinazione» (p. 49) con cui intraprende il suo lavoro di postino.
Ma la vicenda di Jacu subisce una svolta in concomitanza con lo scoppio della prima guerra mondiale: qui gli eventi della storia, come già nei “Malavoglia” verghiani, vengono a scardinare il ciclo ripetitivo della vita di Scurovalle. Infatti il 29 settembre 1916 due carabinieri giungono in paese e consegnano ai ragazzi del ’99 la cartolina di precetto.
Quando si sparge la voce che Jacu non è stato arruolato, fra i compaesani sorgono diffidenza e rancore verso il settimino: e anche se l’equivoco dipende da un banale errore dell’anagrafe il paese si rivolta contro il ragazzo e a nulla valgono i suoi tentativi di riconquistare la fiducia degli altri.
Dopo aver subìto anche una denuncia per abuso della credulità popolare e un breve periodo di detenzione, Jacu decide di arruolarsi volontario; al fronte, però, il suo scopo prioritario sarà quello di rintracciare i suoi compaesani e di guarirli eventualmente dalle ferite riportate.
Il racconto diventa ora un impietoso bollettino di guerra (tanto più triste e devastante in giorni come questi che stiamo vivendo); si fa cupo e drammatico, presenta allucinanti scenari di morte e distruzione descritti nei particolari più “disturbanti”.
Le mutilazioni orrende dei corpi dei soldati, le terribili impari battaglie, la descrizione della fine atroce di molti giovani creano un clima “cinematografico”, che ricorda “Uomini contro” di Francesco Rosi (1970) o “Salvate il soldato Ryan” di Steven Spielberg (1998). Non ci si meraviglia di trovare questo taglio “cinematografico” in uno sceneggiatore del calibro e della sensibilità di Paolo; si aggiungono però una sottile e implicita indignazione, una pietà umana e un mesto pathos che ispirano pagine di rara bellezza narrativa. Si può dire che alcune di queste pagine sulla guerra mondiale raggiungano l’efficacia evocativa di un Rigoni Stern, con note altrettanto cupe e dolenti. La dissacrazione del mito della “Grande guerra”, dai sogni del “maggio radioso” alle stragi sulle trincee del Carso, non potrebbe essere più struggente ed efficace.
La fase conclusiva, che lasciamo alla piacevole scoperta dei lettori, consacra Jacu in una dimensione sempre più ideale, consegnandolo in qualche modo al mito e alla leggenda.
“Jacu” inevitabilmente, per la sua ambientazione e per la storia che racconta, propone il tema della Sicilia, un tema con cui ogni autore nato in quest’isola deve confrontarsi. Come spiega Paolo nella citata intervista, in lui era forte la «voglia di raccontare di una Sicilia arcaica dai profumi e dai sapori di una volta, cercando al contempo di dipingere un panorama storico che fosse il più fedele possibile al periodo in cui la vicenda ha inizio, cioè dalla fine dell’Ottocento fino agli anni ’40 del secolo successivo».
Ebbene, la descrizione di questa “Sicilia arcaica” resta un po’ “vittoriniana”; gli strumenti per ottenere questo effetto straniante sono diversi: mancano in genere i discorsi diretti fra i personaggi (viene così ingegnosamente evitato l’insormontabile problema di “come farli parlare”: in dialetto? in italiano del primo Novecento? in un mix attualizzato?), mancano i termini dialettali (con una doppia eccezione per gli “ainuzzi” di formaggio del Corpus Domini di Cammarata, p. 50), manca un esplicito riferimento alle vicende siciliane prima e dopo la guerra mondiale (anche qui con la fugace eccezione della citazione, nelle pagine conclusive, di «un’orda d’impetuosi viaggiatori in camicia nera mossi da una rozza agitazione», p. 148). E tuttavia l’ambientazione siciliana è forte, radicata, ben percepibile e riscontrabile nell’impietosa caratterizzazione degli abitanti di Scurovalle, nel contesto ripetitivo e asfittico della vita paesana, nell’alterigia della baronessa madre, nelle frecciate al dominio ossessivo della Chiesa («per la sua sopravvivenza la Chiesa deve sempre reagire alla devozione privata», p. 48), nella denuncia dello stato di arretratezza e ignoranza in cui sono tenuti gli abitanti dell’isola in quella fase aurorale del Novecento.
Insomma, fin dal titolo (che “sicilianizza” il nome di Giacomo), in queste 149 pagine si respira Sicilia; e ne sarebbe stato ben lieto Nonno Peppinieddu, che di questa isola è stato una voce poetica significativa.
La scrittura di Paolo non è mai banale e a livello espressivo conosce l’uso di termini accuratamente ricercati. Quando ad es. descrive la morte di Giacomo, omonimo padre del protagonista, afferma che era deceduto improvvisamente, «come una marionetta cui hanno tagliato i refi» (cioè i fili di canapa, p. 12). Non meno insoliti sono vocaboli come “masaro” (con una sola “s”, p. 23), “ghirba” (la “pelle” da salvare, nel gergo militare, p. 96), “giulebbe” (bevanda di succo di frutta bollita con zucchero, p. 76), “encolpio” (la teca che custodisce le reliquie, p. 13), “benandante” (termine associato a un culto pagano-sciamanico contadino basato sulla fertilità della terra, p. 14), “berciare” (“strillare a squarciagola”, p. 128), “esuvia” (la spoglia del serpente staccatasi dopo la muta, p. 82), ecc.
Tutto ciò denota una cura espressiva non comune, una tensione in direzione di una scrittura mai frettolosa e compilatoria. Si vede che il libro non è stato scritto di getto, che c’è una grande accuratezza creativa ed espressiva in ogni sua riga; e questo è un elemento importante, che fa onore al suo autore, soprattutto in un’epoca in cui la cura formale, la qualità dell’espressione, la punteggiatura, la sintassi (e anche l’ortografia) sono per molti diventati soltanto degli “optional” indigeribili.
Paolo, nell’intervista già ricordata, chiarisce il “messaggio trasversale alle epoche” che viene fuori dalla sua opera: «Direi che il messaggio che al meglio sintetizza il senso più profondo della storia è che anche nelle più grandi tragedie, nei momenti più bui della vita, c’è un inesauribile senso di speranza».
Questo messaggio, fondamentalmente positivo, risulta importante e quanto mai condivisibile in un’epoca come la nostra, nella quale ai timori della pandemia si associano tenacemente e purtroppo concretamente le paure di nuovi conflitti e la lotta costante contro le ingiustizie della civiltà contemporanea.
E ci vorrebbe davvero, per tutti noi, un taumaturgo come Jacu, discreto, colto, inquieto, sensibile, critico e autocritico, che ci indicasse la strada e ci “guarisse” dagli innumerevoli mali del nostro tempo.