Del piccolo poemetto didascalico di Ovidio intitolato “Medicamina faciei femineae” (“I cosmetici delle donne”) ci sono arrivati soltanto cento versi in metro elegiaco. Anche in questa operetta, composta forse parallelamente all’Ars amatoria nei primi anni del I sec. d.C., il poeta di Sulmona riusciva a distinguersi dai suoi predecessori e a presentare un approccio alla materia anticonformista e a tratti “eversivo”.
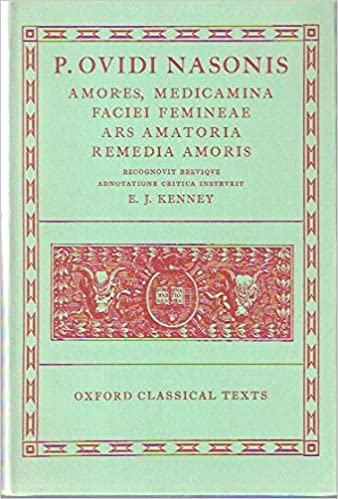
Il poemetto viene annunciato alle donne nel III libro dell’“Ars”: «Io ho un libretto nel quale ho esposto le correzioni della vostra bellezza; piccolo, ma lavoro grandioso per la diligenza» (III 205-206, tr. Maccari).
L’intento didascalico del parvus libellus è evidente fin dalla prima parola (“discĭte” = “imparate”), indirizzata alle puellae che intendano rendersi più belle e mantenere poi questa bellezza: «Imparate, o donne, quali cure abbelliscano il volto, e in quale modo preservare la vostra bellezza» (vv. 1-2; per il poemetto utilizzo qui la traduzione di Gianpiero Rosati).
Va detto preliminarmente che l’uso dei cosmetici nell’antichità aveva dovuto sempre affrontare ostacoli e pregiudizi, subendo anatemi da parte di moralisti, che vedevano nella cosmesi una pratica “immorale”.
La stessa provenienza orientale di molte pratiche cosmetiche (trucchi, pomate, unguenti e preparati di vario tipo) costituiva un’etichetta intollerabile di lussuria e corruzione; già i Greci avevano preso le distanze da esse, come dimostra ad esempio un passo dell’“Economico” di Senofonte, nel quale Iscomaco racconta un suo diverbio con la moglie, «che era tutta imbellettata con molto cerone per sembrare ancora più bianca di quanto non fosse, e anche con molta cipria per apparire più rosea di quanto non fosse, e che portava delle scarpe alte per sembrare più alta del naturale» (X 2, tr. Roscalla).
Le donne dell’antica Grecia, destinate a passare gran parte della loro esistenza in casa, secondo i canoni estetici del tempo non dovevano essere abbronzate; il pallore e la bianchezza del viso erano esaltati come prova di una vita moralmente ineccepibile.
La donna “truccata” era considerata un’ingannatrice (del resto un “trucco” comporta un inganno!) e una millantatrice, se non addirittura una potenziale seduttrice depravata, assimilandola di fatto a una “etéra”, cioè una prostituta di alto bordo.
Non a caso nelle commedie latine di Plauto e Terenzio sono spesso descritte delle cortigiane pesantemente truccate nel tentativo di spillare quattrini ai loro amanti occasionali; e non a caso il filosofo Seneca ritiene che la cosmesi sia frutto dell’eccessiva prosperità, che ha ribaltato le sane consuetudini dell’antica civiltà contadina: «Quando la prosperità ha diffuso ovunque abitudini licenziose, si comincia col dedicare maggiori cure alla persona» (Epistulae ad Lucilium 114, 9, tr. Monti).
Anche i poeti elegiaci latini avevano confermato l’avversione tradizionale verso i cosmetici femminili, ritenuti prova di una degradazione morale intollerabile. Sono celebri i versi con cui Properzio deplora il pesante trucco che deturpa la splendida bellezza della sua Cinzia: «A che ti serve, mia vita, incedere a suo parere con adorne chiome / e agitare in delicate pieghe una veste che viene da Cos, / a che ti serve inondare i capelli di profumi siriaci, / metterti in mostra con finezze esotiche, / e offuscare la tua schietta bellezza, con ornamenti comprati, / senza lasciare che le tue membra splendano della loro grazia? / La tua figura, credimi, non abbisogna di artifici: / Amore, che è nudo, non ama chi troppo ritocca il suo aspetto (“nudus Amor formae non amat artificem”)» (I 2, vv. 1-8, tr. Gazich).
Non meno intollerabile sembrerà a Properzio un altro voluttuoso capriccio di Cinzia, che si tinge i capelli e si fa bionda come i Britanni: «La bellezza perfetta è quella naturale: / non sta bene a una testa romana questo colore belgico» (II 18b, 25-26, tr. Gazich)
Il fatto è che il make-up della donna “truccata” evocava sempre l’immagine negativa della “seduttrice” e della “ingannatrice”; sarà questa anche l’opinione del grande medico Galeno di Pergamo (II sec. d.C.) che distinguerà una cosmetica “accettabile” (con funzione conservativa della bellezza naturale) e una cosmetica “cattiva” in quanto innaturale e contraffatta.
In questo contesto “negativo” verso la cosmesi si comprende meglio come il poemetto di Ovidio risultasse controcorrente: il Sulmonese infatti, contrariamente a tanti suoi predecessori, giudica negativamente la natura e ritiene che essa debba essere “aiutata” con l’intervento umano; tale è per lui il cultus, il “prendersi cura” delle cose migliorandole. Grazie al cultus sono state inventate le arti, si è resa fertile la terra (attraverso, appunto, la “coltivazione”), si è creato il progresso dall’originario stadio ferino; e al suo tempo, nella “aurea” Roma («nunc aurea Roma est», Ars amatoria III 113), la simplicitas rudis (“rozza semplicità”) dei tempi arcaici appare intollerabile e ridicola.
Del resto, il poeta allontana dalla cosmesi l’accusa di immoralità: le donne si fanno belle non per sedurre gli altri, ma anzitutto per piacere a se stesse: «anche piacere soltanto a se stessi è una gioia; alle giovani donne sta a cuore ed è cara la loro bellezza» (Medicamina faciei 31-32).
Il desiderio di bellezza delle donne risponde dunque, per Ovidio, a un bisogno innato e “naturale”, indipendente da una volontà seduttiva e dunque pienamente legittima. In questa ottica, il maquillage diventa una delle tante pratiche “artificiali” che migliorano e arricchiscono la natura, nascondendone i difetti ed esaltandone i pregi nascosti. In tal senso, è significativo il paragone con il pavone: «Il pavone, caro a Giunone, dispiega le penne ammirate dall’uomo e inorgoglisce, nel suo silenzio, per la propria bellezza» (vv. 33-34).
Ovidio ridicolizza l’antico modello moralistico costituito dalle “matrone” sabine o da eroine come Andromaca e Tecmessa, mostrandosi ben lieto di vivere nella sua epoca, smaliziata e vivace: “Le cose antiche piacciano agli altri: io mi compiaccio di essere nato ora; questa epoca è adatta ai miei costumi” (“Prisca iuvent alios: ego me nunc denique natum / gratulor; haec aetas moribus apta meis”, Ars amatoria III 121-122).
E tuttavia (con una certa dose di prudenza e per motivi di opportunità) Ovidio chiude il lungo proemio del poemetto con un invito, rivolto alle donne, alla morum tutela, “la tutela dei costumi”: se la loro indole sarà sana e pura, allora piacerà anche il loro aspetto; infatti «l’amore per il carattere è sicuro, la bellezza la devasteranno gli anni, e il volto un tempo attraente sarà solcato dalle rughe» (Medicamina faciei, 45-46).
Il poeta, evidentemente, si preoccupa di rassicurare i suoi lettori, di non scandalizzarli troppo con la sua moderna sconfessione degli antichi costumi: «con il richiamo finale alla probitas, ponendola a fondamento della relazione d’amore, Ovidio mira a mostrare l’assimilabilità del cultus, delle pratiche cosmetiche, nella vita sociale senza guasti per il sistema etico tradizionale. La cosmesi riceve cioè la sua definitiva legittimazione da una condizione irrinunciabile, quella dell’onestà in amore» (Rosati).

La seconda parte del poemetto (vv. 53-100) contiene la descrizione di alcune ricette cosmetiche, miranti in particolare a ridare bellezza al viso femminile dopo il risveglio mattutino; ed è sorprendente leggere gli “ingredienti” destinati a produrre tali cosmetici: l’orzo usato come antiinfiammatorio, fave e ceci come emollienti, uova e miele come amalgamanti, ma anche finocchi, mirra, incenso, petali secchi di rosa, fiori di papavero macerati, resine vegetali, bulbi di narciso, lupini giallastri, gomma, ecc.
Ci sono persino le istruzioni per realizzare una “maschera facciale”: «Si è rivelato anche utile aggiungere finocchi alla mirra profumata […] e tanti petali secchi di rosa quanti ne può contenere una mano, e incenso maschio insieme a sale di Ammone. Vèrsaci sopra la mucillagine prodotta dall’orzo: incenso e sale pesino quanto le rose. Anche se rimarranno spalmati sul viso delicato per poco tempo, non resterà in tutto il volto alcuna macchia» (vv. 91-98).
Certo, leggendo questo mix di ingredienti (mucillagine inclusa), si può facilmente supporre che le “maschere facciali” delle “puellae” latine non avessero niente da invidiare, come risultato orrorifico, a quelle odierne, che spesso ottengono l’effetto di far scappare i partner terrorizzati a gambe levate…
P.S.: per un’ottima edizione commentata del poemetto ovidiano, cfr. I cosmetici delle donne a cura di Gianpiero Rosati, Marsilio editori, Venezia 1985.
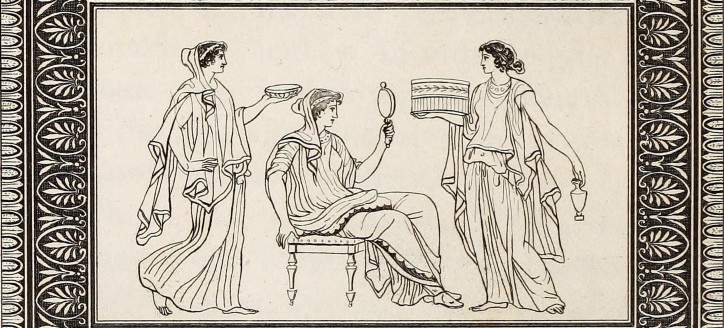
Caro Prof., quando la leggo , mi si apre un mondo ricco, infarcito di passato sempre attuale, classico. Passerei ore a immergermi in queste letture, a cercare, a scoprire per capire la realtà, che però, ci presenta ogni giorno il conto da pagare …. ed ecco che spariscono in un baleno tutti i miei sogni e desideri.