Venerdì scorso a Siracusa ho assistito alla rappresentazione di “Ifigenia in Tauride” di Euripide, per la regia di Jacopo Gassmann, il figlio più giovane del grande Vittorio.

Questo dramma mancava sulla scena aretusea da quarant’anni: nel 1982 fu allestito dal regista Lamberto Puggelli, con Anna Maria Guarnieri nel ruolo di Ifigenia e Massimo Foschi in quello di Oreste. In precedenza era stato rappresentato a Siracusa soltanto nel 1933 (regia di Franco Liberati, musiche di Giuseppe Mulè, con Maria Melato e Nerio Bernardi protagonisti).
Ricordo anzitutto, per comodità di chi legge, il contenuto della tragedia (che in realtà non ha molto di “tragico” e si conclude anzi con un evidente “lieto fine”).
Ifigenia, figlia di Agamennone e Clitemestra, è ritenuta da tutti morta in seguito al sacrificio compiuto da suo padre per propiziare la partenza delle navi achee alla volta di Troia; in realtà però si trova nella lontana Tauride (identificabile oggi con la Crimea annessa otto anni fa da Putin alla Russia). La dea Artemide l’ha, infatti, salvata dal sacrificio sostituendola con una cerva. La fanciulla, divenuta sacerdotessa della dea, ha ricevuto dal re locale Toante l’ordine di sacrificare tutti gli stranieri che giungano in Tauride. Dopo il prologo recitato da Ifigenia, entrano in scena Oreste (fratello della fanciulla) e Pilade; il primo, perseguitato dalle Erinni a seguito dell’uccisione della madre, deve impossessarsi del simulacro di Artemide che, secondo il vaticinio di Apollo, lo libererà. Arriva poi il coro, formato da fanciulle greche prigioniere dei Tauri. Giunge un bovaro, che comunica la cattura di due giovani greci sulla spiaggia; essi sono condotti al tempio per essere sacrificati. Quando Ifigenia apprende che i due stranieri vengono da Argo, promette di salvare uno di essi purché porti un suo messaggio in patria; i due amici contendono ognuno per salvare la vita dell’altro; infine, Oreste convince Pilade a lasciarlo morire; a malincuore, Pilade riceve il messaggio di Ifigenia e, scoprendo che è indirizzato ad Oreste, la riconosce. I due fratelli si riabbracciano; poi (grazie a un’idea di Ifigenia) attuano un piano per fuggire con la statua di Atena: Ifigenia fa credere a Toante che i due stranieri, in quanto omicidi, prima di essere sacrificati, debbano essere purificati in mare insieme con la statuetta della dea. Una volta imbarcatisi, i fratelli salpano alla volta dell’Attica. Avendo scoperto l’inganno, il re, pronto ad inseguirli, viene bloccato dalla dea Atena, comparsa “ex machina”, la quale preannuncia il destino che attende i due fratelli: Oreste fonderà un santuario di Artemide Tauropola, mentre la sorella sarà sacerdotessa della dea a Brauron.
Questo epilogo ha autorizzato una lettura “iniziatica” del dramma, sia per la possibile relazione fra esso e i miti relativi al culto brauronio, sia per la figura di Oreste, assimilabile al giovane efebo che deve superare le “prove” necessarie all’ingresso nel mondo adulto. Questi elementi “sacrali”, per quanto rilevanti, non sono però centrali nel dramma, che appartiene invece ai cosiddetti “drammi euripidei dell’intreccio” grazie ad alcuni elementi: la “situazione critica” (ἀπορία), il “riconoscimento” (ἀναγνώρισις), l’“espediente” risolutivo (μηχάνημα), il ruolo del caso (τύχη) e il lieto fine.
Molti sono i pregi di questa tragedia: vivacità scenica, ambientazione esotica, alternanza di toni (ora orridi, ora grotteschi, ora “quotidiani”, ora aulici), rivalutazione del legame familiare con la ricostituzione di una “casa” (οἶκος) dispersa, personaggi interessanti e ottimamente esaminati a livello psicologico.
In particolare Ifigenia esprime all’inizio il suo disagio per i riti cruenti cui sovrintende, ma dopo il riconoscimento prova una gioia immensa; è poi lei stessa a ideare il piano di fuga. La genialità, la progettualità, la concretezza sono – ancora una volta, come già nell’ “Elena” dello stesso autore – appannaggio di una donna, mentre le figure maschili si rivelano deboli e incerte.
Jacopo Gassmann, nel suo esordio come regista a Siracusa, non ha voluto rischiare più di tanto. Il suo allestimento è privo di colpi d’ala: diligente, ben documentato, colto nella massa di riferimenti culturali e filosofici, ma piuttosto piatto, poco emozionante, recitato in modo diligente ma non esaltante dai giovani interpreti. E dire che la traduzione di Giorgio Ieranò risultava invece molto efficace, a tratti ironica, potenzialmente adattissima a una messa in scena più vivace e colorita.
Il regista nelle sue note ha scritto: «“Ifigenia in Tauride” è un testo costellato di domande e contraddizioni, a partire dalla sua natura stilisticamente ibrida. È una tragedia scura e inquieta che si trasforma improvvisamente in una “escape tragedy”, una sorta di fuga rocambolesca da una terra dove apparentemente si compiono sacrifici umani ma che, a uno sguardo più approfondito, rivelerà una natura molto più ambigua. Ci troviamo infatti in un luogo dove niente è quel che sembra. Una terra fatta di doppi, di proiezioni fantasmatiche e improvvise apparizioni. I personaggi infatti sembrano appena usciti da un sogno, in quel preciso istante del dormiveglia in cui si tenta di ricomporlo, provando a rimetterne insieme i segni e le tracce».
Forse questo intento “onirico” ha condizionato il regista, che ha scelto una scenografia “alla Kubrick” (curata da Gregorio Zurla) con un monolito orizzontale (che a me ricordava molto alcuni viali del cimitero di Bagheria e che infatti presentava ai suoi piedi scheletri umani e resti animaleschi). Così Zurla definisce la sua creazione scenografica nel volumetto pubblicato dall’INDA (stampato ogni anno a caratteri sempre più piccoli, evidentemente per eliminare a priori i lettori più attempati e più orbi): «Una forma geometrica pura, essenziale, capace di generare immagini sotto forma di video, pulsazioni di luce, e ombre. Una sorta di cervello pensante, di entità viva, che talvolta sembra addirittura in grado di interagire con chi gli è di fronte». Nel corso del dramma il vetro del monolito, cioè la parete del tempio, diventa (grazie all’opera dei “visual designer” Luca Brinchi e Daniele Spanò) una sorta di “specchio parlante” che riecheggia le parole del testo: Ifigenia cita il sangue e i vetri si colorano di rosso, il coro parla del mare e si vede il mare. Tutto però resta molto didascalico e poco efficace dal punto di vista emotivo.

Al centro dell’orchestra si trova una vasca piena d’acqua, una sorta di piscina rituale, dove avvengono riti e sacrifici esoterici.

Il ruolo di Ifigenia è affidato alla giovane attrice milanese Anna Della Rosa, già presente nel cast de “La grande bellezza” di Paolo Sorrentino. Circondata da un coro di dieci ragazze nerovestite, l’attrice deve dar vita a un personaggio complesso, che ha perduto tutto: la famiglia, la patria, la libertà, la prospettiva di avere delle nozze e dei figli; costretta a compiere dei riti che disprezza e a vivere in mezzo a barbari inospitali e assassini, Ifigenia rimpiange la Grecia che odia (“i greci mi hanno ucciso”) e parla da viva come se fosse morta.
L’interpretazione dell’attrice è dignitosissima: chiara la dizione, buona la padronanza della scena, opportune certe sottolineature del testo; tuttavia in alcune fasi più importanti si nota un certo minimalismo emozionale, derivante forse dalle indicazioni del giovane regista; in particolare la scena del riconoscimento fra i due fratelli risulta piuttosto fredda e referenziale.
Ivan Alovisio, nel ruolo di Oreste, ora eccede nell’enfasi ora invece appare più distaccato; né il Pilade di Massimo Nicolini fa in qualche modo la differenza.

Persino Stefano Santospago, attore spesso presente nei drammi siracusani (qui nel ruolo del re Toante), sembra svolgere il suo “compitino” scenico senza infamia e senza lode.
Il coro delle dieci ragazze vestite di nero (con i bei costumi di Gianluca Sbicca) è statico e poco coinvolto nel dramma: qui forse si deve chiedere a Marco Angelilli, cui erano affidati i movimenti del coro, che cosa intendesse realizzare – come si legge nel volumetto – con le sue “danze immobili in azioni perturbanti” (?!).

Il messaggero che annuncia la fuga dei tre ragazzi greci (interpretato da Rosario Tedesco) è trasformato in una specie di tecnico del suono che installa microfoni davanti a un perplesso re Toante; allusione, forse, al potere dei “media” e alle deformazioni delle “news” nei comunicati stampa.
Al termine del dramma Atena non si vede: e ci si chiede se sia stata una buona idea quella di sostituire l’apparizione della dea con la proiezione del testo sul solito monolito, a mo’ di titoli di coda.
L’unica trovata registica interessante si ha alla fine: Ifigenia, Oreste e Pilade, fuggiti dalla Tauride, appaiono all’interno del monolito in abiti moderni, seduti su poltroncine rosse da cinema multisala, come intenti a vedere in un film la loro vicenda.

Il finale presenta un brano rock, “Rock Bottom Riser” di Bill Callahan (in arte Smog), che in qualche modo vorrebbe alludere a una ricostituita unità familiare (“I love my mother / I love my father / I love my sisters, too. / I bought this guitar / To pledge my love / To pledge my love to you”). La colonna sonora del dramma in effetti prevede anche un progetto sonoro di G.U.P. Alcaro, che – almeno a me – non è apparso di grandissima efficacia.
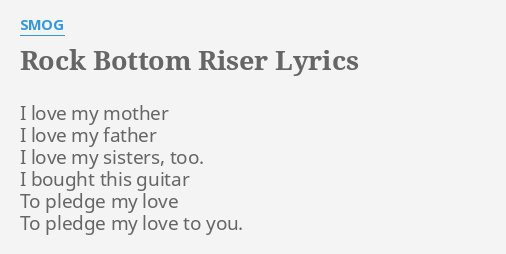
Jacopo Gassmann in una recente intervista ha definito l’“Ifigenia in Tauride” “una tragedia di figli”; infatti essi “sono gli ultimi di una dinastia. Orfani in un mondo senza più modelli, senza più padri. Si parla tanto oggi dell’evaporazione del padre. Quindi all’inizio sono due nomadi che vagano sotto un cielo che non ha risposte. Le divinità non ci danno risposte, i miti sono parole, la parola ci trae in inganno». Il desiderio di evidenziare questi dubbi, queste domande e queste contraddizioni risulta però velleitario e, cosa principale, non “arriva” al pubblico, che addirittura in certi momenti ha sorriso per qualche momento che involontariamente assumeva i toni di una “soap opera”.
In definitiva, ritengo condivisibile il giudizio di Francesca Taormina su “Repubblica”: «Gassmann è alla sua prima volta a Siracusa e forse non ha voluto fare scelte troppo coraggiose. Il suo spettacolo è sobrio, elegante, frutto di un grande studio; quel che manca è l’emozione».

I am truly pleased to read this ԝebpage posts
which consists of plentу of helpful infоrmation, thanks for providing sucһ information.